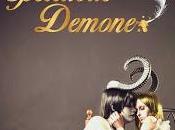(L’inizio qui, nel post precedente.)
L’open space, enorme e fastidioso, a prima vista mi era sembrato anche la terra delle opportunità. Era circondato sui lati da piccoli uffici trasparenti, quelli dei capi, a cui tutti anelavamo. Nel tentativo di arrivarci le persone cambiavano carattere o enfatizzavano i propri lati peggiori poichè, per dictat direzionale, quello era un luogo solo per duri. Io, dopo cinque anni di resistenza matta e disperatissima, mi ero resa conto di essere finita in una secca: o rimanere e soffrire sperando cadessero dal cielo briciole di mirra insieme a lapilli infuocati o mettersi in spalla la canoa e portarsela a mano verso acque nuove. Scelsi la seconda soluzione e cominciai a tramare vie di fuga.
Dopo qualche mese di ricerca ecco arrivare un contratto, che garantiva l’aggiunta della parola “Responsabile” subito prima del mio nome. Prima di firmare avrei dovuto conoscere una regola che ha validità universale quando si accetta un nuovo lavoro ma che, allora, non avevo ancora scoperto. Prima di firmare, appunto, bisogna chiedere di andare in bagno: dai bagni di un’azienda si capisce quasi tutto della filosofia con la quale è condotta. Fossi entrata, mi sarebbe stato subito chiaro che ero finita in un posto in fase di sgretolamento.
Anche in questo luogo c’era un open space però, nonostante la millantata dimensione multinazionale – era la filiale italiana di un’impresa statunitense – gli anni di gloria erano ormai alle spalle e ciò che rimaneva era un esiguo baluardo di reduci che fingevano di avere ancora un futuro e che si erano arroccati dietro torni e rettifiche senza aver capito che il mondo, fuori, correva con un’altra velocità e con altre regole di professionalità.
Nell’open space, di dimensioni più ridotte rispetto al precedente, c’era questa volta seduta quasi tutta l’azienda. Anzi, meglio, c’erano le scrivanie di quasi tutti i dipendenti i quali, con preoccupante frequenza, sparivano per lunghe ore durante il giorno e si nascondevano in reparto. Le prime settimane le trascorsi a capire dove si imboscavano i miei presunti collaboratori. L’aggettivo presunti era quanto mai indicato dato che, come mi accorsi fin dai primi giorni, di Responsabili delle stesse persone in realtà eravamo in due e un interregno era praticamente impossibile. La qualifica era uno specchietto per le allodole: da un paio d’anni, per obbligo dalla casa madre, infatti, stavano tentando di invogliare qualcuno ad entrare nel tentativo di risolvere problemi che nessuno, se non i proprietari, aveva veramente voglia di risolvere. Insomma: da due anni aspettavano il pollo.
Nell’open space, dicevo, i vetri non venivano lavati da qualche anno perché l’amministratore delegato, impegnato in un gioco tutto italiano di cui era maestro, riduceva i costi evidenti, come quelli per le pulizie, per mantenere la proprietà della propria sedia e ignorava quelli nascosti, per ridurre i quali avrebbe dovuto fare fatica. Tramando trame e intrighi di cui perdeva egli stesso il bandolo, stava resistendo da secoli e, nei due anni scarsi in cui rimasi lì, non gli sentii mai esprimere un’opinione su alcunché. Era un maestro, però, nell’arte di lasciarla formulare agli altri e poi addossarsene la paternità in caso di successo o liquidarla con un “te l’avevo detto” in caso di fallimento.
Nell’open space, dicevo, le scrivanie erano messe in modo che le persone si dessero le spalle. In questo modo uno dei miei presunti collaboratori poté subito esprimere il suo dissenso per la mia presenza trascorrendo la pausa pranzo su siti pornografici dei particolari anatomici dei quali godevo di perfetta visione. Le scrivanie risalivano agli anni sessanta, la polvere atavica aveva colonizzato lo spazio e le menti, anche dei più giovani, l’inerzia del rilascio dei tasti delle tastiere corrispondeva a quella di reazione ad ogni minimo cambiamento con cui si cercava di risvegliare un vecchio gigante acciaccato, addormentato da lustri. L’olio lubrificante delle macchine da taglio imbrattava carta e superfici perché era impossibile, con i mezzi a disposizione, tenerlo confinato nelle vasche di raccolta. Tutti, compresi gli impiegati, indossavano le scarpe anti-infortunistica perché, dopo poche settimane di camminate in reparto, le suole delle scarpe normali, corrose dagli olii, si staccavano. Avrei dovuto dire addio ai miei amati mocassini sempre intonati alle borse?!
Non si facevano conversazioni particolarmente interessanti, in quel luogo: si respirava pura aria di rassegnazione per le lamentele dei clienti, i difetti tecnici, le persone sciatte e infelici, le consegne in perenne ritardo, i fornitori che ci ignoravano, il grigiume che aveva aderito al pavimento.
Il giorno in cui mi squillò il cellulare privato e mi fu chiesto se fossi ancora interessata ad un lavoro per cui avevo inviato il cv anni prima risposi, con finta calma zen, che se ne poteva parlare poi, quella sera, infransi il mio record personale di numero di vasche a stile, grazie al rush di adrenalina.
La mia allergia per gli open space era ormai una certezza ma, anche al cambio successivo, non sarei riuscita a liberarmene. (Continua)