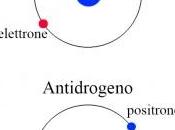Veri e propri fossili ci raccontano i primi vagiti della Via Lattea
di Francesco Scotti


La nebulosa del Granchio, prodotta dalla supernova SN 1054, dimostra come avviene lo spargimento di materia dopo l'esplosione di una gigante rossa. (Cortesia: NASA)
L’evoluzione stellare prevede diverse fasi. Anzitutto una stella nasce quando in una nube interstellare si verifica uno squilibrio che porta la materia, costituita principalmente di idrogeno, elio e una piccola quantità di elementi più pesanti, a concentrarsi a causa dell’interazione gravitazionale. Col passare del tempo, la temperatura e la densità aumentano, fino a innescare il processo di fusione nucleare, grazie al quale gli atomi di idrogeno sono fusi a formare atomi di elio, di maggiore peso atomico. Le stelle in questa fase entrano nella Sequenza Principale, che riguarda la maggior parte della vita di una stella e la cui durata dipende sia dalla quantità di combustibile presente sia dalla rapidità dei processi termonucleari. La fusione dell’idrogeno continua, andando ad aumentare sempre di più l’elio presente. Quando la quantità di idrogeno nel nucleo diminuisce al di sotto di una soglia critica, le stelle di massa superiore a 0,4 masse solari si espandono in giganti rosse, nelle quali la fusione coinvolge l’idrogeno all’esterno del nucleo di elio, prima di ridurre le proprie dimensioni e cominciare a utilizzare l’elio come combustibile. Quando anche l’elio diminuisce oltre un certo limite, nel nucleo delle stelle di massa molto grande (oltre le 2,25 masse solari) comincia la produzione di carbonio, neon, ossigeno ed elementi sempre più pesanti, fino (se la massa della stella lo consente) al ferro. I nuclei di ferro hanno un’energia di legame più elevata rispetto sia agli elementi più pesanti sia a quelli meno pesanti, e di conseguenza la loro fusione non rilascerebbe energia. A questo punto si ha una sfera composta da strati di elementi sempre più pesanti, dall’esterno verso l’interno. Quando la massa della gigante rossa diventa tale da non potersi più sostenere autonomamente, si innesca l’improvviso collasso, che produce un’esplosione chiamata supernova. Questo fenomeno è responsabile dello spargimento nello spazio circostante sia della materia che costituiva la stella defunta sia di quella prodotta nell’esplosione stessa. Questa materia potrà successivamente riutilizzata, tra le altre cose, nella nascita di nuove stelle. Va da sé che, col ripetersi del ciclo, le nuove stelle si arricchiranno sempre di più di elementi di peso atomico maggiore.

Come un cipolla: così si presenta una gigante rossa prima del collasso del nucleo. (Cortesia: R. J. Hall)
E ora torniamo sulla Terra. Il team di ricerca di astrofisica e planetologia dell’Istituto Niels Bohr, di cui Terese Hansen fa parte, da diversi anni tiene sotto osservazione 17 stelle della periferia della Via Lattea. Il motivo? Su queste stelle sono stati rilevati elementi che lì non dovrebbero affatto esistere, perlomeno non nelle quantità osservate: oro, platino, uranio, che normalmente si trovano solo nelle stelle più giovani, cioè che hanno alle spalle molti cicli come quello descritto sopra. Questa volta però sono stati riscontrati in grandi quantità su quelle 17 stelle che hanno attirato l’attenzione degli studiosi perché ebbero origine già nelle primissime fasi di vita della nostra galassia. Insomma dei veri e propri fossili dell’universo con una caratteristica che dovrebbe essere presente solo nelle stelle più recenti.
Nel suo lavoro di ricerca, pubblicato su “The Astrophysical Journal Letters”, Hansen spiega che esiste una teoria secondo la quale queste stelle anomale facevano parte di sistemi binari in cui una delle due componenti, esplodendo, avrebbe ricoperto la gemella di elementi pesanti. Tuttavia l’astrofisica propende per un’altra spiegazione dopo aver rilevato che, delle 17 stelle osservate, solo tre in realtà appartengono a sistemi binari. Secondo la sua ipotesi, nelle prime fasi di vita della galassia alcune supernovae produssero e dispersero nello spazio elementi come l’oro o il platino. Questi ultimi sarebbero poi entrati in contatto le con nubi gassose circostanti, le quali a loro volta avrebbero dato origine a stelle abnormemente ricche di tali elementi, conferendo loro quella caratteristica che le ha rese uniche. “L’esistenza di supernovae primordiali è una teoria già verificata”, dice Hansen. “Quello che invece ci ha più colpiti è il fatto che queste supernovae abbiano dato luogo alla stessa quantità di elementi presenti nelle vecchie stelle non anomale anche in quelle stelle stranamente ricche di elementi pesanti”. Dalle misure effettuate è emerso che l’1-2 per cento delle stelle antiche, povere in metalli (in astrofisica si considerano “metalli” tutti gli elementi di peso atomico superiore a quello dell’elio), risulta contenere oro, platino o uranio. “La distribuzione registrata”, prosegue la ricercatrice, “porta alla conclusione che le supernovae produssero letteralmente dei getti di materia lungo direzioni precise, così che solo determinate stelle ne sarebbero state influenzate. Questo rappresenta una scoperta fondamentale che aiuterà a far luce sui primi eventi che hanno avuto luogo nella Via Lattea, e probabilmente nelle altre galassie”.
Hansen, T., Andersen, J., Nordström, B., Buchhave, L., & Beers, T. (2011). THE BINARY FREQUENCY OF -PROCESS-ELEMENT-ENHANCED METAL-POOR STARS AND ITS IMPLICATIONS: CHEMICAL TAGGING IN THE PRIMITIVE HALO OF THE MILKY WAY The Astrophysical Journal, 743 (1) DOI: 10.1088/2041-8205/743/1/L1