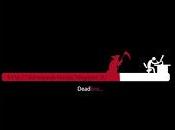Dove sei Livia?
Ora che potrebbe apparire più facile guardarci, perché spogli di ogni falsità effimera, ora che non abbiamo bende pesanti da rivendicare, ora che IO non possiedo fasce di lino robuste a sussidio di occhi vigliacchi, ora.. tu non sei tra le mie dita.
Hai cancellato ogni traccia nel momento preciso in cui avevo ricostruito un percorso composto dalle tue parole nuovamente rivelate, un percorso che seguiva l’ordine dei tuoi vestiti sparsi tra le mie robe, i tuoi mozziconi di sigaretta impressi nelle visioni delle pareti della mia stanza, i tuoi sguardi diretti, la mia vista maledettamente alterata.
Ti cerco, continuo a cercarti tra le strade che la tua vita ha tracciato sul mio fianco. I tuoi numeri di telefono, gli indirizzi delle tue case, la fallimentare richiesta d’aiuto alle tue amiche fidate, a tal punto da renderle schive e assenti ad ogni mia insistente richiesta di aiuto.
Ti cerco perché sento di volerti guardare, di cingerti a lungo, di renderti ogni tuo tentativo di maturare centimetri verso il mio cuore di cane.
Ti cerco come se mi avessi iniettato una dose massiccia di eroina, di quelle che producono dipendenza al primo contatto, mentre tu, spacciatrice di ogni mia emozione appena filtrata ed evasa da vene e polmoni in cancrena d’ossigeno, sei fuggita via con la dose successiva.
Livia… Il tempo non è stato leale con noi. Si è dilatato e ha mostrato la sua infamia genetica. Ha impedito che io cogliessi cosa stesse scivolando da sotto le mie mani, ha permesso che non afferrassi il carico emotivo che mi aveva squarciato il petto, come quei venti freddi del nord che azzannano la carne e penetrano ossa malandate, il tuo carico, il tuo amore, così immeritato e potente.
Il tempo ha mostrato quanto la mia fragilità e il mio egoismo abbiano frantumato ogni possibilità di redenzione. Il tempo non mi ha salvato, e ha aggravato la mia sorte. Ha dilatato la distanza che intercorre tra di noi.
Torna. Prendi quanto basta e sconfiggi il cancro dei nostri giorni passati, senza scelta, e senza una storia di cui vale la pena discorrere.
Amami come su quel binario freddo. Amami come le tue parole gonfie e sacre. Amami come se incrociassi la mia sagoma per la prima volta, come se fossi vergine di ogni tuo battito, ogni tuo gesto. Sono pronto e sono in attesa. Sono vigile e sono in quotidiana forgiatura del vero me stesso.
Sono dentro la tua visuale. Sono dentro il tuo amore.
Quando provo ad oltrepassare l’asfissia che produce la pila di rimpianti che sono fuoriusciti e si sono resi tangibili e fin troppo veri, quando provo a camminare per le vie di Bilbao come ad andare a lavare un’anima sporca di viltà accesa e a lungo consolidata, quando ho bisogno di silenzio e lacrime in libera uscita, tu sei a guidare i miei passi, sei il pensiero feroce e in progressiva ascesa.
Sei incastrata tra i miei passi sbadati. Sei penetrata in ogni mio quotidiano vivere.
Sei tramutata in amore, come solo l’amore puro e impavido è in grado di mutare.
La tua assenza è congenita, perché rinnova di continuo la sua intensa vibrazione.
Livia torna da me. Torna a guardarmi. Ho bisogno dei tuoi occhi.
Guardami, o almeno provaci. Che sia per il tempo di un ultimo sguardo, di un bacio terminale, di un’ eterna resa consapevole perché frontale.
Sento il peso opprimente di un cielo senza luci. Sono un uomo incespicato tra le stelle, perso nel ventre oscuro di una notte infinita che non possiede il tuo odore.
Aspetterò. Per il tempo che mi resta e finchè il tuo sentirti dentro continuerà a costruire la sua insostenibile dimora.
Non posso averti al mio fianco. Quindi non mi resta che amarti.
Vanni
Come caduta per sbaglio in una pozzanghera libera da qualsiasi sbavatura melmosa, la lettera che Livia stringeva tra le mani aveva catturato le lacrime incontrollate e catartiche che trafugavano i suoi occhi, le aveva assorbite, creando dei pois trasparenti ma evidenti su ogni parte del foglio.
Piangeva Livia. Come si piange per una palpitazione improvvisa che scaturisce a seguito di termini improcrastinabili, quando ogni freno inibitorio viene sganciato e non resta che abbandonarsi a tutte le scosse motrici che ne conseguono.
Un lavoro di carcasse carnivore, come vermi ad infierire, fino al punto in cui anche il tessuto più robusto e impermeabile al dolore va a cedere.
Fragile. Come non avrebbe mai voluto esserlo. Su una panchina eretta ma completamente liquefatta dall’acido che certe emozioni producono a contatto con i corpi o con le anime più esposte.
Poteva risiedere ad Amsterdam Livia, o in qualunque città del mondo, gli agenti esterni non avevano alcun potere distrattivo, non esisteva vita intorno a lei capace di terminare quel fiume lacrimoso puerilmente cosparso su carta fino a giungere alla trama del cappotto.
Quelle parole erano napalm su ogni tentativo di razionalità. Tossiche.
“Sonetto 116!”.
Livia, come destata di colpo da un sonno morfinico, udì una voce molto vicina a sé.
Si voltò di scatto e si rese conto per la prima volta da quando era intenta a mordere le ore aggrappata a quella sedia di ruggine e strada, che non era sola su quella panchina.
“Come scusi?”
Una donna, con un manto di capelli lunghi dalle tinte di albe nordiche, avvolta da una cappa di cashmere dal colore dei notturni asiatici e un vistoso cappello di velluto blu, sedeva accanto a Livia.
Elegante, come un bouquet di calle purissime, fiera nella sua posa, senza ostentare arroganza o sopraffazione altrui, una regina di un posto altrove…quella donna aveva pronunciato due parole nella lingua di Livia, senza che lei avesse mai aperto bocca.
“Alle nozze sincere di due anime, impedimenti non so. Non è amore l’amor che muta se in mutare imbatte o, rimuovendosi altri, si rimuove, oh no: è faro che per sempre è fisso e guarda alle bufere e non dà crollo. É il Sonetto 116. William Shakespeare.” Continuò la donna.
Sorrise. Lei sorrise. Ed è come se un vento vigoroso e caldo avesse preso la rotta verso centinaia di fiori di ciliegio, schiudendoli all’unisono, agitando i loro petali come in una danza magica, priva di gravità.
Livia si sentì attraversare da quei petali, come se improvvisamente uno sciame di pace armonica l’avesse trafitta e sedotta.
Quella donna era padrona delle parole. Le pronunciava come se le avesse partorite in quel mentre, come se fosse la genitrice di ogni lettera utile e viva, quasi a creare origami lessicali di cui si rende manifesta l’essenza primogenita.
Quella donna era armonia, e si chiamava Cléile.
Livia le chiese il perchè di quelle sue parole, di quel sonetto datato ma prezioso, perchè pare che le parole assumano valore e necessità solo se pronunciate a guisa di attimi precisi, nelle loro nozze con gli accadimenti.
Cléile sorrise nuovamente.
“Le parole chiamano parole, perchè invocate da sensi non percepibili alla nostra piccola portata. Vi sono delle energie che filtrano nell’aria, si mescolano ai corpi per poi venire esplulse e toccarne altri, di corpi, di uomini. É un circuito elettrico di sinergie e agguati sensoriali. E le parole si nutrono di tali energie. Sono i loro abiti, le loro scarpe con cui si muovono nell’immaginario reale.
Le parole sono andate a scorrere verso di te nell’attimo preciso in cui ti sei seduta accanto a me.
Sono belle vero?
Sono giuste, non credi? Sono potenti come quelle per cui hai cosparso le tue lacrime?”
Livia rimase immobile. Le labbra rigide e le spalle marmoree.
Cléile comprese quella reazione ma non esitò a continuare.
“Prova a scomporre quelle parole. Tienile sospese e scardinate da quel foglio per pochi secondi. Decodificale e tenta di capire se sono le parole di cui ardevi il possesso. Chiedi a te stessa, senza indugiare debolezza, se quelle parole appartengono effettivamente all’uomo che tu hai scelto, chiunque esso sia, e se nei tuoi intenti erano proprio quelli i fiori con cui Lui doveva coronare le tue bramosie. Le tue aspettative.”
Livia cercò di proferire un suono, qualcosa che potesse definirsi voce, ma era come se la lingua le si fosse ritratta in un blocco anestetico.
Cléile si mosse. I suoi gesti, fino a quel momento centillinati e impercettibili avevano la consistenza di passi di fata, sofisticati. Aprì la borsa che aveva con sè, estrasse un mazzo di carte vistoso. Tarocchi.
“Scegli una carta.”
Livia esitò il tempo di un fruscio di foglie, ma non si ritrasse.
Prese una carta e attese che Cléile spiegasse il senso di quel rituale.
Ma lei tacque. Si aprì in un sorriso caldo, estivo, quasi a rompere quella cortina d’inverno che giaceva intorno a loro. Ma tacque.
Livia teneva la sua carta sospesa a mezz’aria e dopo aver scambiato uno sguardo di dolce intesa con la donna, la girò.
L’Imperatrice:
“Perché il tuo amore non mentisca, come colui che finge fiabe per amore, accanto al corpo seppellisci il nome, che per vergogna non perdiamo onore: vergogna mia, del poco che son stato; tua, che quel poco devi avere amato.” (Sonetto 72 W.Shakespeare).”
Real Love – Beach House