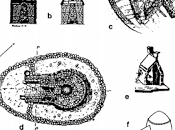Un po’ di tempo fa, scrivendo un articolo per la rivista Illustrati scelsi di parlare di un fotografo che amo moltissimo, per quanto si tratti di un amore recente e nato per caso. Lo conobbi mentre lavoravo per un’altra rivista – una rivista gastronomica atipica, la definirei –, e stavo editando un’intervista all’antropologo Enrico Salza. Non ricordo con precisione i passaggi dell’intervista, ma so per certo che si parlava di Africa, di fame, e di morte. E so che Salza chiuse l’intervista citando una foto e dicendo che dopo poco il suo autore si suicidò. Non aveva retto al dolore. Il fotografo era Kevin Carter.

Io quello scatto non lo conoscevo – colpevolmente – e andai a cercarlo. Non fu difficile, in realtà, poiché si tratta di una delle foto più chiacchierate e discusse che si trovino in rete. Per tutte le implicazioni etiche e morali che quella foto si porta dietro. Il campo è completamente sgombro, a eccezione di due figure; in primo piano una bambina rannicchiata su se stessa; il volto nascosto tra le mani, la magrezza impressionante; poco dietro di lei un avvoltoio in attesa paziente. Questa foto è stata realizzata in Sudan, nel 1993, ed è tutta l’Africa: arriva dritta allo stomaco e rappresenta una condizione che, da allora, si è evoluta di poco o per nulla. Perché la fame esiste ancora, e a patirne le conseguenze sono soprattutto le donne e i bambini. 850 milioni di persone nel mondo. Molte di esse africane, appunto.

Quella foto sembra spazzare via tutto il precedente lavoro di Carter. I reportage in Sudafrica, ad esempio, dove Carter documenta gli orrori del governo di F.W. De Klerk, l’ultimo presidente bianco dell’apartheid. Negli anni Ottanta, infatti, insieme ad altri Carter aveva costituito il Bang Bang Club, che aveva iniziato a immortalare le crudeltà della guerra civile: pistole puntate alla testa, omicidi a colpi di machete, il “supplizio dello pneumatico” che lui, Carter, è il primo a fotografare… Ma nessuna delle sue immagini ebbe mai la stessa forza di questa, che infatti gli valse il Pulitzer l’anno seguente. Quella foto dev’essere anche la sua condanna: che ne è stato della bambina? L’hai soccorsa? Perché l’hai fotografata anziché prestargli aiuto? Che razza di uomo sei?

Carter, a questo fiume di domande, non rispose mai. Il 27 luglio del 1994, subito dopo il ritiro del Pulitzer e lasciò un foglio con su scritto: «Mi dispiace, mi dispiace tanto. Il dolore di vivere prevale sulla gioia a tal punto che la gioia non esiste… depresso… senza telefono… i soldi per l’affitto… i soldi per i bambini… i soldi per i debiti… soldi!!! Sono perseguitato dai ricordi vividi di uccisioni e cadaveri e rabbia e dolore… di bambini affamati o feriti… di folli dal grilletto facile, spesso poliziotti, di killer… Se sono fortunato me ne sono andato per unirmi a Ken (Ken Oosterbroek, anche lui membro del Bang Bang Club, morto nell’aprile del 1994, ndr)». Fine. Kevin Carter non resse. E forse fu per una foto o forse per l’insostenibilità di una condizione, quella del fotogiornalista, che davanti all’orrore si “nasconde” dietro al suo obiettivo. Perché è il suo lavoro. E perché è lì che deve stare. Per trasmettere quell’orrore al mondo. E per stimolare, forse, una qualche risposta.
Kevin Carter non diede mai risposte sul destino di quella bambina, ma lo ha fatto El mundo qualche anno fa, mandando dei giornalisti a indagare sul dopo. La bambina, in realtà, era un bambino: il suo nome era Kong Nyong. In quell’occasione sopravvisse, perché inserito in una missione Onu. Aveva una sigla “T3” apposta sul braccio – una sigla che indica una malnutrizione grave – e ci fu chi si prese cura di lui. Ma morì quattro anni dopo, di febbre.

«Niente è più convincente ed espressivo di ciò che si può vedere con i propri occhi. Sebbene si possa eccellentemente descrivere un attacco della polizia armata a una manifestazione operaia, un corpo di un operaio calpestato dalla polizia a cavallo o un negro linciato da un brutale sanguinario carnefice, mai un’immagine disegnata, in forma verbale o scritta, sarà convincente quanto può esserlo la riproduzione fotografica. Il fotografo è il più obiettivo dei grafici. Riprende soltanto ciò che, nell’attimo dello scatto, si presenta al suo obiettivo. E un’immagine fotografica è comprensibile in tutti i paesi, in tutte le nazionalità, come anche al cinema, nonostante la lingua, il titolo e le spiegazioni».
Tina Modotti, Arbeiter Illustrierte Zeitung, Berlino 1932.
Per saperne di più: