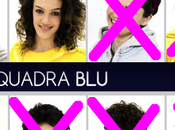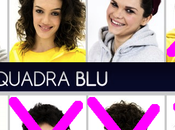In scarpe Adidas, in shampoo Badedas, in culo un ananas. Premessa doverosa da parte mia è dirvi subito che questa espressione, così come la usiamo al giorno d’oggi, non l’hanno inventata gli antichi romani. Essa è citata per la prima volta da Erasmo da Rotterdam (1466 – 1536) nei suoi Adagia (1500), una raccolta di motti latini commentati, accanto al suo equivalente greco ἐν οἴνῳ ἀλήθεια. In effetti la più antica associazione tra il vino e la verità si trova in un frammento del poeta greco Alceo (fr. 366 Voigt) di cui possediamo solo l’incipit: οἶνος, ὦ φίλε παῖ, καὶ ἀλάθεα («il vino, caro ragazzo, e la verità..»). Tra le opere degli antichi romani la forma più simile al moderno in vino veritas la troviamo in Plinio il vecchio (23 – 79 d.C.) che, in un passo della sua enciclopedia scientifica intitolata Storia Naturale, afferma: volgoque veritas iam attribuita vino est (‘comunemente la verità è stata legata al vino’). Bene, se avete resistito fin qui ora è tutto in discesa. Nella società d’oggi profondamente liberalizzata in ambito etilico in cui mi glorio di poter dire di vivere questa espressione è non solo attualissima, ma passibile di declinarsi in svariati altri modi: in rum e cola veritas, in gin tonic veritas, in bacardi breezer veritas (per gli under 15), in campari orange veritas (dalle 19 alle 21) e, per quanto mi riguarda, in secondo sambuca e vodka alla menta veritas.

Al di là del processo di diffusione delle varianti alcoliche che mi piace ricordare col nome di «civilizzazione», tornando ai nostri romani, per loro si parlava di vino, bevanda che nel mondo antico era componente essenziale della vita quotidiana, tanto nell’alimentazione quanto nella sfera sacrale, nelle libagioni, nei sacrifici e nei riti funerari. Il vino aveva un ruolo di primo piano soprattutto in una particolare occasione: il banchetto. E non sto parlando dei tavoli di legno traballanti coperti di orrende cianfrusaglie coloritamente definite «etniche» (ma etnico de che? Ma di quale ethnos poi? Di certo uno con pessimo gusto) che tra qualche settimana non mancherete di saccheggiare passeggiando sul lungo mare di Varigotti. Quello del banchetto e dei poteri catartici del vino è un motivo di lunga tradizione, che si rifà al costume greco arcaico del simposio, una vera e propria istituzione sociale che costituiva anche momento privilegiato di fruizione poetica. Ecco diciamo un po’ come ai nostri matrimoni si sta seduti a tavola ore infinite e la band di turno al soldo degli sposi ci propina chessò Trottolino amoroso dududadada, in epoca antica si stava sdraiati e il soundtrack avrebbe potuto essere ad esempio un bel ditirambo di Pindaro. L’immagine paradisiaca di questo all you can eat 5 stelle luxury è molto allettante, c’è solo da sperare che il padrone di casa non sia uno tipo l’imperatore Eliogabalo, che ebbe la brillante idea di voler stupire i suoi commensali facendo cadere su di essi all’improvviso un tripudio di petali di rosa (Enzo Miccio, so che mi leggi, prendi appunti). L’inconveniente fu che i fiori erano talmente tanti che sommersero gli ospiti e alcuni di essi morirono soffocati.
La realtà aulica del simposio letterario costituisce uno dei temi privilegiati della poesia oraziana, di cui già abbiamo parlato nel post dedicato a Carpe diem. Esiste poi un’altra dimensione del banchetto dove il vino, mai bevuto liscio ma rigorosamente aromatizzato con miele e spezie, scorre sempre a fiumi. Il caso in questione è quello della Cena di Trimalcione, un brano di una delle opere letterarie latine giunteci frammentarie di cui più piangiamo la perdita, il Satyricon di Petronio. Quello che sopravvive di questo romanzo ci dà uno spaccato della vita quotidiana nel periodo di massima pace e ricchezza dell’impero, il I sec. d.C., e rappresenta una fonte inestimabile per la conoscenza della lingua e della abitudini di tutti i giorni dei romani. Nonostante la tematica volgare (nel senso latino del termine, da vulgus ‘popolo’), il suo autore era un finissimo letterato e anche gran viveur, se davvero lo si deve identificare con Gaio Petronio, uomo voluto a corte da una personcina come Nerone a ricoprire il ruolo di «arbiter elegantiae» (‘giudice del gusto’).