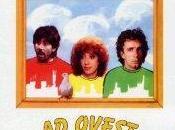On the Road Again. Paolo Marini, All’oro. Versi nel cammino e della marcia, Firenze, Polistampa, 2011
On the Road Again. Paolo Marini, All’oro. Versi nel cammino e della marcia, Firenze, Polistampa, 2011
_____________________________
di Giuseppe Panella*
Versi nel cammino e della marcia, sottotitola il suo secondo libro di versi Paolo Marini a indicarne il carattere in progress e di discussione delle fasi esistenziali che lo sottendono. Come scrive bravamente Franco Manescalchi nel suo denso saggio introduttivo:
«Sembrerebbe, quello di Paolo Marini, un canzoniere scritto nel tempo che, su questa costante, sviluppa gradualmente un percorso che va dalla ricerca dell’altro alla presa di coscienza del mondo, ad una rimodellazione poetica e coscienziale del mondo stesso. Come ebbi a scrivere nel 1997 presentando il suo primo libro, Pomi acerbi, il poeta “ha saputo parafrasare se stesso per il viaggio esistenziale in cui si è mosso e commosso” dando voce e prefigurazione a un ecosistema dove l’uomo e la poesia abbiano ancora spazio per r/esistere» (p. 9).
La scrittura poetica di Marini si avvolge e si dipana nel cammino perché risulta pur sempre collegata e inestricabile alla vicenda sempiterna e sempre diversa della vita che continua, nonostante tutti e tutto, a macinare il suo impassibile percorso verso una fine sempre prossima e sempre dilazionata ma è della marcia perché l’accompagna, la blandisce, la conserva al proprio interno e sembra ricavarne, in questo modo, perle di saggezza esistenziale e succhi di verità. Ovviamente, la poesia (con buona pace di Goethe) non è la verità: è il sogno, l’aspirazione, il delirio della verità… Anche la poesia di Marini mostra il carattere onirico di una ricerca di emozioni e di atmosfere che conducono verso un tentativo di bilancio, di emergenza dal quotidiano per concludere in qualche modo un cammino che parte dall’Io per raggiungere una nuova dimensione di conoscenza, di acquisizione di stabilità emozionale e culturale. Lo dichiara lo stesso autore nell’ultima lirica della sua raccolta, scandita e quasi incisa come un sigillo sulla cera molle del sentimento, quasi una sorta di acquisizione definitiva del proprio mondo interiore:
«IO SONO. Cammino / soffro / e / spero / sulla terra // su questa / terra / la nuda / terra // ma se anche, / amandola, / la stringo / in un pugno // io sono / creatura / del cielo» (p. 98).
La ricerca, il cammino, la marcia, dunque, continuano. Bisogna arrivare al cielo passando attraverso la terra del presente con in mente, tuttavia, come obiettivo reale concreto e tuttavia non sempre raggiungibile la forza della poesia. E’ questo, probabilmente, il senso profondo di quel Nell’oro che titola la raccolta. L’”oro” qui sta per il potere forte e fondante della poesia, per la dimensione “dorata” di un‘esistenza che è oltre di essa (è, forse, l’aspirazione a quella Golden Eternity che, alla fine, è narrata nel sogno poetico dell’ultimo Kerouac) e alla quale si aspira come ideale regolativo.
Essere “nell’oro” è, dunque, desiderio e sogno, ritorno a una dimensione edenica (l’età dell’oro) della vita, volontà di ritrovarsi all’interno di una dimensione riconciliata con la natura e le sue propaggini esterne e interne, umane e non, nel tentativo di restaurare un’armonia (forse irreversibilmente) perduta. Marini qui gioca la carta del canto e dell’evocazione musiva:
«MADRE SOLITUDINE: E’ lo spazio essenziale. / Ti porto ove sempre / faccio ritorno / solo e semplicemente / per respirare: // le pareti dell’anima / vi si rinfrescano / in tutto rifiorisce / una baldanza segreta. // Avvolge d’infinito / la mia inquietudine / spazza la fiacchezza // grembo di salvezza / e d’ogni poesia / madre solitudine» (p. 61)
La solitudine o come in un altro testo della raccolta il silenzio sono le forme espressive che danno spessore e saggezza alla parola. Senza solitudine e silenzio vige l’impossibilità di esprimersi adeguatamente con ciò che dovrebbe costituire la sostanza di ogni vincente comunicazione e che quasi sempre, tuttavia, rischia di venir meno nel gorgo incosciente, proliferante, costrittivo e onnicomprensivo della “chiacchiera” (Heidegger). “Spazio essenziale” della realtà più profonda, la solitudine esige lo stesso rispetto delle forme di creazione più estreme, più avanzate.
Allo stesso modo, appaiono necessari il silenzio, la meditazione e le loro forme di manifestazione diretta. In una lunga e solidissima suite lirica, tesa come la lama di un coltello ed emozionata come una dichiarazione d’amore, Marini si dilunga nel descrivere lo stato dell’arte della sua vita e della sua passione lirica d’autore di poesia:
« […] A vent’anni, se ben ricordo, / le mie impronte si stampavano nel pantano. / Ma il passo era leggero / e il futuro non m’inquietava. // C’era un grande destino / lì, davanti, che a braccia spiegate, / proprio lì, mi aspettava. / Era una voce, dentro di me, / era un fuoco, oltre il dolore, / oltre il limite. // Alla soglia dei trent’anni / non so più raffigurarmi / né credo che vi sia / la cosiddetta donna ideale. // Nebulosa d’adolescente / germinava un morbo esiziale. / Ora, le donne, me ne piacciono di più / e mi convincono di meno; / e un po’ meno è importante / il cor gentile di un bel deretano. // Alla soglia dei trent’anni / mi ritrovo con l’armatura ammaccata / e la polpa un po’ indurita. // Non che abbia alle spalle / la Guerra dei Trent’Anni: / la vita è una guerra, sì, / ma di posizione; è raro che ci / veda al galoppo, con la lancia / in resta e gli occhi di fuoco. // […] Alla soglia dei trent’anni / la faccenda si fa molto meno seria / di quanto avrei potuto immaginare» (pp. 22-23).
Ora i trent’anni sono già oltre (io temo per il poeta che li ha descritti così liberamente e disinvoltamente), ma le motivazioni della poesia restano ferme e validissime.
Se “l’armatura è ammaccata” e il destino è arrivato a far sentire la sua voce un po’ arrochita dopo aver perso lo smalto melodioso dei suoi vent’anni di “fuoco”, quello che è subentrato è un bel calibrato disincanto, una volontà di prendere le cose della vita così come sono, un’aspirazione vagamente edonistica e vagamente dolente e melanconica a un tempo, una seria capacità di prendersi un po’ in giro e di ironizzare su se stesso che non risparmia i miti e gli stilemi del romanticismo giovanile (il “cor gentile” della prospettiva consolidata e patente affermatasi con il Dolce Stil Novo) ma neppure quelli dell’understatement più placato dell’erotismo di solito più corrivo e in fondo pacificato (il “bel deretano” che fa il verso come prospettiva di dolce appagamento all’idealismo esasperante della tradizione lirica italiana di sempre). Marini fa il bilancio e si trova in pareggio: la gloria e la passione travolgente e folle forse non sono (ancora) venute e forse non occorre più neppure che corrano “al galoppo” veloce come le cariche di cavalleria della guerra di Crimea o dei film di Michael Curtiz. Se la polpa si è indurita, l’anima si è rafforzata; se la voce è più flebile, la parola è più affilata, più secca, più tagliente.
La poesia di Marini, dunque, alterna una voce disincantata e spesso (auto) ironica a un’altra più patetica, voluttuosa, appassionata e volitiva. L’alternarsi di queste due voci costruisce e altalena il ritmo della raccolta: il Canto della pulizia nei cassetti (con taglio simil-brechtiano e “didattico”) o Parigi con la sua nostalgia lenta fatta di parole d’antan e di esperienze ormai rimandate al mittente (la”valigia che poco pesa”, il ”limite angusto” ne sono spia non solo linguistica) sono esempi eccellenti della “prima” voce. La parola giusta (la sua ricerca, la sua necessità) contraddistingue la seconda come vera e propria declamazione di poetica esistenziale:
«LA PAROLA GIUSTA. Mi caccia all’inferno // mi assume in paradiso: // più che un rimorso / più che un sorriso / è la parola, // una parola è tutto. // Tant’è scarna / la giornata – e / avara – che, // nell’istante ch’è attesa, // dammi la parola / giusta // /anche se non / fosse vera)» (p. 39).
Nonostante il tempo sia passato, nonostante il sogno sia svanito, nonostante l’asprezza delle rivendicazioni del presente, la ricerca del mot juste (come ha scritto più volte Gustave Flaubert alla sua ninfa egeria Louise Colet) è la sostanza della ricerca poetica e del desiderio che la spinge a durare sempre e comunque nel cammino verso l’”oro” della poesia, quell’oro e quell’aura (ma le due parole forse qui si equivalgono) che sono la capacità di dare parola al silenzio perduto e alla solitudine prescelta e ricambiata, attesa e circondata della sostanza stessa dell’umano destino.
___________________________
*Il titolo di questa rassegna deriva direttamente da quello di un grande romanzo (Quel che resta del giorno) di uno scrittore giapponese che vive in Inghilterra, Kazuo Ishiguro. Come si legge in questo poderoso testo narrativo, quel che conta è potere e volere tornare ad apprezzare quel che resta di qualcosa che è ormai passato. Se il Novecento italiano, nonostante prove pregevoli e spesso straordinarie, è stato sostanzialmente il secolo della poesia, oggi di quella grande stagione inaugurata dall’ermetismo (e proseguita con il neorealismo e l’impegno sociale e poi con la riscoperta del quotidiano e ancora con la “parola innamorata” via e via nel corso degli anni, tra avanguardie le più varie e altrettanto variegate restaurazioni) non resta più molto. Ma ci sono indubbiamente ancora tanti poeti da leggere e di cui rendere conto (senza trascurare un buon numero di scrittori di poesia “dimenticati” che meritano di essere riportati alla memoria di chi potrebbe ancora trovare diletto e interesse nel leggerli). Rendere conto di qualcuno di essi potrà servire a capire che cosa resta della poesia oggi e che valore si può attribuire al suo tentativo di resistere e perseverare nel tempo (invece che scomparire)… (G.P.)