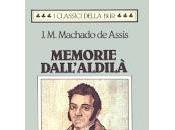di Paolo Pegoraro
«…ma questa è un’altra storia, e si dovrà raccontare un’altra volta». Se questa frase vi dice qualcosa, probabilmente siete tra i fortunati che hanno amato un curioso romanzo in 26 capitoli, alcuni scritti in rosso rubino e altri in verde acqua, ma tutti introdotti da grandi capolettere che procedevano ordinatamente in ordine alfabetico, dalla A alla Z. Se invece questa frase non vi dice nulla, siete probabilmente tra gli sfortunati che conoscono solo i film liberamente ispirati a La Storia Infinita e cordialmente detestati dal suo autore.
Proprio uno strano destino, quello della Storia Infinita, esibita nelle manifestazioni di pacifisti e ambientalisti negli anni Ottanta e oggi involontaria patron – attraverso il nome di un suo protagonista, Atreju – del convegno annuale di un partito di tutt’altra area. Destino tanto più bizzarro se si pensa che alla sua uscita il romanzo fu accusato di apoliticità, destino che però lo accomuna al capolavoro di J.R.R. Tolkien, tirato per la giacchetta dalle direzioni più disparate.
Che cos’è, allora, La Storia Infinita? Una godibilissima storia di fantasia per adolescenti? Certo. Una miniera di citazioni – da J.R. Borges a C.S. Lewis – che il lettore più smaliziato si diverte a riconoscere? Anche questo. Ma pure tanto altro. Per saperlo, meglio lasciare la parola all’autore stesso, Michael Ende, e leggersi la sostanziosa raccolta di inediti Storie infinite (Rubbettino 2010, pp. 94, € 10), curato con invidiabile acribia dal giornalista e critico letterario Saverio Simonelli.
Il titolo di questa raccolta di articoli e conferenze – Storie infinite – mette subito sull’attenti: parliamo di storie che generano nuove storie, non idee o astrazioni. Lo stesso Ende amava definirsi «narratore di storie» piuttosto che letterato. E cosa vuol dire raccontare una storia? Significa rappresentare l’esperienza di un’evidenza che precede il pensiero e che, per essere comunicata, deve traghettare l’invisibile nelle forme del mondo visibile. Secondo lo scrittore tedesco, la poesia «deve farsi realtà» e in una certa misura rendere “presenza reale” ciò di cui parla, secondo una bella espressione di George Steiner. Se fosse possibile spiegare perfettamente un romanzo, non sarebbe stato necessario scriverlo. La narrativa non insegna, mette in moto un processo. Non difende valori, li trova e li rinnova, permettendoci così di ricollocarci nel mondo in un modo nuovo. Scopo dell’arte non è spiegare il mondo, ma unificare la persona. Non andiamo a teatro per sentirci più colti (o almeno, non dovremmo), quanto piuttosto nella speranza di venire pervasi da un’intima sensazione di risanamento. La bellezza, secondo Ende, non è un optional. «Credo – scrive in una pagina toccante – che gli esseri umani non si mostrino mai così riconoscenti come quando viene offerto loro un piccolo frammento di bellezza […] Quando ne vengono privati, si aggrappano perfino ai surrogati, a dei sostituti, perfino al kitsch pur di placare la loro fame».
La bellezza di cui parla Michael Ende, quella che lui stesso cercò di trasmettere con i suoi romanzi, è semplice e perenne. Non ama gli artifici dello sperimentalismo o gli esercizi stilistici, e tanto meno il soggettivismo. È uno sguardo sul mondo naturale e ragionevole, pertanto incantato. Uno sguardo ammutolito per lo stupore: perché è questo l’atteggiamento fondamentale dell’uomo che si pone in un rapporto sano con la realtà. «Il meraviglioso è sempre bello – ha scritto André Breton, per precisare subito dopo – Anzi, solo il meraviglioso è bello». Lo sguardo disincantato viceversa, oggi sdoganato come l’unico sguardo onesto sulla realtà, è amputato e deforme. È lo sguardo della ragione assolutizzata che cessa di contemplare il mondo per divertirsi a giocare allo specchio con le infinite combinazioni della propria immagine. Ende non le manda a dire: per lui il razionalismo è una medicina della quale si è abusato, finendo per trasformarla in una droga. Similmente l’occhio umano «è sano solo se lo si dimentica nell’atto di vedere; se cioè si vede cosa ci sta mostrando e non si bada all’occhio in sé. Se ci presto attenzione è perché è un occhio malato». Un po’ come nella famosa storia del dito e della luna…
La critica di Ende – profondo estimatore dei manifesti della letteratura romantica (Coleridge, Wordsworth, Novalis) – ricorda quella mossa agli scrittori di matrice positivista da Gilbert K. Chesterton: «Il Realismo è soltanto il Romanticismo che ha smarrito la ragione […] L’arte romantica raffigurava un santo asinello che sale al tempio. Ma il Realismo è la raffigurazione di un asinello sperduto che procede senza una mèta» (Mostri di stile gotico, 1910). Un mondo senza elfi, cicogne, fate del dentino, denudato di ogni miracolo o magia, un mondo che bandisce a priori angeli custodi o entità che portano regali sotto le feste, è sicuramente un mondo inabitabile per i bambini. Ma lo è pure per gli adulti, se proprio non si vogliono buttare alle ortiche le amare lezioni che lo scorso secolo ci ha tragicamente insegnato. Ciò che ci è essenziale per vivere meglio non è più conoscenza oggettiva – sempre e comunque benvenuta – ma più saggezza. E i misteri del mondo si rivelano soltanto a chi si lascia cambiare da questi stessi misteri. Come sanno fare i bambini.
Un assaggio dell’opera
Di fatto è la cosa più facile del mondo, esattamente come giocare con un bambino a cucinare pasticcini di sabbia. Si tratta di un gioco del «come se»: se l’adulto chiede al bambino di provare ad assaggiarne uno, questi verosimilmente si soffermerà su qualche particolare riguardante il sapore e così l’altro dovrà fare «come se» aggiungesse del sale o dello zucchero nell’impasto o magari anche un paio di uvette. In questo modo l’adulto diviene parte del gioco e il bambino prende il tutto assolutamente sul serio. Nel momento in cui però l’adulto si mettesse in bocca un pasticcino di sabbia, il bambino si metterebbe a ridere dicendo: «Ma che fai? Mica puoi mangiarlo. È di sabbia!». È un procedimento simile a quanto accade a teatro.
Nel nostro caso il bambino non fa alcuna fatica a tenere assolutamente distinti i due piani. Invece l’adulto di oggi che ha completamente disimparato a giocare e non sa prendere sul serio il gioco tende a confonderli. Con quello dell’immaginario poi gli si presentano i problemi più grossi, quelli che per il bambino assolutamente non si pongono. Costui infatti sa salire al livello dell’immaginazione con un tale senso di pienezza da dimenticare temporaneamente la realtà esterna senza però mai confondere i due piani. È solo l’adulto privo di fantasia che crede di dovere preservare il bambino dal rischio di confonderli, perché in realtà è proprio lui a non sapere più comprendere la realtà «altra» della fantasia.
Prendiamo in esame una pagina di una fiaba qualsiasi, in questo caso la fiaba del ginepro in cui si legge: «Quando il fratellino infilò la testa nel cesto delle mele, la matrigna cattiva chiuse violentemente il coperchio e la testa del bambino rotolò fra le mele rosse». Rifacendoci alle considerazioni precedenti possiamo presupporre che un adulto, con la sua mentalità assolutamente deformata in senso naturalistico, pensi subito all’arteria tranciata, a un qualcosa di truculento, a un bagno di sangue, una scena orribile. Un bambino a una cosa simile non ci pensa assolutamente. Egli vede precisamente quello che gli dice l’immagine, vale a dire che la testa è stata separata dal tronco come fosse quella di una bambola. Nulla di più e nulla di meno di quanto è contenuto nell’immagine, che non è affatto intesa in senso naturalistico: la testa infatti viene separata dal corpo umano sul piano della rappresentazione. Solo quando si presenta l’adulto con le sue interpretazioni, il quadro per il bambino si fa ingarbugliato. A lui infatti basterebbe ricevere l’immagine così senza mediazioni proprio come viene espressa nella fiaba.
Prendiamo come ulteriore esempio la favola del principe ranocchio per mettere a fuoco la tendenza di un certo periodo in cui molti pedagoghi ben pensanti si sforzavano di sterilizzare le fiabe popolari per eliminare da esse ogni passaggio che contenesse una qualche crudezza. Personalmente ricordo una rielaborazione di questo tipo proprio del principe ranocchio che attraverso una minima alterazione faceva venire fuori dalla fiaba esattamente il suo contrario.
Come è noto, nella storia, il ranocchio sta sempre alle costole della principessa ricordandole la sua promessa di matrimonio. Alla fine arriva fin dentro al suo letto, ma la principessa lo afferra e lo scaglia contro il muro. In quel preciso istante appare il bel principe. L’autore della rielaborazione era dell’opinione che, basandosi sulla fiaba, i bambini potessero arrivare a pensare di scagliare ranocchi contro i muri per vedere se l’effetto fosse quello di far comparire un principe. Un modo di ragionare tipico dell’adulto. Nessun bambino scambierà mai un ranocchio vero con questo meraviglioso rospo gigante con tanto di corona che sa parlare e ripescare una sfera d’oro dal fondo di una fontana. Il bambino che confondesse i due piani sarebbe in realtà un bambino completamente rovinato dagli adulti. Ciononostante il finale della fiaba venne cambiato con l’intento di impedire che i bambini infliggessero maltrattamenti agli animali. Nel nuovo finale, quando il ranocchio arriva nel letto della principessa, lei gli volta le spalle atterrita e si mette a piangere… quando poi però si gira nuovamente, vede di fronte a sé il bel principe. In questo modo l’intera fiaba viene snaturata, perché il fattore decisivo dello sviluppo della storia è il costante rifiuto del ranocchio da parte della principessa che però quando, in preda all’ira, lo afferra e lo scaglia contro il muro finisce per liberarlo. Il ranocchio è quel qualcosa di inquietante e repellente che dal sistema metabolico, dalle profondità delle viscere affiora alla coscienza. Solo dopo lunga esitazione la principessa lo afferra con le sue mani – anche se per colpirlo – ma è proprio in questo modo che libera dall’incantesimo il principe. Se non si comprendono queste immagini e le si edulcora con una versione banale e superficiale si distrugge il senso della fiaba.
Il fatto che la gente sia diventata così cerebrale e che non riesca a tenere più distinti i piani è uno degli aspetti più inquietanti del nostro secolo. La realtà umana è costituita da molti livelli, ma le teste piatte non vogliono ammetterlo, perché ammetterlo significa riconoscere di dover avere a che fare all’occorrenza anche con quelli più bassi.
(articolo comparso per l’agenzia ZENIT il 28 settembre 2010)