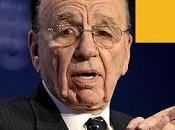Ridurre la discrepanza. Appunti per un Sudtirolo futuro
Così una chiave può rimanere per sempre lì dove l’artefice l’ha riposta e non venire mai usata per aprire la serratura per cui l’artefice l’ha forgiata (L. Wittgenstein).
Vorrei cominciare annotando il concetto di “discrepanza”. Vorrei poi schizzare un quadro del plurilinguismo sudtirolese alla luce di una “discrepanza” che è possibile avvertire ogni qual volta poniamo in questione la mera accettazione di un’esistenza semplificata e idealizzata. Vorrei infine chiedere a quali condizioni, parlando di lingue parlate in Sudtirolo e dei problemi che storicamente si connettono all’uso di queste lingue, è possibile per noi oggi ridurre l’esistenza di una relativa “discrepanza” tra il piano di una realtà ufficialmente riconosciuta e quello invece costituito dalla vita che fluisce ben oltre quel riconoscimento ufficiale. Ma procediamo per gradi.
Il concetto di “discrepanza” richiama quelli di contraddizione, contrasto, differenza, disaccordo, disarmonia, divario, divergenza, diversità, sfasamento. Bisogna ricondurlo dunque a due entità che, se venissero sovrapposte, non coinciderebbero. Appurato questo, poniamo una semplice domanda in relazione al nostro tema: quante sono le lingue che si parlano in Sudtirolo? La risposta ufficiale qui sembrerebbe in apparenza scontata. In Sudtirolo si parlano tre lingue: tedesco, italiano e ladino. E chi parla queste lingue? Altra risposta facilissima: i tedeschi, gli italiani e i ladini. Il presupposto di simili risposte è a) che queste, e non altre, siano le lingue caratterizzanti la nostra realtà sociolinguistica e b) che ogni individuo assuma come tratto primario della propria identità una, e una sola, di queste lingue. Può risultare in effetti assurdo pensare che la realtà sia davvero questa. Ma questa per l’appunto non è la realtà, bensì la sua declinazione ufficiale e istituzionale, composta mediante la cristallizzazione di un’immagine che idealizza (e dunque fissa) soltanto una possibile versione di quella realtà, anche se di fatto si tratta di una versione dominante e perciò accettata più o meno da tutti.
Credo sia sufficiente gettare anche uno sguardo superficiale sulla propria cerchia di amici e conoscenti per certificare tutta la “discrepanza” tra una simile immagine semplificata della realtà e quella “vita che fluisce”, come l’avevo definita in precedenza, nella quale siamo immersi. Intanto, e senza soffermarci sul tema della diglossia tra dialetto e lingua standard (che concerne quasi per intero la popolazione di lingua tedesca), per molte persone non è assolutamente vero che la propria identità sia riducibile alla lingua appresa nell’infanzia (anche perché in molti casi possono essere due, o anche di più, le lingue con le quali si è avuto la fortuna di crescere). Poi ci sono ovviamente tutti quegli individui, provenienti da svariati paesi, che portano in dote (vorrei dire preziosa dote) le lingue parlate nei loro luoghi d’origine. Infine dobbiamo mettere nel conto anche tutti coloro i quali, pur rientrando senza troppi problemi in una delle categorie ufficiali definite in precedenza, non ritengono che ciò debba risultare determinante ai fini della costruzione della nostra stessa base istituzionale. E si tratta dunque di persone decise a non arrendersi all’idea che oltre le colonne d’Ercole del nostro modello di convivenza – proporzionale etnica, censimento linguistico, patentino di bilinguismo e così via – non si diano anche ulteriori possibilità di ridurre progressivamente la “discrepanza” tra quello che astrattamente siamo ritenuti essere e quello che invece concretamente sentiamo, o almeno molti di noi sentono di essere.
Torno dunque all’inizio e chiedo di nuovo: a quali condizioni, parlando di lingue parlate in Sudtirolo e dei problemi che storicamente si connettono all’uso di queste lingue, è possibile per noi oggi ridurre questa “discrepanza” tra il piano di una realtà ufficialmente riconosciuta e quello invece costituito dalla vita che fluisce ben oltre quel riconoscimento ufficiale?
Suggerisco tre possibili ipotesi/condizioni d’intervento sulle quali converrebbe forse lavorare in futuro per dare senso a una proposta politica (in primo luogo di politica linguistica ma ovviamente anche di respiro più vasto) che qualificherei di orientamento progressista:
1) ogni istanza di cambiamento sarà destinata a restare troppo debole in rapporto alle forze conservatrici ancora capaci di aggregare maggiore consenso se essa verrà vissuta, proposta e costruita come minoritaria o elitaria; al contrario essa sarà in grado di acquistare maggiore forza se saprà rivolgersi a tutte le parti in gioco, ponendosi quindi come obiettivo il ripensamento delle logiche partigiane sinora generalmente praticate.
2) ogni proposta di mutazione dello scenario attuale – linguistico e culturale – dovrà puntare sul concetto di miglioramento, non negando dunque ciò che di buono è stato acquisito, non puntando a uno distruzione dello status quo, ma suggerendo con convinzione che esistono traguardi futuri ancora da cogliere;
3) La trasformazione degli equilibri prevalenti che le istituzioni prescrivono dovrà essere favorita soltanto in relazione alla crescita di una consapevolezza condivisa, dunque mediante un’estensione della partecipazione e un allargamento della facoltà decisionale degli abitanti di questa terra.
Dalla realizzazione di queste tre condizioni – condivisione, miglioramento, decisione comune – dipenderà la capacità d’impostare anche all’interno del nostro piccolo spazio un programma che non dobbiamo temere di collocare su uno sfondo ambizioso: l’Europa unita e plurale dei popoli, delle lingue e delle culture.
Contributo pubblicato nel Rundbrief della OEW (Organisation für Eine solidarische Welt), Februar 2012