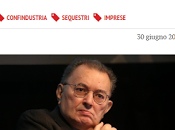di Luca Barana

La rivolta del Nord del Mali si è accentuata negli ultimi mesi, dopo che a marzo un colpo di Stato militare ha spodestato il Presidente Amadou Toumani Tourè. I militari sono stati spinti all’azione dalla supposta incapacità del governo civile di gestire le prime avvisaglie della sollevazione dei Tuareg nella regione settentrionale. Il risultato di tale iniziativa è stato tuttavia paradossale, dato che la debolezza e la confusione istituzionali generate dalle tensioni a Bamako, la capitale, hanno rafforzato la rivolta del Nord, oggi saldamente nelle mani di alcune formazioni dalle spiccate tendenze islamiste.
La rivolta in realtà discende dalle rivendicazioni etniche del popolo Tuareg, che rappresenta circa un decimo della popolazione del Mali e vive per lo più nella parte settentrionale del Paese, fra le sabbie del Sahara. Le accuse di discriminazione rivolte nei confronti del governo centrale sono ormai radicate nella coscienza collettiva di questo popolo, tanto che già in passato i Tuareg sono stati protagonisti di rivolte nel Nord, come nel corso degli anni Novanta, quando ricevettero il decisivo supporto del regime libico di Gheddafi. Non a caso, il ritorno in patria di moltissimi uomini Tuareg al servizio del defunto leader della Libia costituisce un elemento particolarmente critico della vicenda e potrebbe averne costituito uno dei fattori scatenanti. Sin dalla fine della fase più acuta della crisi libica del 2011, infatti, una delle maggiori preoccupazioni a livello internazionale è stata legata alla circolazione di consistenti quantità di armamenti, nelle mani di ribelli e forze governative, che sono state poi trasferite o vendute nel sud della Libia e nei Paesi confinanti, come il Mali. Il timore di un “effetto domino” seguente al conflitto in Libia pare essere confermato dunque dai fatti in Azawad, la regione settentrionale del Mali.

Fonte: Global Voices
Se inizialmente la rivolta è stata connotata da tratti etnico-nazionalistici, con il passare dei mesi la componente islamista fra i ribelli si è tuttavia fatta sempre più forte, allarmando anche le cancellerie occidentali, a partire da quella francese. Fra le forze protagoniste della rivolta infatti, a latere del Movimento Nazionale per la Liberazione dell’Azawad (MNLA, dal suo acronimo francese) di matrice Tuareg, considerato in declino, si sono imposti gruppi come Ansar Dine (“i difensori della fede”) e al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQIM). Se il primo è comunque composto per lo più da combattenti Tuareg, il secondo costituisce una delle componenti più significative delle rete che farebbe riferimento ad al-Qaeda e fra le proprie file conta anche uomini stranieri, fra cui molti algerini. È su questa formazione che si è concentrata l’attenzione internazionale, a causa del fatto che tramite la presenza sempre più pervasiva di AQIM, l’Azawad potrebbe divenire un nuovo terreno fertile per il reclutamento e l’addestramento delle nuove leve del network terroristico, oggi che le roccaforti di al-Qaeda nella regione dell’AfPak, in Somalia e in Yemen sembrano sempre più sotto pressione. Unite alle testimonianze di un inasprimento delle condizioni di vita della popolazione locale a causa della sempre più rigorosa applicazione della legge islamica da parte delle forze ribelli, tali preoccupazioni hanno portato gli attori regionali ad interrogarsi sul percorso da intraprendere per un’efficace risoluzione della crisi.
Le opzioni sinora esplorate sono sostanzialmente due: la proposta di negoziati con le formazioni più moderate e la predisposizione di un intervento militare internazionale, a sostegno delle esigue capacità di Bamako. Per quanto riguarda il primo aspetto, il focus è concentrato su Ansar Dine, ritenuta la più malleabile fra le forze islamiste sul campo e, soprattutto, quella più legata alle tradizionali rivendicazioni della popolazione Tuareg. Delegazioni di tale formazione hanno incontrato il Presidente del Burkina Faso, Blaise Compaorè, e si sono recate in Algeria, un attore fondamentale per gli equilibri regionali. Il 13 novembre, inoltre, rappresentanti dello stesso gruppo islamista e di MNLA hanno incontrato a Ouagadougou il rappresentante dell’ONU in Africa Occidentale, Saïd Djinnit. Entrambe le parti hanno espresso il proprio reciproco impegno per un dialogo proficuo.
Figura centrale in questo intricato gioco diplomatico appare Iyad ag Ghali, il leader di Ansar Dine, che sarebbe mosso, secondo fonti citate da The Economist, più che dal proprio zelo islamico, dalla volontà di ribadire il proprio ruolo di spicco fra le tribù che hanno un ruolo cruciale nella gestione degli apparati istituzionali nella regione. Un tratto, quello dell’uso personalistico delle strutture statali, caratteristico del sistema patronale e neopatrimoniale di molti Stati africani. La regione, infatti, costituisce uno snodo importante per molti traffici illegali che uniscono il Mediterraneo all’Africa sub-sahariana, senza considerare i progetti per unire potenze energetiche come la Nigeria e l’Algeria. Il controllo su di essa è particolarmente allettante per i big men sul territorio.
Al di là di tali speculazioni, la risposta più diretta (anche se non necessariamente essa si rivelerà tale nella pratica) è giunta dall’ECOWAS (Economic Community of West African States), l’organizzazione regionale di cui è membro il Mali e che ha accumulato nel passato una buona tradizione in materia di interventi nelle varie crisi regionali, in Liberia (1990 e 2003), Sierra Leone (1997), Guinea Bissau (1998) e Costa d’Avorio (2003). Tramite lo strumento dell’ECOMOG (ECOWAS Ceasefire Monitoring Group), l’organizzazione si è dotata di capacità d’intervento significative, nonostante rimangano pressanti i vincoli derivanti dallo scarso finanziamento delle missioni da parte dei Paesi membri e dal ruolo giocato dall’egemone regionale, la Nigeria.
Il caso del Mali non esula da tale casistica. L’11 novembre, un summit dei capi di Stato dell’ECOWAS, a cui hanno partecipato anche rappresentanti di altri attori regionali come Algeria e Mauritania, ha espresso un accordo di base circa l’invio di una missione militare africana a sostegno delle forze di Bamako. Si ritiene che tale missione conterà circa 3000 uomini messi a disposizione dal Mali e altri 3000 dagli altri membri dell’ECOWAS. L’effettivo impegno dei Paesi della regione, però, appare tutt’altro che scontato. Innanzitutto, le missioni dell’ECOWAS sono state spesso interpretate come uno strumento utilizzato dalla Nigeria, che ne è il primo contributore in termini di personale e finanziamenti, per ribadire la propria egemonia regionale. Inoltre, in questo caso è l’Algeria ad essersi espressa contro un eventuale intervento, intimando al governo di Bamako di rafforzare gli sforzi per un dialogo più approfondito con i ribelli. Infine, sussiste sempre nei governanti africani una certa diffidenza di fondo nei confronti di azioni che mettano in dubbio la sovranità statale, anche se il rigido principio di non indifferenza dei tempi dell’OUA è stato superato.
In ogni caso, è stato il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con una risoluzione approvata all’unanimità il 12 ottobre, a premere per una soluzione regionale, riflettendo allo stesso tempo le preoccupazioni statunitensi circa la proliferazione delle reti terroristiche e la volontà francese di giocare ancora un ruolo centrale nella regione. Parigi, in effetti, appare un attore cruciale, dato che non ha mai rinunciato ai legami post coloniali con gli ex possedimenti e continua a considerare l’Africa Occidentale, dove si concentravano molte delle colonie francofone, come un’area su cui esercitare la propria influenza da grande potenza, ancora nel 2012.
Sarebbe stato il governo francese a premere su Bamako perché il dialogo con i ribelli non fosse approfondito eccessivamente. Nonostante il Presidente Hollande abbia affermato che “in nessun caso” la Francia interverrà direttamente in Mali, la missione dell’ECOWAS sarà probabilmente supportata da specialisti e personale civile fornito dalla Francia e, forse, dagli Stati Uniti. Il modello d’intervento perseguito da Parigi appare essere quello applicato in Libia nel 2011, sebbene in questo caso non dovrebbe essere impiegata un’azione diretta. Tuttavia, la Francia gioca un ruolo di prima fila a sostegno dei propri clienti nella regione, lasciando, ad oggi, in disparte gli Stati Uniti e bilanciando il peso della Nigeria, almeno dal punto di vista diplomatico.
L’incertezza in ogni caso regna tuttora intorno a questa missione e più in generale in riferimento alla risoluzione dell’intricato puzzle maliano. Non sono innanzitutto chiari i tempi dell’intervento, che in teoria dovrebbe svolgersi nei primi mesi del 2013. Tale ritardo, tuttavia, non fa che ridurre le speranze della popolazione maliana. Per di più, non sono chiare le modalità: si tratterà di una missione di peace-keeping in piena regola o di un intervento, in particolare da parte del personale occidentale, di ‘mero’ addestramento dell’esercito del Mali? Se la Francia si è fatta portavoce delle ragioni di un intervento diretto da parte dei suoi alleati regionali, il coordinatore dell’Unione Europea per la lotta al terrorismo, Gilles de Kerchove, interpellato da Le Monde, ha perorato la seconda ipotesi, specificando che “la riconquista del Nord è un affare maliano”. Aggiungendo alle incertezze europee le diverse sensibilità fra i membri dell’ECOWAS e gli altri Stati della regione, la risoluzione della crisi in Mali non sembra essere dietro l’angolo.
* Luca Barana è Dottore in Scienze Politiche (Università di Torino)