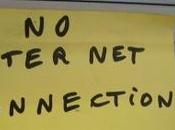Arrivai a Bologna, per la prima volta, in una calda e umida serata di fine estate. Avevo deciso di lasciare il Sud, la mia terra di origine, perché credevo mi avesse tradito.
Che avesse tradito i miei sogni, le mie speranze, la mia voglia di fare e realizzarmi. Col tempo, avrei capito che a tradire un passato fatto di certezze e verità, in fondo, ero stata io, nell’istante stesso in cui avevo, a livello sotterraneo, messo in crisi le mie stesse origini e ciò che, intorno, mi era stato sapientemente costruito per proteggermi dall’impeto della Vita.

Appena scesa dal treno, confusa e stanca, rammentai un passaggio di un’intervista a Fellini, letta anni prima, in cui il regista raccontava della sua surreale abitudine, in gioventù, di perlustrare, degnamente coperto da fidati compagni di scorribande, non luoghi ordinari, oggetto del comune interesse giovanile, ma quello insolito e silenzioso e raccolto dei cimiteri, in serate offuscate dalla nebbia della Val Padana, dove tutto è e non è, dove il tempo si perde e diventa solo una convenzione, dove il luogo diventa sogno smaterializzandosi e dove può capitare di imbattersi in strani fenomeni che di allucinato hanno poco, se nulla di reale a cui ancorarsi è intorno, quali vedere chi ha già esaurito il suo percorso terreno e che, per qualche istante, decide di fare capolino, giusto a rammentare, a chi vuol crederlo, che vita e morte sono livelli diversi di uno stesso gioco.
Quella scena onirica, nell’immaginario e nei ricordi del regista nato in terra romagnola, non mi era, a ben guardare, per nulla sconosciuta.
E non solo perché pensavo che fosse la trasposizione a parole e nel reale di quanto egli aveva tracciato sapientemente nel dialogo tra un figlio annoiato dalla Vita e disilluso e un padre fantasma, nel film “Otto e mezzo”, di fronte alla cui scena, prima di quel giorno, fui costretta a lasciare la sala di proiezione, ma anche perché, dentro, sapevo che la capacità di andare oltre il confine netto e distinto del reale razionale, in qualche modo, doveva essere mia e faceva paura.
In fondo, senza paura, in quella sala sarei rimasta e avrei guardato non solo lo schermo, ma anche me.
Lasciai il sole al Sud e, insieme al sole, la mia famiglia, la grande casa della mia infanzia e una quantità infinita di ricordi. Non tutti esattamente belli, ma tutti fortemente miei. Sapevo o, meglio, credevo di sapere esattamente cosa stavo lasciando, in cambio di un futuro dai contorni incerti. Il tempo mi avrebbe, infatti, aiutato a portare alla luce pezzi di storia familiare non esattamente idilliaci, mi avrebbe aiutato ad essere giudice, terzo e imparziale, di una storia difficile.
Non so esattamente perché scelsi Bologna. L’università, la cultura, l’attenzione per il diverso, i colori, le luci che accompagnano il viaggiatore solitario, durante le ore notturne, nel percorso tracciato e protetto dai portici di questa città… Certo è che, in un momento di fuga, ogni luogo può andar bene, ma diventa tuo solo quando hai cessato di fuggire e provato a guardarti dentro, rimanendo fermo solo fisicamente, perché il viaggio, quello vero, lo stai portando avanti dentro, tra fiamme e luoghi non proprio celestiali.

Mi sono sempre chiesta che cosa sarebbe accaduto, se anche io fossi stata quella giusta.
Forse, nulla sarebbe cambiato o, forse, avrei avuto quella sorta di serena accettazione di me, che ancora manca, nei limiti in cui i desideri, i miei e i loro, quelli della mia famiglia, fossero confluiti in un unico calderone. Ad ogni modo, nel viaggio verso la stazione, seppi trattenere il desiderio di piangere. Mio padre ne sarebbe stato orgoglioso. Davanti a lui, vietato piangere.
Così, nel tempo, quando Bologna mi aiutò a tirare fuori un po’ di roba nascosta, nei miei successivi rientri a casa, mio padre dovette rassegnarsi a fare i conti con una tale quantità di acqua, con cui avrei potuto sommergere la grande casa di infanzia e, magari, renderla più limpida e trasparente, perché, a nascondere le emozioni, si finisce nel buio e nella desolazione, nell’ottusità e nell’opaco di chi ha paura di se stesso e delle proprie umane fragilità. Dal giorno della partenza sono trascorsi parecchi anni e il viaggio continua. Tra sconfitte e conquiste, tra perdite e vittorie. Le più importanti sono quelle che conosco solo io, perché, con gli anni, ho capito che quel giorno in cui decisi di lasciare il Sud avevo deciso “semplicemente” di crescere.