
Trascrizione a cura di Daniel Iversen
Capire come il cervello intuisce quello che pensano gli altri serve a Rebecca Saxe per progettare possibili soluzioni a conflitti politici e sociali che sembrano senza speranza
Intervista di Gareth Cook
dalla rivista “Le Scienze“, edizione italiana di “Scientific American“
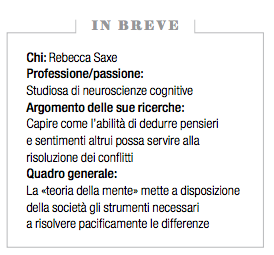

Rebecca Saxe, 33 anni, del Massachusetts Institute of Technology, lavora in un campo di ricerca che mira a capire meglio questa capacità, nota come «teoria della mente». È riuscita stabilire che questa capacità del pensiero è centrata in una regione del cervello, la giunzione temporo-parietale destra. La scoperta ha sorpreso gli esperti di neuroscienze, perché la teoria della mente è una capacità astratta e complicata, del tipo che si sarebbe detto dovesse coinvolgere ampie porzioni della corteccia. E invece, secondo Saxe, proprio questa piccola sezione del cervello, giusto dietro l’orecchio destro, è alla base di buona parte di quello che associamo con l’essere un essere umano: conversazione, amicizia, amore, empatia, moralità. E arte: la teoria della mente è il motivo per cui gli esseri umani scrivono romanzi, e li leggono. Il curriculum di Saxe sottolinea le sue credenziali nelle neuroscienze, ma la si potrebbe classificare altrettanto bene tra i filosofi. Cresciuta nell’Ontario, in Canada, è poi andata a studiare all’Università di Oxford, ancora incerta sulla strada da seguire. Fra gli strumenti di cui si serve oggi ci sono computer e dispositivi di scansione cerebrale, ma le domande sono quelle di sempre. Che collegamento c’è tra la nostra capacità di dedurre quello che pensano gli altri e quei 1300 grammi di materia che chiamiamo il nostro cervello? Qual è il rapporto tra idee ed esperienza?
Il laboratorio di Saxe ha iniziato ricerche di vasta portata su linguaggio, ragionamento morale, autismo, ragionamento causale e sviluppo del cervello. Ma la sua particolare passione è la risoluzione dei conflitti. Insieme al collega Emile Bruneau, la scienziata spera di scoprire perché la nostra teoria della mente è inadeguata quando pensiamo a un nemico, e come la comprensione di questa insufficienza potrebbe servire a guarire le ferite di una società divisa. Le nostre capacità di lettura della mente altrui sono già buone, dice Saxe, ma se potessimo migliorarle anche il mondo sarebbe migliore. Di seguito, alcuni brani della nostra conversazione.
Come è accaduto che la sua passione per la scienza l’ha condotta a studiare il cervello?
Da sempre, per quanto posso ricordare, sono affascinata dall’idea che le cose che per noi contano di più siano fatte a partire da semplici e minuscole parti comprensibili. Da ragazzina mi interessava il modo in cui atomi e molecole costituiscono tutto quello che abbiamo intorno, e quindi volevo studiare chimica. Poi ho iniziato a interessarmi alle parti, chimiche e cellulari, di cui è fatto il nostro corpo, e volevo fare la biologa.Arrivata ai 16 o 17 anni, la cosa che più mi entusiasmava era il cervello. Da una cellula che manda segnali elettrici a un’altra cellula si può costruire la nostra mente, i nostri pensieri, le nostre esperienze coscienti. A volte si dice che i due problemi fondamentali della scienza sono l’origine dell’universo e la struttura della mente. Di tutti e due ci si può innamorare, e per gli stessi motivi.
Come ha scelto il suo attuale campo di studi nelle neuroscienze?
Uso le neuroscienze per studiare negli esseri umani quello che non si può studiare negli altri animali, cose come linguaggio e moralità. Le parti del nostro cervello che comprendiamo meglio sono quelle che abbiamo in comune con gli animali, e sono principalmente quelle legate ai segnali in entrata e in uscita. Per esempio, come facciamo a dividere e ricomporre una scena in parti chiare e scure, o in tavoli e divani? Il nostro sistema visivo ha molto in comune con quello di gatti e scimmie, e sul modo in cui funziona abbiamo elaborato teorie accettabili. Lo stesso vale per il controllo dei movimenti, che le neuroscienze studiano dalla fine del XIX secolo. Tutto questo è incredibilmente importante, e a volte trovo allettante il fatto di lavorare in qualche area delle neuroscienze che sia già ricca di conoscenze. C’è qualcosa di molto soddisfacente nel conoscere bene un sistema e aumentare queste conoscenze in un programma di ricerca. Ma a sedurmi è stata l’altra strada, quella che porta agli aspetti della mente e del cervello di cui sappiamo meno.
È questo che l’ha spinta a cercare di capire la cosiddetta «teoria della mente»?
Sì, è un problema profondo e fondamentale, e del tutto aperto. Ma l’altra cosa che mi attira della teoria della mente è il fatto che ha tante possibili applicazioni. Ci sono applicazioni cliniche per persone con disturbi della cognizione sociale come autismo e ansia sociale. Molti fra i disturbi dello sviluppo del sistema nervoso che conosciamo di meno hanno aspetti sociali. Per gestire bene la nostra società c’è bisogno di capire in che modo funziona la mente. Dobbiamo capire noi stessi e gli altri, e come pensiamo agli altri. Dobbiamo coordinare le varie società in modo che possano funzionare insieme. E non riusciremo mai a farlo bene se sbagliamo sistematicamente a capire ciò che hanno in mente gli altri. Per esempio, nel mondo si dedicano grandi sforzi alla risoluzione dei conflitti. Ma sono in larga misura basati su teorie della mente puramente intuitive, nozioni di senso comune su come funzionano gli altri, su che cosa può spingerli a cambiare idee e comportamenti, su che cosa provoca conflitti e che cosa li può amplificare.Queste teorie della mente intuitive sono piuttosto buone, come abbastanza buona è la nostra fisica intuitiva, quella che ci consente di colpire al volo una palla da baseball. Ma per alcune applicazioni «piuttosto buona» non basta. Se uno cercasse di andare sulla Luna con la fisica intuitiva, mancherebbe il bersaglio. Nella risoluzione dei conflitti, a volte ho la sensazione che stiamo cercando di andare sulla Luna, e sbagliamo mira.
Come ha cominciato a lavorare sulla risoluzione dei conflitti?
Quando ho cominciato ad allestire il mio laboratorio, ho ricevuto una e-mail da Emile Bruneau, dottorando dell’Università del Michigan. Mi diceva che la sua passione era capire in che modo le persone cambiano opinione sugli altri, e in che modo si risolvono i conflitti. Diceva: «Credo che sia un problema profondo, che ha disperatamente bisogno di essere affrontato in termini scientifici, e credo che le neuroscienze possano essere di aiuto. Gli ho risposto dicendo: «Tu sei matto. Quel che proponi probabilmente non è possibile». Dopo aver parlato con lui, però, sono arrivata alla conclusione che era davvero un problema molto importante, e che Bruneau era una persona spinta da una visione del problema. Onestamente, sono cinque anni che stiamo in questo campo e continuo a non sapere quanto, in fin dei conti, si riveleranno utili le neuroscienze. Ma Emile pensa a questi problemi 24 ore su 24, quando è sveglio e quando dorme, che stia lavorando oppure no. Questa è la cosa che lui vuole fare nel mondo, e questo è il genere di persona con la quale si vorrebbe lavorare.
Che cosa possono dare le neuroscienze alla risoluzione dei conflitti?
Pensiamo per esempio al pregiudizio. Ci sono molti motivi per cui le persone ti dicono di non avere pregiudizi. Non vogliono essere prevenuti; e sanno bene che la risposta giusta è dire di non avere pregiudizi. Spesso le persone non sono neppure consapevoli dei propri pregiudizi. Quindi c’è un problema: come si fa a misurare e modificare una cosa di cui le persone non sono neppure del tutto consapevoli, che non vogliono ammettere e che sono motivate a tenere nascosta? Sarebbe molto meglio se si potesse trovare un modo di misurare cose come i pregiudizi in modo diretto, ed è qui che entrano in gioco le neuroscienze. Se potessimo capire il meccanismo che c’è dietro nel cervello, potremmo misurare i pregiudizi, invece di chiedere alle persone di dirci se ne hanno. Quindi, se potessimo misurare i pregiudizi avremmo un metodo più accurato per mettere alla prova i diversi approcci alla risoluzione dei conflitti. Potremmo semplicemente verificare il livello dei pregiudizi delle persone prima e dopo diversi tipi di intervento, e vedere quale di essi è il migliore. Questi obiettivi sono assai lontani. Ma penso che quello che avviene nei conflitti sia un complesso e insidioso insieme di pregiudizi nel modo in cui una parte considera le emozioni e le motivazioni dell’altra. Ognuna delle due parti pensa che l’altra sia spinta dall’ideologia, non da qualche ragione, o che capisca soltanto il linguaggio della violenza. Questi elementi di teoria della mente sono essenziali, ma relativamente trascurati.
Può spiegare il suo studio su quello che chiama <<dare la propria posizione>>?
Il nostro obiettivo era applicare un approccio scientifico allo studio del dialogo: quello che succede quando due persone delle due parti in conflitto hanno la possibilità di parlare delle proprie delle due parti in conflitto hanno la possibilità di parlare delle proprie vedute e delle proprie esperienze. Molti programmi di risoluzione dei conflitti ontano sul dialogo, ma ci sono pochi studi scientifici che ci dicono se funziona o meno.
La nostra idea è che nel dialogo ci sono due aspetti. In uno si ascolta il punto di vista dell’altro, si riceve la posizione altrui. Nell’altro si è la persona che viene realmente ascoltata: noi diciamo che si dà la propria posizione. In numerosi conflitti, inoltre, uno dei due gruppi è più forte dell’altro. Noi ipotizziamo che gli effetti del dialogo possano non essere simmetrici.
Abbiamo studiato due coppie di parti in conflitto – palestinesi e israeliani, e immigranti messicani e bianchi dell’Arizona – e nell’atteggiamento delle persone del gruppo relativamente meno forte si vedevano positivi miglioramenti solo quando si trovavano nel ruolo di chi dà il suo punto di vista, quando erano loro a spiegare la propria posizione. Per queste persone non c’era nulla di buono nel dovere ascoltare il punto di vista di una persona relativamente dominante. Per il gruppo dominante, invece, i massimi benefici del dialogo venivano dal ricevere il punto di vista dell’altro, dall’ascoltare l’altra parte.
Non vogliamo suggerire che i programmi di dialogo debbano essere completamente asimmetrici, una parte che parla e l’altra che ascolta e basta. Ma è importante capire che parlare e ascoltare possono dare risultati diversi per i diversi gruppi. Ho sentito, per esempio, di uno studio non pubblicato di Philip Hammack, dell’Università della California a Santa Cruz, che riguarda quello che accade nelle conversazioni tra arabi e israeliani. Hammack e colleghi hanno notato che gli israeliani parlano molto di più degli arabi. Se quando parlano gli arabi c’è un beneficio per tutti, come minimo si dovrebbero adottare meccanismi con cui cercare di aumentare la probabilità che lo facciano.
E’ possibile che questa stessa idea valga anche per le reazioni personali ?
Sì, nel senso che nella misura in cui uno nel rapporto è in posizione di forza dovrebbe sforzarsi di mettersi in ascolto, per ottenere nuove informazioni e sentire qual è il punto di vista dell’altro. Per una persona in svantaggio, l’esperienza di essere ascoltata può servire a smontare barriere e sbloccare situazioni negative.
Ci sono altri aspetti di questo lavoro che potrebbero valere a un livello più personale?
Un’altra cosa su cui stiamo lavorando è il modo in cui le persone ragionano sulle argomentazioni con cui non sono d’accordo. L’obiettivo dei programmi di risoluzione dei conflitti non è necessariamente cambiare ciò che pensano le persone. Vogliamo solo che vedano la potenziale validità dell’altra parte.
Vorremmo capire meglio tutto questo: la differenza fra non essere d’accordo su qualcosa per una reazione immediata che dice che è assurda e non esserlo ma capendo da dove arriva.
Certo che oggi questa sembra una questione dall’ordine del giorno, negli Stati Uniti …
Sì, ce ne stiamo occupando adesso. Gli Stati U niti sono arrivati a un punto di particolare faziosità nella loro storia. Ci interessa il modo in cui le persone ragionano sulle argomentazioni – o sulle persone – della parte opposta alla propria riguardo a grandi questioni come l’ambiente e il matrimonio fra omosessuali.
Non stiamo cercando di capire perché le persone siano a favore o contro il matrimonio fra omosessuali. Vogliamo vedere se riusciamo a far loro cambiare idea sul perché qualcun altro possa pensarla diversamente. Tante persone sembrano dire che il solo motivo per cui gli altri possono avere un’opinione diversa dalla loro è che sono immorali, o pazzi. E’ questa sensazione per cui devi essere pazzo se non sei d’accordo con me che potrebbe valere la pena di cambiare, o almeno provarci.
Teorici della mente
Intervista di Gareth Cook (Le Scienze , 534 febbraio 2013)
Gareth Cook, premiato con il premio Pulitzer e titolare di una rubrica sul <<Boston Globe>>, dirige la sezione Mind Matters di <<Scientific American>>.
Per approfondire.
Looking for Empathy in a Conflict-Ridden World.
Bjoran K, 18 maggio 201. http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2011/05/18/looking-for-empathy-in-a-conflict-ridden-world
Live Webcast: Xenophobia – Why Do We Fear Others? Redazione di «Scientific American» (a cura), 31 marzo 2012. www.scientificamerican.com/article.cfm?id=live-webcast-xenophobia

Questo opera è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.







