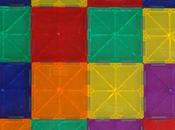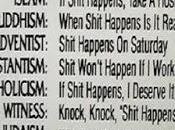Ci incontrammo al bar come eravamo soliti fare fin dai tempi della scuola. Prendemmo un caffè, io doppio e amaro, lui macchiato freddo. Lo sorseggiammo con calma, poi uscimmo e ci accendemmo una sigaretta. Prima io, poi lui.
Cominciava a rinfrescare – era quasi dicembre – ma l’inverno non sembrava aver ancora abboccato alla lenza del calendario. Tirava appena un brivido di vento rinforzato di tanto in tanto dal passaggio di autobus di linea, tristi e musoni come coleotteri affaticati. “Novembre è un mese che non mi è mai dispiaciuto” disse lui. “D’improvviso tutto si svuota. È sempre la stessa città. Ci abita sempre lo stesso numero di persone. Eppure d’un botto pare che non ci sia più nessuno. È buono per tornare a mettere a fuoco le cose.”
Avevo sempre avuto il medesimo pensiero. A ottobre ancora trovavi gente che si ritagliava gli ultimi angoli di mare tra i temporali, c’era l’eccitazione delle scuole che ricominciavano a funzionare a pieno regime, gli uffici pieni, il paese che pareva mettersi nuovamente in marcia. Ma a novembre d’improvviso tutto si arrestava. Tutto pareva placarsi. Ci dovevano pensare le luci di Natale a risvegliare qualcosa – un eccitamento, una frenesia assopita, un entusiasmo, cosa esattamente non l’avrei saputo dire – nelle persone.
Io ero diverso. Io avevo sempre un’inquietudine dentro.
Lui fumava con lentezza.
Guardavamo davanti a noi la strada sgombra e il marciapiede sommerso di foglie. Alcuni vecchi erano seduti su una panchina accanto alla fermata dell’autobus di fronte. Li stavo osservando da tempo, erano sempre lì a qualsiasi ora del mattino o del pomeriggio. Passavano giornate intere senza rivolgersi il fantasma di una parola. Me l’ero sempre chiesto come facessero gli anziani a stare così a lungo in silenzio gli uni accanto agli altri. Sempre con quella stessa espressione di chi sta guardando un film a cui nessun altro in quel momento è stato invitato.
I-m-m-o-b-i-l-i.
E mi sentivo come se d’un tratto fossi divenuto anch’io come loro. Mi sentivo come se anch’io d’un tratto mi fossi ritrovato davanti a uno schermo. Ma era uno schermo vuoto quello che stavo vedendo. Un grande e bianco e muto telo dove da anni scorrevano i titoli d’inizio, e i titoli d’inizio, e i titoli d’inizio di un film che non si voleva mai decidere ad iniziare. E allora mi domandavo se non fossero davvero i titoli d’inizio quelli che anche i vecchi stavano guardando. Non il finale. Non il film. Ma l’attesa sempre più prossima della sua proiezione.
Fumammo. Il tabacco era come parlare. E non ci pesò finire le sigarette senza interrompere quella nostra conversazione.
Ci aveva raggiunto Michelino l’elettricista, era appena uscito dal lavoro, si sedette e cominciò a raccontare della casa in cui era stato quel pomeriggio, e della casalinga che ci viveva dentro e “poi fanno bene a dire che alle volte lo stupro se lo vanno a cercare” disse. Lo diceva scherzando. Ma c’era un ché d’impercettibilmente serio nel suo discorso. Un retro del verso che rendeva le parole ambigue, e finiva per appiccicarle più al retro che al verso di quello che voleva dire.
Questa casalinga l’aveva accolto in minigonna e non aveva fatto altro che girargli attorno, avanti e indietro per tutto il pomeriggio, mentre lui cercava di montare alcune lampade da muro nel corridoio della casa. “A un certo punto volevo chiederglielo, se gradiva che montassi un po’ anche lei” disse ridendo.
“Adesso perché hai imparato ad avvitare due lampadine” intervenne il mio amico “non devi credere che sia lo stesso anche con le donne. Le femmine vivono di tutta un’altra elettricità.”
Stavolta fui io a sorridere.
“Buona era buona” continuò lui come se nessuno avesse ancora detto niente, “secondo voi dovevo provarci? Dite che ci stava?”
“Non credo” disse il mio amico.
“Neanch’io” aggiunsi.
“Quella però era in minigonna in casa. E sculettava avanti e indietro. Mi chiedeva vuole un caffè? Gradisce un bicchiere d’acqua? Te la do io l’acqua. Sai che c’è un elettricista che ti arriva in casa, e ti metti la minigonna. Vuol dire che sei una troia” disse.
“E tu un pervertito” disse il mio amico. “Stava in minigonna, mica era nuda. Guardati, sei in canottiera ed è novembre, starai mica cercando di sedurci?”
“Mia sorella se le metteva sempre le minigonne in casa, e non credo volesse trombarsi i miei genitori” aggiunsi.
Ridemmo insieme. Michelino ci pensò un po’ su, poi non convinto salì sul camioncino e mise in moto. “Secondo me” disse andandosene “ci stava.”
“Magari la prossima volta” gli gridò dietro il mio amico, cominciando ad arrotolarsi una nuova sigaretta. “Capirai” aggiunse sottovoce, “casalinghe disperate, ma non fino a questo punto.”
Ci si era radunato attorno un gruppetto male amalgamato di gente. Chi usciva dal lavoro, chi non c’era mai andato, chi parlava della domenica di calcio e del sabato sera precedente. Chi ricordava qualcosa che qualcun altro aveva fatto, ubriaco, alcune notti prima. C’era una sorta di eccitazione forzata e stanca a premerci addosso. Come una strada senza sbocco in cui nessuno aveva più voglia di camminare, ma in cui tutti continuavano senza entusiasmo ad affluire. Un tempo ci sarebbe stata una magia nell’aria, in momenti come questo, un’energia che dilatava gli occhi e chiedeva di divorare il mondo.
Adesso più persone arrivavano e più sentivo crescere in me la solitudine.
Era la riproposizione del giorno prima, e della settimana prima, e dell’anno prima, eppure in quel ripetersi non riuscivo più a scovare alcuna poesia.
La poesia non va scovata mi dicevo. La poesia c’è. Ma per vederla fuori, prima devi sentirla dentro. E dentro cosa sentivo?
Lontananza.
Mancanza dei miei amici, innanzitutto – quelli che non riconoscevo oramai da troppo tempo anche se li incontravo per strada tutti i giorni – ma soprattutto lontananza dalla vita. Forse una persona è, veramente, mi venne da riflettere, solo in determinati attimi della propria esistenza. Il resto sono solo oscillazioni, sono fremiti, ricerche d’equilibri e distanze che si allungano fino a non poter più essere colmate. E in quelle distanze, nel vuoto di una di quelle lunghissime oscillazioni, mi trovavo in quel momento io. A terra. Mentre avrei voluto essere in alto mare, con le vele spiegate e il vento di traverso, e nient’altro che una sensazione d’infinita pienezza a risalirmi nel petto.
Meno la coltivi la vita, mi ripetevo, e quella meno ti cresce attorno.
Pian piano tutti se ne andarono, come sempre facevano, sparendo uno dopo l’altro in qualche anfratto di cui oramai ignoravo ogni cosa.
Rimanemmo soli io e il mio amico. I vecchi avevano lasciato la panchina, gli autobus si erano fatti più radi. Qualcuno dentro il bar stava ancora litigando sull’arbitraggio della domenica precedente.
“Quando eravamo al liceo” mi ascoltai a quel punto dire “sognavo sempre che un giorno avrei vissuto in una grande città davanti all’oceano. E avrei fatto surf tutte le mattine con la bassa marea, prima di andare a lavorare. Non importava troppo il lavoro. Quello che davvero importava era l’oceano.”
Il mio amico taceva.
“La città era grande e piena di luci. Qualcosa di vivo e vibrante e colmo di aspettative. E la casa sorgeva appena fuori, in uno dei quartieri sulla spiaggia, come sui margini di un deserto. E la spiaggia” continuai cercando di affilare quell’immagine che adesso sentivo palpitarmi nella testa, “sarebbe stata una di quelle che vedi alle volte nei film, bianca e vuota, e potenzialmente senza fine. Sarei uscito dall’acqua e avrei trovato la mia donna ad aspettarmi sulla veranda, avvolta in una coperta con una tazza di caffè tra le dita sottili, e gli occhi pieni dell’immensità che le stava davanti.”
Tacqui anch’io per alcuni istanti.
“So che alcuni non ce l’hanno un sogno così. Altri magari ce l’hanno ma non credono che esistano luoghi del genere. Altri ancora credono che la vita sia una cosa e i sogni un’altra, ed è meglio lasciarli separati. Ma io che un sogno così ce l’ho avuto, e che so che un luogo del genere esiste, e che credo che non bisogna separare ciò che è da ciò che potrebbe essere, io dovrei smetterla di stare qui ad aspettare e dovrei ricominciare a sognare” dissi.
La luce era scesa. I lampioni ancora stentavano ad accendersi. E per un momento, ci trovammo sprofondati in quella che gli americani chiamano twilight e gli italiani crepuscolo. Dando, gli italiani, un senso di “fine” alla parola che in inglese non ha. E che in quel momento non volevo vedere.
T-w-i-l-i-g-h-t ripetei aprendo le vocali come fossero ali: il territorio di mezzo che non appartiene a nessuno e in cui tutto può succedere. Non più giorno, non ancora notte.
Vidi il mio amico annuire con gli occhi.
L’ultima cosa che mi era rimasta in quella città, era il suo sguardo.