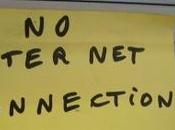Mary Shelley (1797-1851)
VALPERGA
o
La vita e le avventure di Castruccio, Principe di Lucca
Traduzione integrale di Marco Vignolo Gargini dall’originale in inglese Valperga; or the Life and Adventures of Castruccio, Prince of Lucca
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Capitolo 14
La corte di Eutanasia continua. Arriva Pepi.
Castruccio non aveva partecipato agli intrattenimenti del giorno essendo tornato a Lucca e avendo riunito il consiglio per deliberare su una questione spinosa della politica lucchese. Risolto quest’affare importante, risalì a cavallo e si diresse lungo la solita strada per il castello di Valperga. Appena uscito dalla porta della città udì una voce dietro di lui che lo chiamava e, fermando il cavallo, vide avvicinarsi al gran trotto Benedetto il ricco di Cremona. Riconobbe subito, nonostante la distanza, il vecchio compagno di viaggio per i suoi abiti dimessi ancora non cambiati, le grandi spalle, strette dietro e piegate sulle ginocchia. Pepi, accostandosi con un umile saluto, disse che aveva degli affari importanti da comunicare al nobile console di Lucca e lo pregò di ascoltarlo.
«Volentieri», disse Castruccio, «Sto andando a quel castello lassù. Mi accompagnerete, parleremo strada facendo e quando saremo là troverete ospitalità come me.»
«Allora dovrete frenare il vostro destriero», disse Pepi, «perché il mio galoppa a malapena dopo il duro viaggio del giorno.»
Viaggiarono insieme, Pepi sembrava oppresso da un grave segreto che desiderava rivelare, pur non sapendo come. Lodava le fortificazioni di Lucca, la fertilità della sua pianura e le montagne, quelle barriere naturali contro le incursioni nemiche. Prese una pausa, tossì, rimbrottò il cavallo e cadde in silenzio.
«Ora», chiese Castruccio, «Qual è quell’affare importante di cui mi volete parlare?»
«Ah! Messer lo Console [1], è una questione di tale importanza che non so come rivelarla. Mi sembrate in uno stato d’animo troppo gioioso per ascoltare con l’attenzione necessaria, tanto che per il momento farò a meno di affrontarla.»
«Come volete. Ma quando arriviamo al castello troveremo un piccolo pretesto per parlarne, perché laggiù il divertimento e l’allegria sono all’ordine del giorno.»
«Allegria! Beh, forse sarà un bene per il mio cuore rivedere ancora dei volti felici. Ne ho visti così pochi da quando siete stato sul torrione del mio palazzo. Cremona non s’è ancora ripresa dal feroce assedio, molti dei suoi palazzi sono ancora in cenere e molti acri buoni e fertili sono stati venduti a prezzi stracciati, per ornare le spoglie dimore così com’erano un tempo. Anche se i guelfi hanno di nuovo avuto la meglio, i miei concittadini sono orgogliosi, ribelli e non hanno imparato dalle loro disgrazie l’umiltà dei poveri, che in un suddito è meglio dell’insolenza della prosperità. Se io fossi un principe, tutti i miei sudditi dovrebbero essere poveri, ciò li renderebbe obbedienti verso il loro padrone e audaci verso i nemici, sulle cui rovine dipende la loro ricchezza. Ma, ahimè! l’uomo è così ostinato nella sua malvagità che, come vediamo a Cremona, la fame, il fuoco e il massacro non ce la fa ad addomesticare il loro spirito fazioso.»
«Ah! Messer Benedetto, siete sempre lo stesso. Non avete cambiato vestito né opinioni dall’ultima volta che vi ho visto. Sempre immerso nella politica.»
«Veramente, mio buon signore, sono più che mai immerso nei casi politici e in quello della necessità, come capirete quando sentirete ciò che ho da dirvi. Ah! I cremonesi sono ancora orgogliosi e invece dovrebbero essere umili. Anche un piccolo potere adesso può facilmente sopraffarli, dato che pensano più a come ripiantare i loro vigneti arsi che ad opporsi al legittimo principe. I sovrani muovono guerra in un modo stranamente dispendioso quando prendono le armi e le flotte contro un paese. Mentre tutti in città dormono nei loro letti, una dozzina di baldi individui con i tizzoni ottengono il massimo come centomila uomini armati in pieno giorno. L’incendio tempestivo dei raccolti è un castigo migliore per i ribelli di un esercito alla guida di tutti i sovrani d’Europa. Sono sempre stato un ammiratore dei guerrieri ebrei che mandavano le volpi con le torce attaccate alle code in mezzo ai campi di grano del nemico. Queste sono astuzie belliche così poco considerate, ma che sono di un inestimabile vantaggio.»
«Messer Benedetto, ascolto con ammirazione la vostra saggezza, ma fidatevi della parola di un amico e non parlate così apertamente lassù al castello, oppure, se adesso non siete in grado di frenare la vostra lingua, prendete il vostro cavallo e tornate a Lucca. Là ci sono dei guelfi.»
«Strana compagnia per inserirmi. A Cremona non mi sono mai imbattuto in un guelfo, chiunque potesse essere. Ma se voi, mio sire, siete prudente, lo sarò anch’io di sicuro e abbiate fiducia in Benedetto Pepi per la sua discrezione. Ritengo che voi siate mio amico e un ghibellino e, da signore di questo nobile paese, potete ben giudicare la veridicità delle mie osservazioni. Sono contento di far parte della compagnia dei guelfi e contento di sapere che vi trovate bene con loro, perché è sempre conveniente avere una spia in campo nemico.»
Se Castruccio non avesse capito appieno i modi eccentrici del suo compagno, si sarebbe offeso a sentirlo parlare. Tuttavia si sentì avvampare al nome di spia accostato così a lui, ma rispose ridendo: «Sì, Messer Benedetto, laggiù ci sono delle attività piacevoli per voi, la dama del castello sta tenendo corte e domani abbiamo un torneo. Volete far parte della lista contro questi cavalieri mangiapreti?»
«Non valgo meno come mangiapreti e non valgo meno nemmeno se quelli fossero davvero preti. Io so bene, per mia sfortuna, d’esser stato battuto quasi a morte da un giovane canonico che era mio nemico, e questo molti anni fa quando ero più giovane e attivo di ora. Ma sono stato vendicato. Sì, a Benedetto Pepi non è mai stato torto un capello, ma l’angoscia del suo nemico ha pagato per questo.»
Pepi guardò il suo compagno a fronte alta con aria di trionfo e vanità, mentre i suoi occhi acuti esprimevano non la ferocia, ma l’astuzia del vincitore. Castruccio lo esaminò con un’occhiata di diffidenza, che l’interlocutore non vide. Pepi proseguì: «Questo giovane birbante è stato forzato ad indossare gli abiti talari, ma non ha mai preso i voti, quando decise di soffiarmi una ricca e giovane ereditiera che intendevo sposare. Ero un uomo di mondo, con un buon patrimonio e un nobile palazzo, così il padre della ragazza diede il suo consenso e tutto andò avanti felicemente, finché questo prete smaliziato ordì un piano per la mia distruzione. Mi tese un agguato il giorno delle nozze mentre stavo portando la sposa nella mia casa. Lei lo amava e mi ha lasciato. Sì, al primo fischio di questo baldo cacciatore di dame, la sentì strappare la sua mano dalla mia e la vidi gettarsi nelle sue braccia. Io ho resistito, più per rabbia che per saggezza, poiché loro erano armati e io indifeso: così, come vi ho detto, il villano mi ha battuto e fui portato a casa quasi morto per i colpi ricevuti. Durante la mia guarigione, sdraiato nel mio letto con le mie ossa dolenti per i lividi, formulai il mio piano di vendetta, che ho portato avanti, finché lui e lei e le loro rispettive famiglie non si sono prostrate ai miei piedi per chiedermi pietà. Ma io non mi sono chinato e fu quella la più gloriosa vendetta. E adesso lui dov’è? È un disgraziato canuto, vecchio prima del tempo, che sta marcendo nelle prigioni dell’Inquisizione. Lei è morta da molto, di dolore, dicono. Almeno non se l’è mai goduto un momento il suo amante.»
Castruccio riprese il suo cammino appena udita la confessione diabolica del suo compagno. Non rispose, però non provò più quella sensazione di divertimento spensierato avuta prima dalla sua conversazione e dai modi rozzi; ma lo guardò con aria guardinga come se fosse stato un vecchio e rugoso serpente, senza zanne, ma con il veleno ancora presente nelle sue gengive sdentate.
Pepi continuò a cavalcare, inconsapevole delle emozioni che aveva mosso. Credeva di aver narrato il più bell’episodio della sua vita. Questo vecchio artigiano era saturo della visione politica italiana, che ha insudiciato la storia dei suoi signori e principi con i marchi orribili della frode e della crudeltà: lui non ammirava il conquistatore di una nazione (anche se era quasi un oggetto di ammirazione per lui), piuttosto adorava il tessitore di frodi, l’intrigante che, non con uno scontro aperto di potere e passione, ma con mezzi vili e subdoli, portava il suo nemico a inginocchiarsi davanti a lui.
Quando giunsero al castello, furono condotti alla sorgente della roccia, e Castruccio presentò Pepi alla compagnia. Il cremonese fece un inchino alle belle contesse e poi lanciò degli sguardi veloci intorno, per scoprire se conosceva qualcuno della compagnia. Molti li aveva già visti prima, e non poté fare a meno di mormorare mentre sedeva: «Guelfi fino al midollo! Che bel nido di calabroni è questo!»
La compagnia nel frattempo stava esaminando con occhi curiosi l’abito e le maniere del visitatore. Il suo vestito era più sdrucito di quello del più misero giocoliere, poiché in quest’occasione non aveva portato con sé il mantello con frange dorate e, senza la presentazione di Castruccio e gli speroni dorati che portava, sarebbe incappato nella vergogna d’essere messo insieme ai servitori del castello. Pepi osservò il disprezzo e si rivolse loro come segue.
«Voi, nobili signore e signori, che con labbra all’insù sogghignate per il mio abito semplice, ascoltate la mia storia e non disprezzate le mie parole perché sono quelle di un ghibellino. Voi risplendete per le sete, gioielli e pellicce costose. Io sono vestito con pelle di pecora e sclavina, e forse il mio cappuccio ha un buco nel suo robusto tessuto, ma guardate i miei speroni dorati: sono un cavaliere e ho un palazzo, una torre e un buon cavallo, come dovrebbe avere un nobiluomo italiano. Ora ascoltate, e ditemi poi se ho ragione o torto a non sprecare il prodotto dei miei campi in ninnoli e sciocchezze.
Oso dire che voi tutti sapete che un tempo c’era un imperatore dell’occidente, chiamato Carlo Magno. Fu un gran conquistatore e durante la sua vita dominò dignitosamente su tutta l’Europa, dalle tiepide acque del Mediterraneo fino al gelido Mar Baltico. L’Italia non mugugnò contro il suo potere e la Germania fu costretta a sottomettersi alle sue armi. Era uno splendore vedere questo gran principe cavalcare in mezzo ai suoi seguaci, vestito, come me, con pelli comuni, e fu più grande del più umile soldato del suo accampamento solo grazie alla sua superiore abilità e saggezza. Ma i nobili della sua corte erano tali e quali hanno continuato ad essere fino a oggi, e il denaro che avrebbero potuto risparmiare per il mantenimento del proprio seguito e l’equipaggiamento di guerra, lo spendevano in vestiti e vanità.
Un giorno Carlo Magno si trovava nella città di Fugolano, con indosso, come ho detto, una bella veste di pelle di volpe, e il più bel gioiello era la lama affilata della sua fedele spada. I cortigiani erano riuniti intorno a quest’aquila regale, e lui era profondamente indignato nel vedere i loro abiti sgargianti: erano appena giunti da Pavia, luogo che, come adesso, i veneziani avevano reso il centro di smistamento di tutte le ricche mercanzie portate dall’oriente. I cortigiani erano abbigliati con ogni sfarzo, indossavano stole di penne d’uccelli fenici, foderati di seta, abiti di broccato ornati con penne di pavone. I loro fluenti mantelli erano fatti con le pelli di mille piccoli animali, importati dalle lande selvagge della Tartaria, e sui loro cappelli avevano gioielli e penne di straordinario valore. Così si sdilinquivano davanti al loro padrone, illudendosi che lui li ammirasse, lui che amava un elmetto da nulla, stivali inzaccherati dall’inseguimento dei nemici in fuga, una spada lorda di sangue e un cavallo grintoso in guerra, più che dieci eserciti di questi uccelli opportunisti. “Venite, miei prodi compagni”, gridò l’imperatore, “non abbiamo battaglie o assedi per divertirci e la giornata buia con la sua pioggerella rende la quiete del mio palazzo a me fastidiosa. Montate i vostri destrieri e andiamo fuori a caccia.”
Fu proprio un bello spettacolo vedere i cortigiani dare un ultimo pietoso sguardo ai loro bei vestiti e montare sui loro cavalli per seguire il padrone. Lui fece strada, nessun fosso, siepe o vegetazione fitta poteva ostruire il suo cammino. Il suo nobile destriero superava tutto ed ogni rovo s’arricchiva delle spoglie dei suoi compagni: seta, pelliccia e penne sparpagliate sul terreno e attaccate ai rovi del ciglio della strada. Ciò che sfuggì ai pericoli del terreno andò in rovina con l’acqua, poiché la pioggia li inzuppò fino alle ossa e i tessuti dei loro vestiti, perdendo la loro lucentezza, avevano perso tutto il loro valore.
Quando tornarono i cortigiani si lamentarono profondamente tra loro per le perdite ricevute: l’imperatore fu avvisato delle lamentele e inviò loro l’ordine di presentarsi. Obbedirono e si avvicinarono al trono in ben altro modo rispetto al gaudio mostrato la mattina: le loro penne rotte, i gioielli perduti, le sete strappate e le pellicce, prima bagnate e poi seccate al calore del fuoco, s’erano ritirate, deformate e rovinate. “Oh, sciocchissimi mortali!” esclamò Carlo Magno, “che ne è di queste pellicce preziose o confortevoli? La mia costa solo pochi soldi, le vostre molte libbre non solo d’argento, ma anche d’oro!” »
Pepi finì il suo racconto molto appropriato con una risata di trionfo e forse si notò bene che qualche giovane nobile fu lungi dal gradire le rozze maniere del loro insegnante. Ma il sole adesso era tramontato e la campana dell’Ave Maria suonò nella cappella di Valperga, così la compagnia scese dalla rocca e si unì alle preghiere del sacerdote che celebrò il vespro insieme a tutti i più umili ospiti del castello.
La sera molti mimi si esibirono sotto la direzione di Borsiere. Nessun popolo può eccellere quanto gli italiani nell’espressione della passione ottenuta solo con il linguaggio dei gesti, o nel talento di dar voce in modo estemporaneo ad una serie d’azioni che intendono rappresentare. Persino in quei tempi incivili furono capaci di indurre al pianto il pubblico o di farlo ridere a crepapelle. Gli attori del castello all’inizio misero in scena la commovente storia di Palamone e Arcite, e poi il racconto preferito degli amori di Troilo e Cressida, e recitarono con tale vivacità la vicenda della tenacia mal riposta del valoroso cavaliere di Troia e del turpe tradimento dell’infedele Cressida, che pochi occhi restarono asciutti, quando ci s’immaginò che quest’infelice cavaliere, che invano aveva cercato la morte, ma era sopravvissuto al suo paese e agli amici, se ne stesse vicino alla cisterna diroccata a metà di una sorgente un tempo molto frequentata in mezzo alle rovine e ai palazzi di Troia, e vedesse Cressida, venuta a prendere l’acqua, portare una pesante brocca sulla sua testa con abiti dimessi e deformata dalla malattia. Ogni cuore s’emozionò per l’amaro dolore di Troilo e per l’umile pentimento e i sinceri rimorsi di quella che fu un tempo la sua depravata amante quando, chiedendo perdono, lei morì. Per risollevare la compagnia dalla commossa partecipazione, i mimi si misero a recitare le grottesche pantomime del giorno, ma non furono molto decorosi né abili: un mugnaio e un prete erano troppo ambiziosi nelle loro pretese amorose, e furono lasciati a battere i denti nella neve in una notte d’inverno, mentre due giovani studenti di Bologna, che gli altri nobili avevano escogitato di gabbare, godettero ciò che nella loro condizione desolata desideravano ardentemente. Metà della notte era trascorsa e la compagnia si ritirò, dopo aver tessuto le lodi meritate delle prove riuscite di Borsiere.
La mattina dopo prima dell’alba Castruccio sentì qualcuno entrare nella sua stanza. Era Pepi, che s’avvicino al suo letto e disse: «Mio sire, vengo a salutarvi. Dopo quello che è successo l’altra notte, state pur certo che la giovane contessa preferirebbe non avermi tra i suoi ospiti. Sto per tornare a Cremona, ma prima vorrei chiedervi, se voi non preferireste che un vostro amico leale fosse il signore di quella città, piuttosto che vederla restare nelle mani del popolo, che è diventato guelfo e traditore fino alle midolla?»
I pensieri di Castruccio all’istante si fissarono su Galeazzo Visconti, o Cane della Scala, come signori promessi di Cremona, e rispose con ansietà: «Messer Benedetto, mi fareste un favore eccezionale se, con ogni mezzo, anche in vostro potere o di chi conoscete, riusciste a mettere il governo della vostra città nelle mani di uno dei miei amici.»
«E voi siete pronto a patrocinare un’impresa del genere?»
«Adesso non posso, ma ho promesso d’essere in Lombardia alla fine del mese di luglio. In agosto vi verrò a visitare a Cremona e, se vorrete rivelarmi i piani e i mezzi per questo cambiamento…»
«Ora non posso dirvi nulla. Venite da me il quindici agosto, da solo, o con un solo attendente, però non venite con l’aria del principe. Quel giorno, alle cinque della sera, incontrerete una persona sul ponte del fiumiciattolo che attraverserete a mezzo miglio da Cremona; ditegli la parola “Lucca” e lui vi porterà al mio palazzo in gran segreto, e allora vi rivelerò tutto. Nel caso voi non ce la farete a essere a disposizione per quel giorno, vi aspetterò per un mese, fino al quindici settembre. Se poi non venite, l’impresa deve andare avanti con altri mezzi. In quest’intervallo promettetemi un assoluto riserbo.»
«Cosa non dovrei dire?»
«Nessun essere vivente deve sapere questo… Se fate trapelare ciò che io vi affido, il mio piano fallirà all’istante. Io mi fido della vostra discrezione.»
«Va bene, Messer Benedetto», replicò Castruccio, richiamando alla mente le impressioni della sera precedente e guardando il suo compagno con diffidenza: «Non comprendo con chiarezza i vostri piani e non vi posso promettere di patrocinarli, però vi assicuro il mio riserbo e che vi vedrò prima del quindici settembre.»
«Ne sono convinto. Addio. Le stelle stanno sparendo e io vorrei raggiungere la vostra città prima dell’alba.»
Pepi partì preoccupato, mentre tutti al castello di Valperga erano infervorati e ogni volto esprimeva gioia. Era il terzo giorno che si teneva la corte, il giorno dedicato al torneo. Ma sarebbe noioso dilungarsi sul resto di queste cerimonie e sui giudizi verosimilmente espressi sulle prove ancora a venire.
I mesi estivi passarono e si avvicinava il tempo in cui Castruccio aveva promesso a Galeazzo Visconti di incontrarlo a Rovigo. Eutanasia durante l’autunno desiderava rivisitare la sua città natale, dalla quale era stata a lungo assente. Concordarono di fare il viaggio là insieme e al ritorno di Castruccio dalla Lombardia il loro matrimonio tanto ritardato avrebbe avuto luogo.
FINE DEL PRIMO VOLUME
[1] In italiano nel testo.