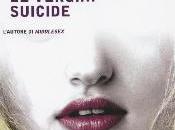Mi smarrisco tra i labirinti del suicidio, adombrato dal bianco accecante dei soliloqui di Edouard Levé, con in mente la musica e il dialogo a una voce di Emma Bovary di Battiato e Sgalambro. La voce cavernosa di Patty Pravo mi fa compagnia tra le pagine dirette e vigorose di “Suicidio”. Mi accompagno a quest’io senza nome e dai contorni indefiniti, come si farebbe con un fratello a cui si chiede perché, fuorviato dalla falsità di un luogo scelto per ingannare la freccia che ucciderà. Mi sento come il capitano superbamente convinto di veicolare i pensieri verso lidi più sicuri. Il fallimento è un’ipotesi inconciliabile.
Mi smarrisco tra i labirinti del suicidio, adombrato dal bianco accecante dei soliloqui di Edouard Levé, con in mente la musica e il dialogo a una voce di Emma Bovary di Battiato e Sgalambro. La voce cavernosa di Patty Pravo mi fa compagnia tra le pagine dirette e vigorose di “Suicidio”. Mi accompagno a quest’io senza nome e dai contorni indefiniti, come si farebbe con un fratello a cui si chiede perché, fuorviato dalla falsità di un luogo scelto per ingannare la freccia che ucciderà. Mi sento come il capitano superbamente convinto di veicolare i pensieri verso lidi più sicuri. Il fallimento è un’ipotesi inconciliabile.
Nel suicidio, l’aspirazione è solo una forma mitigata d’essere; chi lotta quotidianamente con questa eventualità di soluzione definitiva, in realtà, ha già deciso. La pianificazione è un sostegno secondario alla realizzazione concreta; l’idea induce a una guerra aperta contro se stesso.
Per il suicida, il soliloquio è l’unica forma di dialogo, il resto è tempo rubato, perché sprecato nella distrazione da un proposito che si perpetua nella realtà di un quotidiano vissuto nel rimando di qualunque esperienza di vita.
Rimandare non a domani, ma a mai più. L’azione più naturale perde di vigore e i gesti si moltiplicano in parcellizzazioni spazio-temporali annullabili dalla solita domanda che risuona quasi come l’eco di un urlo lanciato una volta, all’inizio, e che poi si ripropone incessantemente in mille varianti: «A che pro, se domani potrei cedere?». Un potrei che, in verità, è un avrei potuto, perché la decisione è presa ma procrastinata di tempo in tempo, aggrappandosi a momentanei appigli in cui il dibattersi delle due voci si ricompone in una riunificazione nell’interesse velleitario per un impegno, un libro, una frase da scrivere, una parola da dire, un amore da consumare. Tutto assume un’importanza capitale, ammantato dietro il velo di una questione di vita o di morte; ogni parola è rivestita della pesante coltre del definitivo, di ciò che non potrà essere rettificato se non a patto di uno sforzo immane su se stessi. Non si ammettono repliche, perché il tempo della risposta non è certo. Tutto va svolto in fretta, il sospeso pesa sulla coscienza come il dolore per il male che si fa a chi rimane con il cadavere. Nemmeno l’amore basta… i tormenti di Emma sono il contraltare del matrimonio di Levé, il tentativo di trovare qualcosa di solido a cui aggrapparsi per sopravvivere a se stessi un giorno in più, un giorno ancora, per farcela nonostante il fastidio di doversi riprendere la propria monotonia dopo l’eterno ritorno dell’ardore dei sensi che severamente si rimpossessa dell’ordine momentaneamente ricostruito per simulare lo stupore che i propri stati d’animo possano mutare così radicalmente e velocemente senza che nessuno se ne accorga.
Né menzogna né maschera per celare la verità; è l’esercizio alla resistenza, stemperata nello sguardo malinconico di una consapevolezza che si fa sempre più fatica a tenere a freno.
La partecipazione alla vita diventa strategia di fuga, tentativo di distrazione dai propri pensieri, rifugio in un mondo restandone ai margini per un senso di inadeguatezza e spaesamento dovuti all’assenza di qualunque forza vitalistica. Non ci si stupisce del sentirsi inadatto al mondo, ma del fatto che il mondo abbia potuto produrre un essere che lo vive da estraneo, un elemento che lo nega giorno per giorno. Le piante si suicidano? Gli animali muoiono di disperazione? O si adattano o si estinguono.
Il suicida impara a dare del tu a se stesso, a distanziarsi dal proprio io in un rapporto di familiarità che presuppone una certa estraneità, perché se l’io si dibatte tra la voluttà finale della verità o di un colpo di pistola, un tu è assassinabile con più facilità, senza pentimenti o rimpianti.
---------------------------------------------------
L’articolo è costruito come un pastiche di due testi:
Edouard Levé, Suicidio, Bompiani, 2008.
Emma, testo di Manlio Sgalambro, musica di Franco Battiato, 1998, che potrete ascoltare qui e qui.