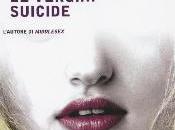"C'è una ragione perché sono tornato in questo paese; [...] Qui non ci sono nato, è quasi certo; dove son nato non lo so; non c'è da queste parti una casa né un pezzo di terra né delle ossa ch'io possa dire [...] di che carne sono fatto."
"C'è una ragione perché sono tornato in questo paese; [...] Qui non ci sono nato, è quasi certo; dove son nato non lo so; non c'è da queste parti una casa né un pezzo di terra né delle ossa ch'io possa dire [...] di che carne sono fatto." La luna e i falòinizia così, con un triste ritorno nei luoghi del passato, nei posti di un'infanzia tormentata; mai vissuta, se leggiamo, anche velocemente, le parole che Cesare Pavese, nei panni di Anguilla, riserva alle ultime pagine del primo capitolo: "Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti".
Abbandonato quando ancora era in fasce, Anguilla è cresciuto grazie a Virgilia e Padrino, " tutta gente che non c'è più" e che, in fin dei conti, non avrebbe mai potuto, né voluto, aspettarlo: "[...] Loro mi hanno preso e allevato soltanto perché l'ospedale di Alessandria gli passava la mesata. Su queste colline quarant'anni fa c'erano dei dannati che per vendere uno scudo d'argento si caricavano un bastardo dell'ospedale, oltre ai figli che avevano già". E fu così che quei due, che non erano la sua famiglia, entrarono in contatto con lui, con la speranza, neanche tanto contestabile, di poterlo veder crescere in una " grossa cascina ".
L'infanzia del protagonista, insomma, non è segnata da affetto, né da figure amiche, ma solo da abbandoni, mancanze ed egoismi. Anguilla sa che le sue non sono radici solide; è consapevole che, con un solo soffio di vento, con soli cinque minuti di ritorno al passato, tutto si sgretolerebbe. E si sgretola, su questo non c'è dubbio: ritornare a Santo Stefano Belbo significa fare i conti con un passato che non c'è mai stato e mettere ordine, una volta per tutte, nei frammenti sparsi della propria infanzia; che non sarebbe un male, se non fosse per la fine delle illusioni: per la distruzione di un vecchio mondo costruito con fantasia e, perché no, desiderio.
Pavese decide di affrontare la realtà, di mettere un punto, una virgola o un punto e virgola - non lo sa prima di tornare. Importante, almeno adesso, è prendere la situazione di petto, con tutti i rischi che essa comporta; è proprio questo ciò che succede ne La luna e i falò: l'incontro con il passato pone fine al disinganno.
Il gioco dei contrasti, della sospensione tra il ricordo dolciastro di ieri e l'amara accettazione dell'oggi, si evince sin dalle prime righe, quando Anguilla ricorda Giulia e Angiolina, le sue due sorellastre: " Adesso sapevo ch'eravamo dei miserabili, perché soltanto i miserabili allevano i bastardi dell'ospedale. Prima, quando correndo a scuola gli altri mi dicevano bastardo, io credevo che fosse un nome come vigliacco o vagabondo e rispondevo per le rime. Ma [...] io ancora non avevo ben capito che non essere figlio di Padrino e della Virgilia voleva dire [...] non essere sbucato da sotto i noccioli o dall'orecchio della nostra capra come le ragazze "
C'è una presa di coscienza da parte dell'autore che fa quasi tenerezza; che, per un attimo, ci allontana dal Pavese di sempre, anche da quello che abbiamo imparato a conoscere con La casa in collina, dove l'inetto Corrado assiste alla guerra; ricorda i vecchi conflitti, come se fossero un film, durante il quale è incapace di reagire. Come ne La luna e i falò, non ci sono lacrime; forse perché l'autore ci parla dell'infanzia di Anguilla con il senno del poi, o forse perché non c'è alcun motivo di gridare al mondo la propria rabbia: l'infanzia è stata negata; indietro non si può tornare, soprattutto quando alla vicende personali si intrecciano quelle della Post-resistenza e quelle di un conflitto, la Seconda Guerra Mondiale, che, vivo nella coscienza di ognuno, continua a scombussolare il nuovo corso.
Sembra impossibile un ritorno alla vita - e, in effetti, Pavese morirà suicida - ma non in tutti i casi. Lo sapeva bene, e forse lo sperava, proprio lui, quando, scrivendo del cugino, nell'ultima stupenda strofa de I mari del Sud:
"[...] Quando gli dico Ch'egli è tra i fortunati che han visto l'aurora Sulle isole più belle della terra, al ricordo sorride e risponde che il sole si levava che il giorno era vecchio per loro"lasciava che fosse lui a veder l'aurora. Un momento che anche lui, sin dall'adolescenza, ha cercato di vivere, lasciandosi sopraffare, però, dagli eterni contrasti del suo animo: "In fondo ai grandi periodi hai sempre sentito tentazione suicida. Ti eri abbandonato. Ti eri spogliato dell'armatura. Eri ragazzo. L'idea del suicidio era una protesta di vita. Che morte non voler più morire"