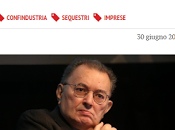di Antonio Scarazzini

Squilibri commerciali negli USA: tutta colpa dello yuan?
Uno studio dell’Economic Policy Institute stima in 2,8 milioni i posti di lavoro persi a causa del crescente deficit commerciale con la Cina, di cui 1,9 nel solo settore manifatturiero. La cosiddetta “manipolazione del tasso di cambio” è pure caduta sotto la scure delle critiche di autorevoli economisti come Paul Krugman o di ex governatori della FED come Alan Greenspan, cui hanno fatto eco proteste di varie associazioni di categoria. Da ultimo, il Senato USA ha approvato nello scorso ottobre il “Currency Exchange Rate Oversight Reform Act“, che si prefigge l’intento di recuperare oltre 2 milioni di posti di lavoro e di diminuire di circa 200 miliardi di dollari il deficit commerciale. Gli strumenti previsti – peraltro non specificamente riferiti al caso cinese, ma abbastanza dettagliati per non lasciare dubbi in merito – sono la dotazione da parte del Dipartimento del Tesoro di strumenti di rilevazione di disequilibri fondamentali del tasso di cambio e la successiva predisposizione di contromisure commerciali e di istanze presso un Panel WTO.
I vertici cinesi hanno più volte segnalato la pericolosità di un simile approccio alla risoluzione del disequilibrio commerciale fra i due Paesi, ricordando la centralità che la politica di cambio ha avuto per lo sviluppo economico: da sempre fedele al perseguimento di un alto grado di stabilità sociale, la Cina degli anni Ottanta ha avviato una serie di riforme del tasso di cambio legate alla liberalizzazione del sistema commerciale, quando ancora le esportazioni non erano destinate all’ottenimento di valuta forte, al punto che solo dagli anni Novanta le imprese abilitate al commercio estero iniziarono a trattenere i ricavi in valuta estera. Così, dal tasso sopravvalutato nei primi anni dell’era Deng per sostenere le importazioni, lo yuan si è avvicinato alla fluttuazione con gradualità: dopo una svalutazione del 57,2% a partire dal 1986 nei confronti del biglietto verde[1], nel 1994 fu unificato il sistema duale di tassi tra mercato interno ed esterno e dal 2005 la valuta cinese fu ancorata al dollaro tramite una fluttuazione quotidiana controllata dal governo in una banda dello 0,5% rispetto ad un paniere di monete in cui la valuta americana pesa per oltre il 90%[2].
Con la sola eccezione del biennio 2008-2010, in cui la crisi economica colpì l’export cinese, l’amministrazione di Hu Jintao guidò una graduale rivalutazione del tasso di cambio dagli 8,28 renminbi per dollaro ai 6,29 di fine 2011, un balzo del 25% rispetto ai livelli del 2005. La gradualità del rialzo concesse di limitare l’aumento del costo delle importazioni, salvaguardando la competitività dell’export, mentre il controllo sul movimento di capitali impedì l’eccessivo apprezzamento e non accelerò la transizione verso maggiori consumi interni, ancora troppo esposti alle possibili spirali inflazionistiche.
Lo stesso Xi, nel corso della sua visita, ha ricordato come i problemi della bilancia commerciale USA nascono proprio negli States, a causa della restrizione nell’esportazione di beni tecnologici ad alto valore aggiunto – peraltro giustificabili dai timori di persistenti violazioni dei diritti di proprietà intellettuale – e di perdita di competitività dei settori labour intensive dell’economia americana; a ben vedere, la stessa composizione dell’interscambio commerciale sembra sostenere questa tesi, per non per parlare delle difficoltà nello stabilire metodi e parametri per definire quel “tasso d’equilibrio” richiesto in particolare dall’ala repubblicana del Congresso per trovare e punire i “currency manipulators”.
Manifattura e tecnologia: la new wave dell’export cinese
Nel 2010, infatti, Cina e Stati Uniti hanno scambiato beni e servizi per quasi 500 miliardi di dollari occupando la leadership rispettivamente nelle esportazioni e delle importazioni mondiali: secondo le statistiche WTO aggiornate ad Ottobre 2011, gli Stati Uniti hanno nella Cina la prima fonte di importazioni mentre la Repubblica Popolare trova negli USA il secondo mercato di esportazione dopo quello europeo. Il Dipartimento del Commercio USA stima in 295 miliardi di dollari il deficit commerciale bilaterale per il 2011, circa il 40% del totale di 737 miliardi: come indicato in uno studio per il Congresso, le ragioni di questa crescita vanno ricercate nella composizione del commercio sino-americano e soprattutto nella collocazione che la Cina ha raggiunto al vertice della catena di produzione mondiale: secondo i dati 2011 del Census Bureau, il dato aggregato del deficit commerciale nei prodotti ad alto contenuto di tecnologia (advacend technology products – ATP) è aumentato rispetto al 2010 di circa 20 miliardi di dollari, toccando quota 99 miliardi a fine dicembre.
E’ proprio nel settore ATP che lo squilibrio nei confronti della Cina si fa più marcato: dagli undici miliardi del 2002 il deficit è schizzato ai 109 miliardi del 2011, pari al 36% del disavanzo bilaterale complessivo. Il campo manifatturiero è quello più in affanno, con un calo dell’export nei confronti della Cina, solo quarto mercato di esportazione dei beni USA, proprio nei settori merceologici (informatica, elettronica, macchinari che contano per il 47% dell’import USA) in cui Pechino continua ad aumentare la sua quota, come registrato dall’ultima revisione per il 2011 dei dati della U.S. International Trade Commission.
Dal 2002 Pechino è ormai il primo fornitore di materiale informatico per computers, in ragione soprattutto delle politiche di delocalizzazione ed outsourcing operate dalle multinazionali. L’esempio di Apple e Foxconn, salito all’onore delle cronache per i tragici aspetti legati alla violazione dei diritti dei lavoratori, è stato più volte utilizzato per esemplificare il trasferimento in Cina delle attività di assemblaggio, laddove il valore aggiunto dai lavoratori cinesi consente di limitare al 2% (secondo un’analisi recentemente apparsa sull’Economist) la componente del prezzo al consumo diretta a remunerare la forza lavoro di Foxconn, nei cui stabilimenti si assemblano ormai da un decennio i prodotti del colosso con maggiore capitalizzazione a Wall Street.
Se si considera, infine, che le Foreign Invested Enterprises (FIE, joint venture tra capitale cinese e straniero, oppure imprese a controllo interamente straniero) contavano nel 2010 per il 55% dell’export cinese e per il 68% del surplus commerciale, emerge come l’aumento del deficit commerciale statunitense possa essere imputato, più che a politiche sleali sul tasso di cambio, ad un modificazione delle catena internazionale del lavoro[3]: i Paesi emergenti, in cui peraltro la Cina fatica a collocarsi dato il gigantismo della sua economia, sanno offrire alta produttività con una bassa incisione del valore aggiunto dalla forza lavoro, fattore sul quale una rivalutazione della moneta può incidere solo con scarsi effetti. Proprio l’industria leggera ad alta intensità di lavoro ha saputo raccogliere la maggior parte degli investimenti esteri diretti (IDE) in Cina, indirizzati nello stabilimento di nuovi impianti produttivi e nel miglioramento delle tecniche di produzione di quei beni poi destinati all’esportazione. Sebbene gran parte del capitale straniero in Cina provenga da Hong Kong e Taiwan, gli Stati Uniti sono il quinto Paese per investimenti attivati sul territorio cinese con circa 3 miliardi di dollari e le multinazionali USA sono state tra le prime a sfruttare gli incentivi introdotti da Deng Xiaoping a partire dal 1984 nelle Zone Economiche Speciali (ZES) situate in particolare nell’area costiera.
Se è vero che il deficit commerciale è legato in particolare alla modificazione degli equilibri di produzione globale, una rivalutazione dello yuan potrebbe dunque risultare addirittura sconveniente laddove andasse ad aumentare i prezzi all’importazione di quei beni semi-lavorati che consentono poi ai gruppi high-tech statunitensi di competere nel mondo, senza contare che la diminuzione nei prezzi dei beni di largo consumo (ad es. abbigliamento) importati dalla Cina ha sostenuto il potere d’acquisto dei consumatori americani soprattutto dopo l’inizio della Grande Recessione.
Rivalutazione miracolosa…oppure no?
La spinta al ribasso dei salari dei lavoratori meno qualificati e la competizione tra i settori manifatturieri a livello mondiale sono certamente due delle conseguenze più evidenti della globalizzazione e, come detto, sono state alla base del mutamento delle preferenze delle multinazionali nello stabilimento di nuovi impianti produttivi. Per il tramite degli IDE, le tecnologie e le best practices si sono trasferite gradualmente anche ai mercati emergenti e la Cina, che dall’apertura al capitale straniero contava di ottenere la tecnologia necessaria a rilanciare il suo sviluppo, si è mostrata in grado di superare gli Usa anche nei settori in cui il vantaggio tecnologico e di know-how pareva incolmabile.
Nell’America che fatica a riprendersi dalla crisi finanziaria iniziata nel 2007, prostrata nelle sue finanze pubbliche da un deficit che supera il trilione di dollari, rimane tuttavia ferma la convinzione che il rilancio dell’export made in Usa passi in primo luogo dalla rivalutazione dello valuta cinese: un paper di Robert Scott per l’Economic Policy Institutestima che una rivalutazione del 28,5% dello yuan rispetto al dollaro consentirebbe il recupero di 1,6 milioni di posti di lavoro, un risparmio di 71 miliardi di dollari per il budget federale, un taglio del deficit di partite correnti per 138 miliardi ed un aumento del PIL attorno al punto percentuale.
L’analisi di Scott si basa principalmente sui dati forniti dagli studi di William Cline e John Williamson per il Peterson Institute of International Economics, in cui i due economisti cercano di definire periodicamente un tasso di cambio di equilibrio (FEER – Fundamental Equilibrium Exchange Rate), definito come il tasso in grado di consentire al saldo di partite correnti di oscillare fra il +/- 3% del PIL. Ad ottobre 2011 il renminbi risultava, secondo tale metodo, svalutato del 23,5% rispetto al suo tasso di equilibrio malgrado un apprezzamento in termini reali del 5,5% tra aprile ed ottobre.
Numerosi gli economisti a sostegno di questa tesi, tra gli altri anche quel Fred Bergsten che nel 2005 su Foreign Affairs coniò il termine G-2 per descrivere il duopolio sino-americano: è tuttavia difficile spiegare secondo questo metro di giudizio come il deficit commerciale sia potuto aumentare del 30% tra il 2005 ed il 2008 a fronte di una rivalutazione del 20% del renminbi rispetto al dollaro[4]. Altri punti di vista, come in questo articolo apparso sull’Economist, tendono poi a sottolineare che l’inflazione abbia portato al 17% l’apprezzamento reale tra 2009 e 2011 a fronte di una rivalutazione nominale del 4%, lasciando intendere che una politica di apprezzamento più aggressiva sommata all’alto tasso di inflazione presente in Cina possa colpire di riflesso le importazioni e i consumatori americani[5]. Lo stesso FMI, infine, nel suo report annuale sull’economia cinese sancisce un possibile impatto sulla crescita del PIL Usa in un range che va dal + 0,05% al + 0,15%.
Se l’obiettivo dell’apprezzamento dello yuan è dunque di rilanciare l’export americano e di ridurre il deficit commerciale fra le due nazioni, la strada potrebbe rivelarsi più ostica del previsto: i dati della International Trade Commission[6] indicano che i settori merceologici che dominano le esportazioni verso la Cina coincidono per gran parte con la top five delle importazioni dal colosso asiatico, suggerendo che l’effetto stimolante all’export Usa potrebbe venire annullato o superato da una più pesante riduzione delle importazioni e dei consumi da parte cinese. La fede alla stabilità interna impedisce inoltre al Partito Comunista di sperimentare eccessivi apprezzamenti, onde evitare ulteriori spirali inflazionistiche o bolle speculative come quelle che sembrano colpire il mercato immobiliare; da ultimo è bene ricordare che il controllo della fluttuazione dello yuan e dei movimenti di capitale hanno condotto al fenomeno della gigantesca accumulazione di riserve in dollari nelle casse della Banca Popolare Cinese, che ha rastrellato valuta estera vendendo valuta nazionale con il duplice obiettivo di impedirne l’apprezzamento e di incamerare valuta forte.
La cosiddetta “trappola del dollaro” si completa con l’investimento di gran parte di queste riserve in titoli del Tesoro USA per un valore di oltre 1,2 trilioni di dollari, pari al 30% del debito americano detenuto da investitori esteri. La cifra è sufficiente a coprire il budget di bilancio statunitense ed è facile capire che la trappola è abbastanza larga per due occupanti: la rivalutazione dello yuan colpirebbe le esportazioni cinesi riducendo pertanto le prospettive di crescita, comportando una riduzione del surplus commerciale e delle riserve valutarie. A farne le spese, oltre che i consumatori americani, anche le casse statali dal momento che una riduzione delle riserve in dollari all’estero comporterebbe – date le dimensioni dell’esposizione cinese – una pesante svalutazione del dollaro oltre che una fuga dai Treasury Bonds che pure in tempo di crisi hanno consentito agli USA di finanziarsi a bassi tassi d’interesse.
Obama e Xi: prove di dialogo per le sfide del futuro
La speranza è che il primo incontro fra Obama e Xi – il primo favorito alla presidenziali di novembre, il secondo dato ormai come sicuro successore di Hu Jintao nel 2013 – possa rivelarsi un antipasto del dialogo fra i futuri leader delle due prime economie mondiali. L’auspicio è che entrambi sappiano riconoscere che la soluzione del pesante squilibrio che caratterizza le relazioni commerciali fra i due Paesi possa essere trovata analizzando nelle dinamiche interne alle due economie: parafrasando Michael Porter, gli Stati Uniti hanno diminuito il proprio vantaggio competitivo nell’industria a maggior tasso tecnologico. Gli anni in cui la Cina appariva come grande serbatoio di manodopera a basso costo furono inoltre gli stessi in cui i grandi gruppi multinazionali scelsero la strada della delocalizzazione, preferendo investire all’estero anziché nella formazione interna del personale o nei programmi di Ricerca e Sviluppo. Il tasso di cambio fra yuan e dollaro nel frattempo rifletteva le esigenze di stabilità per lo sviluppo armonioso dell’economia cinese: controllando i movimenti di capitale la Cina seppe superare al meglio la crisi finanziaria delle tigri asiatiche del 1997 ed ha certamente favorito le esportazioni delle sue imprese, cui peraltro partecipano in modo significativo i capitali esteri. Pur esponendosi in misura forse eccessiva verso le riserve in dollari, Pechino ha saputo tuttavia modificare la propria immagine: grazie alla massimizzazione dei benefici degli investimenti esteri, il Dragone asiatico è ora tra i leader mondiali della manifattura, anche e soprattutto di beni high-tech che sino agli anni Novanta parevano monopolio del trio Usa-Europa-Giappone.
* Antonio Scarazzini è Dottore in Studi Internazionali (Università di Torino)
Fonti:[1] U.S. China Economic and Security Review Commission, Hearing on “Chinese State-Owned Enterprises and U.S.-China Bilateral Investment”, pag. 18
[2] CRS Report for Congress RS21625, W.M. Morrison – M. Labonte “China’s currency: An analysis of the Economic Issues” 08/2011
[3] Chart of the week: Chinese wage inflation raises doubt over cheap labour, Valentina Romei, Financial Times, 5.04.2011
[4] US-China Business Council, How much China’s exchange rate affect the trade deficit?, April 2011
[5] Il legame tra tasso di inflazione e tasso di cambio è spiegato dal cosiddetto effetto Balassa-Samuelson, secondo il quale un aumento del tasso di inflazione in un paese comporta l’apprezzamento del tasso di cambio.
[6] US International Trade Commission, US imports for consumption at customs value from China, 2011