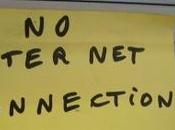Ci sono autori che o si fanno in grande o non si fanno. Ibsen è uno di questi. Un dogma che si sposa a perfezione con il gigantismo tipico del teatro di Gabriele Lavia. Manie di grandezza che prendono forma, in primis, in una scenografia imponente per una pièce che sin dal titolo denuncia la sua aspirazione al monumentale. Sontuosi divanetti e triclini purpurei, specchi enormi e ritratti seicenteschi appesi a pareti rosso fiammante, un pianoforte da suonare a festa e lode a Dio. Lusso barocco e alto-borghese in una slanciata architettura neoclassica. E poi cinque gradoni che sfondano il proscenio e scendono in platea, e una quarta parete a vista che sale e scende. Lavia mette in mostra e in scena una grande macchina di teatro (iper)realista per raccontarci un mondo dove la realtà è invadente, appariscente, eccessiva, vera. Tutta una magniloquente paratia atta a mascherare un microcosmo fatto di menzogne decennali e verità schiavizzate, ispidi basettoni e cilindri e mantelli da monatti della libertà, dove morale e verità sono sorellastre. Il suo console Bernick è il pilastro di una società marcia alle fondamenta, costruita e avvelenata dal denaro e dalla falsità, pronta a nascondersi e farsi forte (e coraggio) dietro un puritanesimo spicciolo e un perbenismo inattaccabile.

La performance di Gabriele Lavia e del suo gruppo d’attori cresce proporzionalmente al dramma ibseniano. La recitazione di posa pian piano si eclissa verso quell’isteria che solo una scomoda verità sa generare negli uomini. I pilastri della società è un Ibsen che spaventa, sul moralismo di chi morale non ha, che Lavia, a cinquant’anni di distanza dall’ultima messinscena di Orazio Costa, sa rendere con terrore e pathos alternando la serenità di un’allegra cantatina al pianoforte da Canto di Natale a rari e mirati inserimenti musicali che gettano una lunga e inquietante ombra di spettri su chi guarda.
Un testo complesso e denso che però non trattiene l’ego (smisurato!) di un Lavia che ama citarsi. E’ così che, tra un’ottica di riuso e una strizzatina d’occhio ai suoi fedelissimi, per puro sfizio sterile di sviluppi narrativi, ci ripropone quella camminata cadenzata già vista, però a ritroso (e quello era il bello!), in Tutto per bene dello scorso anno.
In sostanza, evitando i toni caricaturali del suo Malato immaginario, il solito Lavia megalomane, ampolloso, prolisso, ridondante, e per questo bello fino a ipnotizzarci e, nel finale, renderci popolo attore che applaude un leader politico e teatrale. Se Arlecchino si confessò burlando, Bernick/Lavia si burlò confessando.