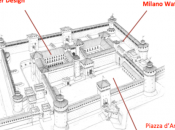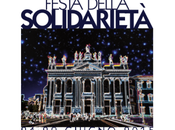Nell’ambito del rinnovato interesse che paiono avere opere dell’ingegno “alternative”, come videogiochi e fumetti, testimoniato dalla sempre più grande affluenza nelle fiere organizzate sul territorio nazionale, e memori dell’ottima – e sovraffollata – ultima edizione del Lucca Comics, hanno risposto alle nostre domande tre autori di fumetti, la cui prima opera insieme è stata appena pubblicata e presentata proprio alla fiera di Lucca questo autunno.
Manfredi Toraldo, direttore responsabile della Manfont, sceneggiatore e insegnante di sceneggiatura alla Scuola internazionale di comics di Torino; Jacopo Tagliasacchi, disegnatore; e Virginia Chiabotti, inchiostratrice, rispondono dunque alle nostre domande sul mondo dei fumetti in generale e presentano la loro opera.
Iniziamo a parlare generalmente “di fumetti”: il mondo dei fumetti, che cos’è di fatto e che cosa rappresenta oggi – visto che molti sono abituati oggi a vederli nei manga, e invece qui si parla di un prodotto occidentale, italiano: in che cosa differisce, e perché approcciarsi a questo, e che cosa vuole offrire un fumetto italiano?
Innanzi tutto la storia dei fumetti occidentali ha circa cento anni; il fumetto nasce ufficialmente nel 1899 con “Yellow Kid”, che oggi dà il nome ad uno dei più importanti premi in Italia.
Il fumetto comunque è un mezzo espressivo molto particolare: all’apparenza è uno strano ibrido tra disegno, storia, e narrativa in prosa, che ha sviluppato una lingua però proprio sua: è un linguaggio molto diverso da quello orientale, che conosciamo attraverso i manga.
Esso è più dinamico, mediamente più d’impatto, che si sviluppa però attraverso decine di offerte; in Giappone si fanno manga per ogni cosa, da storie di avventura a storie d’amore, ma anche cose assurde, come, storia bellissima, “L’Uomo che Cammina” di Jiro Taniguchi, che descrive ciò che vede un uomo passeggiando per dodici ore. Sembra una cavolata, ma ha un grande valore.
In Giappone c’è molto più il concetto di fumetto con una valenza più profonda; in Occidente si vede ancora come un pochino più “infantile”. Ha però dimostrato di poter dire tante altre cose, peraltro grazie al concetto di Graphic Novel.
Il concetto di base è che nel fumetto viene confuso il mezzo con il messaggio. Un libro è a prescindere qualcosa che può parlare di qualunque argomento; un fumetto no: si concepisce che tu guardi le figure prima che tu abbia imparato a leggere. Quando sei adulto, se guardi ancora le figure sei fondamentalmente un po’ stupido. In realtà è una stupidaggine: per l’argomento, la finzione narrativa non è legata allo strumento. Con il concetto di Graphic Novel questo è evidentissimo: opere uniche che con la stessa forza di un libro vanno a parlare anche di argomenti molto complessi.
Forse la più famosa è “MAUS” di Art Spiegelman, che parla dell’Olocausto: è una storia a fumetti dell’Olocausto che parte da un racconto del padre dell’autore che l’ha vissuto sulla sua pelle. Gli ebrei sono topi antropomorfi; i nazisti dei gatti.
E invece dal punto di vista proprio Italiano, che cosa offre il fumetto? Di solito si pensa sempre ai “classici”: Tex, Dylan Dog…
Ci sono certamente le serie classiche, ma vi sono anche lavori da libreria. Uno dei fumetti che sta vendendo un sacco, numeri che farebbero impallidire molti libri in prosa, è ZeroCalcare. Un gran bel lavoro, molto divulgativo, che non ha pretese di essere un’opera particolare. Vuole fare divertire, e riflettere, ma in maniera blanda e tranquilla.
Il fumetto è intrattenimento, è giusto che sia così. In Italia c’è stato per lungo periodo la polemica tra fumetto popolare e fumetto d’autore.
Il primo era il fumetto tipo Tex, Diabolik, e per alcuni versi anche Topolino; il secondo era quello di Corto Maltese, o i lavori di Manara, cose di questo genere.
Grazie proprio a Dylan Dog la distanza di questi fumetti si è molto assottigliata. Grazie ad esso, che veniva venduto in albi da edicola, ma ciascuno dei quali con un’unica storia autoconclusiva e disegni molto moderni, più particolari e ricercati rispetto al classico fumetto seriale, si è capito che il fumetto poteva dare di più. Finché però non sono arrivate le vere Graphic Novel, il “romanzo a fumetto” di origine americana, non si è concepito che il fumetto potesse essere anche “adulto”. Il fumetto d’autore è stato visto anche con una valenza erotica, confondendo ancora il mezzo col messaggio.
Pensate che un pubblico più vecchio, di 40-50 anni, possa pensare al fumetto in maniera diversa, abituato a ritenerlo quasi una cosa “da bambini”, oppure il fumetto è effettivamente prerogativa di una generazione più giovane?
In realtà ci sono tre generazioni diverse: una di 20, una di 40, una di 60 anni.
Ovviamente i sessantenni hanno più problemi. E’ la generazione che ha vissuto con Tex. Leggevano quello, Asterix, i grandi classici. Quelli li leggono: non hanno nessun problema.
Quelli di 40 anni sono cresciuti con Corto Maltese, con un certo tipo di messaggio, e vedono il fumetto come qualcosa di già più normale, ma lo sottovalutano. Lo sottovalutano perché lo vedono un pochino troppo ancora infantile. Sono cresciuti d’altra parte con i cartoni animati giapponesi, con i quali fare confusione è facile. Se io cito a loro due o tre fumetti, o due o tre cartoni animati per cui erano impazziti da piccoli, questi oggi mi dicono “sì, ma a un certo punto bisogna lasciarsi quel mondo alle spalle”.
E i ventenni?
I ventenni sono bombardati di una serie infinita di media: videogiochi, film, cartoni animati di vari livelli. Di tutto. E paradossalmente sono meno interessati ai fumetti.
Sarebbero il pubblico migliore, ma hanno due problemi: l’uno che il fumetto italiano è troppo legato ad un pubblico vecchio: non quello dei quarantenni, ma addirittura quello dei sessantenni. Hanno fumetti che arrivano dal Giappone, e infatti leggono i manga, oppure dall’America. E poi, l’altro, è che leggono di meno. Semplicemente. Sono più attratti da opere diverse, meno impegnative. Il videogioco. Uno non deve impegnarsi per giocare a un videogioco: ti fai trascinare dal gioco.
Sì, forse il film ancora di più.
Sì, anche se il film te lo devi andare a cercare. Certo, oggi con internet è ancora più facile. Infatti forse bisognerebbe dire che subentra una nuova generazione, dei sedicenni, che fruiscono di tutto immediatamente – e non hanno la cultura dei ventenni che, bene o male, il film lo devono pagare.
Facciamo un rapido discorso sul mondo dei fumetti, inteso sul “come si lavora”: raccontatemi, voi, da dentro, cosa si fa, e innanzitutto come ci si accorge di avere una certa indole a questa professione.
Beh, sicuramente una grande passione per la lettura. Una passione per il disegno e per disegnare. Essere attratti da altri fumetti. Ci sono poi scuole che danno una mano a realizzare queste passioni.
E se uno vuole pubblicare questo suo fumetto? Per esempio, voi?
Noi siamo stati fortunati; lui [indicando Manfredi Toraldo] è stato nostro insegnante alla scuola di fumetto e ci ha notati.
Fondamentalmente ci sono due strade. O un’autoproduzione, o lavorare per un altro editore.
L’autoproduzione può comportare che tu continui a pubblicare da solo, con più o meno successo, oppure che tu venga notato da un editore più grande. E’ quel che è successo a ZeroCalcare.
Parliamo della vostra opera: presentamela.
“Agenzia Investigativa Carlo Lorenzini” è intanto un lavoro che ho iniziato tanti anni fa per una rivista gratuita della Banca Antonveneta. Era una storia pubblicata in quattro pagine su questa rivista trimestrale, e poiché mi piaceva molto, ed era piaciuta, ho deciso di autopubblicarla. Ho pubblicato prima un’edizione digitale, e infine ho deciso di raccoglierla in un cartaceo. E’ già infatti fruibile in digitale, ma solo la prima metà.
La storia parla del fatto che in questa ipotesi narrativa, i grandi classici nel momento in cui divengono tali si incarnano; ma noi non dobbiamo saperlo: vi è infatti un incaricato dalle Muse che tiene il mondo all’oscuro della loro esistenza, e tiene sotto controllo i classici. Questo è soprattutto difficile perché queste persone sono estremamente prone ai vizi, perché hanno una vita così stilizzata, così definita, che è difficile vivere come i normali esseri umani. Un Dracula avrà sempre la tentazione di cavar sangue agli altri.
Nello specifico chi si occupa di questo controllo è Carlo Lorenzini, in realtà Pinocchio, che ha preso il nome del suo creatore vero (Carlo Lorenzini era il nome reale di Collodi), in onore del padre, e ha messo su un’agenzia investigativa per tirare a campare e per nascondere questo suo ruolo di “Guardiano delle storie”.
Sono tutte storie brevi: dodici storie brevi da quattro pagine ognuna, ma molto complesse nonostante la brevità, dove ci si confronta con vari classici: dal Fu Mattia Pascal a Chtulu.
La prima parte è più specializzata sulla letteratura italiana, ed era quella della Banca Antonveneta; la seconda è più internazionale. Si va da Chtulu a Casanova, a un altro mago dei nostri tempi, abbastanza palese.
Della Casa Editrice che vi pubblica cosa mi dite?
La Manfont in realtà non è una vera e propria casa editrice ma è una sinergia di autoproduzione. Chi vuole autoprodursi e vuole dividere le spese o ha bisogno di un aiuto e vuole collaborare con noi può pubblicare con noi, a patto che il prodotto sia sufficientemente professionale.
Alcuni miei ex studenti hanno pubblicato con me, e oggi sono professionisti del settore.
Uno di loro, Luca Baino, editor in chief, che lavora per la Becco Giallo, e pubblica fumetti d’inchiesta: oggi sull’Aquila, in passato sul Caso Calvi. Tra l’altro fumetti molto piacevoli. La Becco Giallo in particolare è una casa editrice che parla di tematiche moderne: Caso Calvi, Vajont, inchieste varie.
E’ dunque la prova che il fumetto può fare critica sociale e interessare anche delle tematiche contemporanee. Come vedete voi questo: cioè l’impegno dell’intellettuale nel mondo politico, che non vuol dire che debba schierarsi, ma almeno far sentire la sua voce, perchè in quanto intellettuale ha una visione del mondo particolare, e la capacità e la possibilità di indagare le cose del mondo con un mezzo più o meno di diffusione di massa, come può essere il fumetto? E’ condivisibile una linea che indaga la contemporaneità e la critica, quasi come un giornalista d’inchiesta, nel mondo del fumetto? Il fumettista può schierarsi?
Sì, assolutamente. Il fumetto d’inchiesta è parte fondamentale del panorama odierno, a partire dalle Graphic Novel.
Per parlare di fumetto politicizzato, si può citare Andrea Pazienza: uno dei più grandi fumettisti d’Italia, che ha pubblicato una serie di opere in cui satirizzava in modo molto ironico, ma anche artistico, la situazione politica dell’epoca. E’ poi morto di overdose. Un vero bohemienne, un autore completo che ha vissuto una situazione politica molto complessa.
Al giorno d’oggi c’è un pochino poca roba. C’è Makkox, un artista molto politicizzato, ma meno autori interessati alla politica rispetto a una volta, proprio perchè la politica in generale ha deluso tutti.
Destra, sinistra, sembra che ci sia una delusione completa: una volta c’era la speranza che le cose potessero cambiare. Oggi si pensa alla politica come a qualcosa di così sporco che anche all’artista che vuole dire qualcosa, passa la voglia.
Mediamente, qual è l’indirizzo politico del fumettista?
Con le debite eccezioni, il fumettista è di sinistra.
Esistono certo grandi fumettisti “di destra”. Il più famoso, quasi accusato di essere fascista nella sua destrorsità, è Frank Miller. E’ anche vero che lui si è ormai creato il personaggio e quindi continua per la sua strada. In Italia è sicuramente più facile trovare fumettisti di sinistra, o per lo meno che si dichiarino: a volte, e questo vale per tutti gli intellettuali, chi è di destra non lo dice.