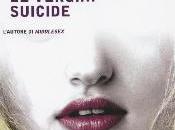Introdurre Julian Barnes è un’impresa per nulla difficile. Narratore tra i più apprezzati, sia nella sua Gran Bretagna che all’estero, autore di romanzi letti e acclamati negli anni come Il pappagallo di Flaubert (Rizzoli, 1987, traduzione di Riccardo Minardi) o England, England (Einaudi, 2000, traduzione di Susanna Basso) giusto per citarne alcuni. Si potrebbe dire che Barnes è, tra i romanzieri postmoderni, uno dei più accreditati, ma questo si allontanerebbe troppo dal nostro discorso, aprirebbe troppe parentesi. Il nostro intento qui è invece quello di parlare dell’ultimo romanzo di Barnes, Il senso di una fine, uscito in Inghilterra nell’agosto del 2011 per l’editore Jonathan Cape e pubblicato in Italia nel 2012 da Einaudi con la traduzione della solita, ottima, Susanna Basso. Ne avete sentito parlare perché per alcuni mesi è stato in cima alle nostre classifiche tra i libri più venduti di narrativa straniera. E probabilmente anche perché, come apprenderete dall’amabile fascetta rossa che lo avvolge, è vincitore del Man Booker Prize (potremmo dire, l’equivalente inglese del nostro Strega se solo una frase del genere non risultasse ridicola in modo insopportabile) per l’anno 2011.
Introdurre Julian Barnes è un’impresa per nulla difficile. Narratore tra i più apprezzati, sia nella sua Gran Bretagna che all’estero, autore di romanzi letti e acclamati negli anni come Il pappagallo di Flaubert (Rizzoli, 1987, traduzione di Riccardo Minardi) o England, England (Einaudi, 2000, traduzione di Susanna Basso) giusto per citarne alcuni. Si potrebbe dire che Barnes è, tra i romanzieri postmoderni, uno dei più accreditati, ma questo si allontanerebbe troppo dal nostro discorso, aprirebbe troppe parentesi. Il nostro intento qui è invece quello di parlare dell’ultimo romanzo di Barnes, Il senso di una fine, uscito in Inghilterra nell’agosto del 2011 per l’editore Jonathan Cape e pubblicato in Italia nel 2012 da Einaudi con la traduzione della solita, ottima, Susanna Basso. Ne avete sentito parlare perché per alcuni mesi è stato in cima alle nostre classifiche tra i libri più venduti di narrativa straniera. E probabilmente anche perché, come apprenderete dall’amabile fascetta rossa che lo avvolge, è vincitore del Man Booker Prize (potremmo dire, l’equivalente inglese del nostro Strega se solo una frase del genere non risultasse ridicola in modo insopportabile) per l’anno 2011.
The Sense of an Ending, il titolo originale, è anche il titolo di un saggio del 1967 di Frank Kermode, dal sottotitolo Study in the Theory of Fiction (Studi sulla teoria del romanzo). Sarebbe questo - vale a dire l’intitolare un romanzo alla stessa maniera di un saggio che parla della teoria del romanzo - un raffinatissimo espediente tipico delle tendenze postmoderne, ma lasceremo che sia il lettore più acuto a notare simili dettagli irrilevanti. Qui ci limitiamo a dire che Il senso di una fine è il racconto autobiografico di Tony Webster che, ormai sessantenne, ripercorre i passaggi più importanti della sua vita, per tirarne fuori i significati profondi. Il romanzo è diviso in due parti; nella prima, Tony ci racconta della sua giovinezza, degli anni trascorsi a scuola con il suo gruppo di amici, delle prime esperienze amorose, del rapporto con Veronica, del suicidio di Adrian - il più brillante del gruppo -, ci racconta di cosa significasse diventare piano piano adulti nella Londra borghese degli anni Sessanta; la seconda parte, dopo un rapidissimo riepilogo del periodo che separa il Tony adolescente dal Tony sessantenne, e quindi del matrimonio con Margaret, del divorzio, del ritiro in pensione, ci riporta nel 2011, al momento in cui il nostro protagonista riceve in eredità il diario del suo amico Adrian. A quel punto una serie di vicissitudini e di imprevisti legali lo costringono a riconfrontarsi con il suo passato. E lo costringono a incontrare Veronica, che adesso custodisce gelosamente il diario di Adrian, del quale trent’anni prima era stata la fidanzata.
E allora Tony, che per anni si è sforzato di sfuggire ai problemi, di vivere in maniera semplice, appartata, anonima, si ritrova a rispolverare il passato, a rivivere la propria storia. La sua storia che scopre essere nient’altro che il racconto della sua vita così per come lui lo ha costruito negli anni («la nostra vita non è la nostra vita, ma la storia che ne abbiamo raccontato»), una sua costante reinterpretazione di se stesso, un palinsesto in cui varie riscritture si sono sovrapposte, nella memoria, l’una sull’altra. La sua vita tranquilla diventa così, all’improvviso, mistero, anche per lui, anche per la persona stessa che l’ha vissuta. Tony capisce di non aver capito, scopre di aver sbagliato da qualche parte. Ma non è questo ciò che lo turba. A turbarlo è l’aver scoperto di non aver mai avuto la possibilità di capire davvero. Nessuno ce l’ha mai. Perché la vita ci passa attraverso e ci sovrasta e noi non abbiamo la possibilità di tenerle dietro. Lui che una volta, ancora inesperto, aveva saccentemente rivelato al suo professore che la storia è soltanto il racconto dei fatti narrato dai vincitori, adesso scopre che in quella affermazione - che noi lettori attenti sappiamo essere probabilmente ispirata da Walter Benjamin - c’è una falla. Adesso è chiaro. «Non è vero che la storia è fatta delle menzogne dei vincitori come sostenni una volta disinvoltamente con il vecchio Joe Hunt; adesso lo so. È fatta più dai ricordi dei sopravvissuti, la maggior parte dei quali non appartiene né alla schiera dei vincitori, né a quella dei vinti».
Tony Webster capisce che nella vita di ognuno accadono piccole tragedie inenarrabili e che davvero, come disse sua suocera un tempo, «siamo stati tutti vittime di un abuso», solo che non siamo in grado di rendercene conto. Come per le scatole nere degli aerei, la vita cancella automaticamente la traccia di quanto accade durante il tragitto; per far in modo che la traccia rimanga è necessario un precipizio, è necessario uno schianto. Per poter capire davvero è necessario che la vita perfori il nostro stato di serenità e armonia, che ci metta davanti allo scheletro nudo delle nostre vicende personali. È necessario che il tempo agisca «come solvente». E sarà comunque sempre troppo tardi. Perché saremo già arrivati alla fine «di ogni probabilità che qualcosa cambi». Il «senso di una fine» dunque, non è il senso di una fine specifica, di una tra le tante possibili (in questo ci inganna un po’ la difficile traduzione dall’inglese). Significa che il senso della fine è l’unico a cui ci è concesso accedere. Il resto sarà solo una nostra illusione.
Il romanzo di Barnes è un «romanzo filosofico», possiamo dirlo senza remore e sciogliere così i dubbi che Antonio Sgobba si pone sapientemente sul blog «Minima&Moralia». È un romanzo perché c’è la storia di una vita, degli amori, delle difficoltà da affrontare, c’è un punto di rottura da ricomporre. Ed è filosofico perché la narrazione funge solo da espediente per lanciare una riflessione profonda e pungente sul senso delle cose, della storia, della vita, del trascorrere del tempo, della fatica di diventare adulti e disillusi; ma anche sul senso del senso stesso che di queste cose ci facciamo nel corso degli anni. Julian Barnes offre al lettore tre chiavi di lettura. La prima è quella più semplice e sta nella trama, nel giallo da sciogliere nelle scelte del personaggio, nei suoi nuovi approcci con l’ex fidanzata Veronica. La seconda contiene la prima e consiste nella meditazione sui significati profondi della Storia e delle storie, maiuscole e minuscole, collettive e individuali, sull’interpretazione che di esse diamo e su quella che possiamo dare. La terza e ultima è più difficile; è quella che ci invita a mettere di fronte la vita e la letteratura (ce lo suggerisce il titolo tratto da un saggio di critica letteraria) per cercare di capire quale delle due cose sia rappresentazione e riflesso distorto dell’altra («ecco una delle nostre paure, che la vita potesse rivelarsi diversa dalla letteratura»).
E poi su questi interrogativi e spunti di riflessione arriva la fine; la fine del racconto, la fine del tempo, la fine delle nostre avventure personali, la fine della possibilità di cambiare le cose. Ed ecco l’unica certezza che abbiamo; con la fine dovremo fare i conti. E, nel farlo, saremo sempre soli.
«Certe volte penso che lo scopo dell’esistenza sia quello di riconciliarci, per sfinimento, con la sua perdita finale, dimostrandoci che, indipendentemente dal tempo che ci vorrà, la vita non è affatto all’altezza della propria fama».
Media: Scegli un punteggio12345 Il tuo voto: Nessuno Media: 4 (1 vote)