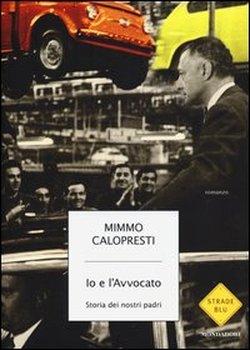 Si dice in genere che non si dovrebbe giudicare un film dal romanzo da cui eventualmente è stato tratto. Si dice, ma quasi mai si fa. Anche le migliori intenzioni e la più solida consapevolezza delle differenze tecniche e metodologiche difficilmente riescono a prevenire la tentazione di giudicare l'uno sulla base dell'altro.
Si dice in genere che non si dovrebbe giudicare un film dal romanzo da cui eventualmente è stato tratto. Si dice, ma quasi mai si fa. Anche le migliori intenzioni e la più solida consapevolezza delle differenze tecniche e metodologiche difficilmente riescono a prevenire la tentazione di giudicare l'uno sulla base dell'altro.
Rovesciando l'assunto di partenza, lo stesso discorso dovrebbe valere quando è un regista a cimentarsi con la letteratura, come è il caso di questo esordio di Mimmo Calopresti con Io e l'Avvocato: Storia dei nostri padri (Mondadori, 2013). Bisognerebbe, a parità di presupposti, riuscire a leggere questo libro evitando di cercare indizi che riconducano all' esperienza cinematografica del suo autore, per concentrarsi solo sugli aspetti eminentemente narrativi. Ci si può provare, ma la domanda è: ci si riuscirà?
Il titolo Io e l'Avvocato: Storia dei nostri padri riassume, al massimo grado di sintesi, l'intera trama. Chi altri può essere, nella memoria collettiva, l'Avvocato con la A maiuscola se non Gianni Agnelli? Chi sia l'Io è persino superfluo sottolinearlo. Ma chi sono "i nostri padri"? Perché "nostri" e non semplicemente "padri"?
Ecco, allora, che già dal sottotitolo si rivela la struttura chiastica che accompagnerà tutta la narrazione: all'Avvocato, qui rievocato principalmente nel suo ruolo di padre dell'unico figlio maschio, Edoardo, si contrappongono (o piuttosto si pongono in parallelo) le figure di Emilio Calopresti, il padre dell'Io del titolo, e quella dell'altro figlio, Mico.
Si delinea, in questo modo, il doppio binario su cui viaggia il romanzo: da una parte gli Agnelli, con tutto il bagaglio, implicito ed esplicito, di ascendente economico-politico-culturale che la famiglia ha avuto sul nostro Paese; dall'altra la parabola di un umile sarto calabrese che, rimasto senza lavoro negli anni '60, fece quello che molti altri meridionali fecero nello stesso periodo (e prima, e dopo): attraversare la penisola, risalirla fino alla grande città, Torino, alla ricerca di una nuova vita e di un nuovo lavoro, in Fiat. Che diventa il vagone dove le storie dei due padri si sfiorano senza quasi mai incontrarsi, mentre i figli - solo apparentemente più lontani - finiscono per incrociarsi per davvero, toccarsi persino, in un cerchio ristretto di conoscenze comuni e allo stesso tempo straordinarie, al cui centro ritroviamo la figura di Don Luigi Ciotti.
Si tenta, a questo punto, per quanto ellitticamente, un'indagine interiore di due ragazzi ognuno inquieto a modo suo, tra grumi di depressione e avanzi di crisi, che porta, tuttavia, a esiti diversi: da un lato il fragile, quasi ascetico, a tratti doloroso Edoardo, dall'altro l'irriducibile, indocile, ostinato Mico. E a un'imprevedibile inversione di ruoli, che sembravano invece già segnati, incisi nel nome e nelle figure dei capifamiglia: entrambi rinunciano a seguire la strada dei padri, ma alla fine drammatica dell'uno fa da contrappasso lo slancio vitale che porterà l'altro a rompere gli indugi per intraprendere quella carriera che lo porterà dietro la macchina da presa. Quanto hanno effettivamente contato le condotte dei rispettivi padri sulle scelte e sulla sorte dei figli, questo sta al lettore deciderlo leggendo.
Il testo conserva una struttura narrativa fondamentalmente classica; ciononostante la pluralità dei codici, letterario e filmico, quest'ultimo congenito al Calopresti regista, non possono non contagiarsi qua e là: nel montaggio dei capitoli, per esempio, paragonabili ora a singoli fotogrammi, ora a intere sequenze; nella loro stessa titolazione, suggerimenti di regia, indicazioni tipiche di una sceneggiatura (interno notte/esterno notte/interno ufficio); nella voce in campo (narratore interno) che si appaia a quella fuori campo (narratore esterno). Oltre ad alcuni topoi spesso ricorrenti nella cinematografia di Calopresti qui recuperati in chiave narrativa: la puntigliosa ansia di esplorare ogni sentimento senza affettazione, l'incomunicabilità in particolare, nella cui dimensione evanescente sono collocati, non a caso, i personaggi di Agnelli e figlio. E, infine, i simboli: la fabbrica (la Fiat) e la città (Torino).
A questo punto è evidente che la risposta alla domanda di cui sopra è: arduo separare completamente il regista dallo scrittore, non solo in quanto i due statuti ontologici, pur non combaciando perfettamente, si sovrappongono in più di un punto (entrambi raccontano una storia, per immagini o attraverso le parole), ma soprattutto, trattandosi della medesima persona, sarebbe come voler separare la mente dal cuore, sarebbe bello ma...
Alla prova dei fatti questo libro si trova al centro di un trivio perfetto tra documentario, autobiografia e romanzo. Ma a funzionare meglio sono il documentario: accurato, minuzioso, attento (la riduzione della manodopera in Fiat, la razionalizzazione produttiva, la marcia dei quarantamila), e l'autobiografia: morbida memoria che richiama l'infanzia, i sapori, i toni, le sfumature della Calabria natia, l'intimità, la semplicità della propria famiglia, fino a divenire ispirata, nel finale, al momento di contemplare il futuro. Il romanzo, il non vissuto, il ricostruito (la storia degli Agnelli, insomma), mostra la mano incerta dell'esordiente, didascalica, incolore. O più semplicemente troppo timida, pudica nell'esporsi, per la prima volta, alla vista del pubblico.
Certamente non imputabili ad alcuna forma di inesperienza o immaturità sono, invece, i tanti refusi di stampa presenti: da una casa editrice come la Mondadori ci si aspetterebbe maggiore perizia nella revisione dei propri testi.






