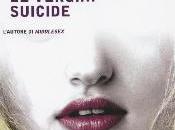La piel que habito, Spagna, 2011, 117 min.
La piel que habito, Spagna, 2011, 117 min.
Con La pelle che abito Almodovar sembra discostarsi dai suoi tipici melodrammi caratterizzati da complicati intrecci, personaggi sempre sopra le righe e situazioni paradossali, per portare lo spettatore in un intenso thriller psicologico (che però più carnale di così non potrebbe essere) con un soggetto decisamente forte. Il regista ha sempre avuto uno stile estremamente personale e riconoscibile, ma è innegabile come nelle ultime pellicole sia andato incontro ad un manierismo ripetitivo e piuttosto sterile. Per questo La pelle che abito costituisce una scommessa – e anche piuttosto rischiosa – per rilanciarsi e mettersi in gioco, cercando di far emergere la propria autorialità anche in un prodotto all’apparenza estraneo al suo percorso.
Robert (Antonio Banderas) è un metodico e ambizioso chirurgo plastico che ha concentrato tutte le sue ricerche su un solo progetto: l’invenzione di una pelle estremamente simile a quella umana ma sintetica, in grado di resistere a bruciature e punture di insetti. L’idea gli è venuta in seguito ad un evento tragico: la moglie era infatti rimasta completamente ustionata in un incidente automobilistico. La sua successiva morte, unita a quella della figlia per le conseguenze di un presunto stupro, hanno prodotto in lui un senso di vuoto e di vendetta acutissimi che si materializzano nella sperimentazione di questa nuova pelle su un soggetto umano scelto con attenzione e con il quale si instaurerà un ambiguo rapporto.

Banderas ritrova il regista che lo aveva lanciato a più di vent’anni di distanza dalla loro ultima collaborazione per Legami! interpretando forse uno dei suoi personaggi più complessi ed è bravo nel rendere la figura di questo medico sempre controllatissimo, ma con una scintilla di lucida follia nello sguardo. La sua interpretazione trattenuta viene però superata da quelle di Marisa Paredes e Elena Anaya, le due figure femminili a lui vicine. La prima interpreta Marilia, la madre/domestica di Robert, tipico personaggio del mondo almodovariano, sofferente e amorevole al tempo stesso. La seconda è la bellissima Vera, la co-protagonista, il risultato dell’esperimento del chirurgo. Lei ha il compito più difficile: interpretare due persone nello stesso corpo, dover dimenticare, cambiare e infine ritrovare la propria identità; un lavoro fatto di sguardi e sensualità, rabbia repressa e confusione che colpiranno lo spettatore con violenza e morbosità.

EDA