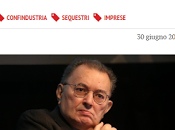di Antonio Scarazzini
Lo scorso 10 luglio la Duma ha ratificato l’ingresso della Russia nella World Trade Organization schiudendole definitivamente le porte del sistema commerciale internazionale. Storia di un cammino lungo quasi vent’anni e di un altro che è appena cominciato.
Gli anni Novanta, i primi drammatici passi alla scoperta del capitalismo

Non a caso i primi passi mossi per abbandonare la pianificazione socialista a favore dell’economia di mercato coincisero con alcuni dei più drammatici fallimenti delle logiche del “Washington consensus”, di cui l’apertura dei mercati e la liberalizzazione degli investimenti esteri costituivano parte integrante. Ragioni e colpe dei disastri economici che condussero al default del 1998 vanno dunque ascritte alla miope applicazione dell’ideologia mainstream e di politiche economiche, quali il “Mass Privatization Program” o la revisione del sistema di preferenze commerciali, che miravano a sradicare i residui dell’economia socialista per impiantare un modello fondato su privatizzazioni e competizione, totalmente estraneo ed insostenibile per una base produttiva cresciuta sotto la tutela della pianificazione centrale e dei sussidi statali.
Ai governi di Anatoli Chubais e Yegor Gajdar si può quindi imputare l’incapacità di riformare l’economia senza sconvolgerne repentinamente quelle basi che, per quanto inadatte a sopravvivere nel circuito mondiale, rappresentavano le uniche condizioni di political economy a disposizione della Russia dei primi anni ’90. Nel biennio ’92-’94 i primi due governi succedutisi sotto la presidenza di Boris Eltsin furono infatti incaricati di ridurre il gap che separava la neonata Federazione Russa dagli standard minimi previsti dal Gatt-Wto: una volta eliminati il monopolio statale sul commercio estero e il regime di prezzi governativi, fu la volta di severi ritocchi alla politica tariffaria in base al principio di nazione più favorita. La sommatoria di prezzi stabiliti dal mercato, importazioni alleggerite dai dazi (che arrivavano a toccare anche il 30% sul valore) ma penalizzate da un rublo svalutato si tradusse in iperinflazione e panico in un complesso industriale assolutamente inadatto alla competizione mondiale.
A questo si aggiunse il profondo squilibrio generato dalle privatizzazioni di massa [1] – le cosiddette voucherizzazioni – delle oltre 75000 imprese statali: operai e impiegati si ritrovarono al timone di aziende con produzioni obsolete e senza le adeguate capacità manageriali. Malgrado il “Mass Privatization Program” riguardasse circa il 70% del totale, circa 14000 rimasero poi sotto il controllo del Cremlino mentre in altre 2500 lo Stato rimase socio al 25%; tra queste ci furono i grandi colossi del comparto energetico (Yukos, Lukoil, Rosneft, Gazprom) che furono oggetto di privatizzazioni solo parziali e di programmi quali il “Loans for shares” che consentivano a pochi imprenditori già in possesso di ingenti capitali di finanziare il governo in cambio di quote azionarie delle società di maggior interesse strategico.
Gli oligarchi erano ormai entrati in scena e all’esplosione della crisi del 1998 l’economia russa aveva fallito nel riformarsi in senso liberale: inefficienza produttiva e burocratica non erano state intaccate dalle prime riforme “pro-WTO”, i programmi di aggiustamento strutturale del FMI non favorirono l’afflusso di investimenti esteri e le esportazioni di idrocarburi furono piegate dal crollo del prezzo del greggio. Collusione fra grandi imprenditori e sistema politico facevano della Russia l’emblema perfetto del crony capitalism, il capitalismo corrotto e incapace di liberare le forze virtuose del libero mercato.
L’avvento di Putin
Malgrado il primo fallimentare approccio con le regole dell’economia di mercato, i Paesi del Gruppo di Lavoro in sede WTO incaricato di esaminare il Memorandum di ammissione della Russia avevano già avviato i negoziati: nel 1996 le delegazioni erano pronte a discutere delle normative sulle barriere non tariffarie e sui dazi agricoli, mentre dal 1997 presero il via i negoziati bilaterali, in primis con Stati Uniti, Unione Europea e Giappone.
Si trattava ora di guidare la nuova Russia attraverso modifiche alle proprie legislazioni di impresa, ai sussidi agricoli e industriali – ossia a tutti gli strumenti economici che avevano retto un’economia di sussistenza – conciliandole con esigenze di rapida crescita e modernizzazione. La caotica era Eltsin terminò nel 2000 con l’elezione di Vladimir Putin al Cremlino: nell’agenda del presidente neoeletto, l’ingresso nella WTO faceva bella mostra di sé insieme a quella strategia di controllo delle risorse strategiche che del “putinismo” divenne marchio di fabbrica.
Sull’onda del rialzo dei prezzi del greggio, il PIL tornò a crescere a doppia cifra, con un avanzo medio di bilancia commerciale di oltre 40 miliardi di dollari. Le risorse energetiche trasformate in sapienti armi politiche sembrarono ridare alla Russia la giusta credibilità per sedersi ai tavoli internazionali e al termine del primo mandato presidenziale, nel 2004, Putin poteva vantare innegabili progressi nella marcia verso il WTO: i negoziati bilaterali con l’Ue erano giunti a compimento, delineando quegli impegni di politica doganale che ritroviamo nel rapporto finale del Gruppo del Lavoro approvato nel novembre 2011 dalla Conferenza Interministeriale del club ginevrino.
Ben tredici gli incontri del Working Party tenuti fra il 2002 e 2004 [2] per individuare i settori di maggiore criticità: difesa dei diritti di proprietà intellettuale (accordi Trips), introduzione di una legislazione in materia di protezioni di investimenti esteri (accordi Trims) e adeguamento dei codici giuridici alle minuziose normative Gats in tema di commercio in servizi misero in seria difficoltà un sistema amministrativo ancora troppo avvezzo alla vischiosità burocratiche.
Tanti, troppi i nodi insoluti: le restrittive norme in materia di “branch banking” potevano far storcere il naso ai colossi finanziari internazionali cui veniva impedito di aprire filiali indipendenti, mentre dai settori “iperprotetti” come quello automobilistico si levavano voci – su tutte quella di Oleg Deripaska, allora detentore del marchio Rospromavto e ora presidente di GAZ – per mantenere i dazi a difesa dell’industria nascente. Lo stesso comparto agricolo iniziò a temere per l’insufficienza dei cosiddetti “Green Box Subsidies”, un mix di sovvenzioni allo sviluppo tecnologico e di prezzi calmierati non sanzionabili in sede WTO, quando fu prospettato il taglio degli aiuti diretti al settore.
Diatribe sul gas e ripensamenti, Ginevra si allontana
Con il caos economico e sociale dei primi anni Novanta ancora fresco nella memoria, il Vladimir Putin del secondo mandato (2004-2008) non sostenne la causa WTO con lo stesso entusiasmo i primi giorni. Nel 2005, d’altronde, erano già stati raggiunti accordi bilaterali con 56 dei 59 paesi partecipanti al Gruppo di Lavoro e il presidente ebbe buon gioco nel rallentare il cammino del proprio paese verso il WTO. La politica energetica tornò ad avere il sopravvento sull’esigenze di riforma del mercato e dell’industria nazionale. Le nuove linee di fornitura previste per i corridoi Nord e Sud (Northstream e Southstream) e la longa manu di Gazprom legavano a doppio filo le sorti degli approvvigionamenti europei ai giacimenti russi, ma nel “great game” giocato dal Cremlino sull’energia risiedevano anche pressanti ragioni di politica interna.
Gas e petrolio continuavano a trainare il PIL ma dietro ai contratti trentennali di esportazione il cui prezzo superava di gran lunga i 100 $ (sino ai 160 durante la crisi del gas con l’Ucraina) per migliaio di metri cubi (mmc), si nascondeva infatti un tipico paradosso dell’economia russa: sul territorio nazionale (cui nel 2007 veniva destinato circa il 70,9% della produzione totale) Gazprom veniva infatti obbligata a distribuire gas in una forbice di prezzo tra i 15 e i 20 $/mmc, valore largamente insufficiente a consentire margini di profitto e tale da giustificare la ricerca dello stesso nei contratti take or pay (acquisto di una quota annuale minima, spesso superiore al fabbisogno) stipulati – con scarso margine di trattativa – con i partner europei.
Fu l’Unione Europea a sollevare l’attenzione sulla criticità del dual pricing, ossia del divario fra i pezzi di vendita in patria e all’estero, in quanto forma di indebito sussidio fornito all’economia russa (in particolare ai cosiddetti settori energy intensive). Analisi giuridiche come quelle di Sergey Ripinsky [3] dimostrarono tuttavia l’impossibilità di perseguire tale fenomeno come forma di sussidio presso i panel WTO. Per quanto certamente fruito attraverso un organo statale (tale era Gazprom data la quota di maggioranza del Cremlino), il sussidio di un gas fornito a prezzi artificiosamente bassi veniva goduto da tutto il complesso industriale, con l’impossibilità di individuarne la specificità del settore cui fosse destinato richiesta per attivare la procedura di infrazione. Gli effetti più diretti del dual pricing si vedevano dunque in politica sociale, mirata a sovvenzionare gli strati più deboli della popolazione riducendo i costi di produzione dell’energia elettrica e calmierando i costi di riscaldamento delle unità immobiliari.
Nel confronto fra forze modernizzatrici e difesa dello status quo, fecero poi in tempo ad inserirsi anche crisi geopolitiche e piccoli colpi di scena. La crisi del gas del 2006 aveva ifnatti rallentanto i negoziati con l’Ucraina mentre la guerra con la Georgia, scoppiata nel 2008, arrestò momentaneamente le trattative, risoltesi positivamente solo nell’autunno del 2011. Scalpore fece poi la volontà manifestata da Vladimir Putin nel 2009 di interrompere il processo individuale di adesione per perorare la causa di un’unione doganale con Bielorussia e Kazakhstan, che avrebbe a sua volta fatto richiesta di ingresso nella WTO. Il progetto perse di intensità, pur venendo riconosciuto anche dai documenti finali del Working Party, e dopo quasi un anno di balbettii Mosca decise di proseguire individualmente. Nel 2010 videro il traguardo i negoziati con gli Usa, spianando la strada verso l’obiettivo che venne finalmente ufficializzato nel dicembre 2011 durante i lavori dell’Ottava Conferenza Interministeriale.
* Antonio Scarazzini è Dottore in Studi Internazionali (Università di Torino)
[1] Vedi A. Shleifer, “The Politics of Russia’s Privatization Program”, Carnegie Council Privatization Project, n.15 – 1992 e B. Djelic – D. Sachs, “The Russian Mass Privatizion Program”, Privatisation International 04/01/1992
[2] Per una cronologia dei lavori Main stages of Russia’s WTO accession negotiations
[3] Sergey Ripinski, “The system of gas dual pricing in Russia: compatibility with WTO rules”, World Trade Review, 3 : 3, 463 – 481, 2004