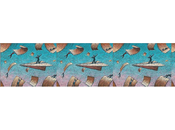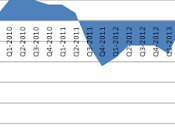L’articolo riportato qui, e tratto da Controlacrisi.org sotto merita un’attenta lettura.  Anzi è consigliabile a chi si interessa poco di economia uno sforzo in più, per non limitarsi alle sintesi della tivù. L’argomento del bilancio europeo è complicato ma è l’emblema di una politica economica continentale che si contrae. Tre miliardi di euro in meno nel bilancio complessivo e l’impossibilità di uscire dallo gabbia di ferro in cui l’Italia come altri Paesi si trova, chiusa dal rigore del fiscal compact, che costringerà lo Stato a ripianare il debito in meno di dieci anni per portarlo al 60% del Pil. Il bilancio europeo per i prossimi setti anni non potrà fare affidamento su una disponibilità maggiore, bensì minore: meno addirittura dell’1% del Pil dei Paesi membri. Invece di investire nelle infrastrutture realmente utili, ricerca e formazione, reti di trasporto, si taglia. Vince ancora la linea del rigore, la politica restrittiva, con la quale non si potrà creare sviluppo, soprattutto in Italia, dove i ricavi dell’industria, nel suo complesso, crollano addirittura di un terzo, un dato negativo su cui incidente con forza il calo dei consumi. Il cerchio si chiude rimpicciolendosi. Così non si esce dalla crisi. Bisogna cambiare le regole liberiste e rigoriste con cui è stata costruita questa prigione europea nella quale siamo rinchiusi. Fuori, va ricordato, c’è il vuoto.
Anzi è consigliabile a chi si interessa poco di economia uno sforzo in più, per non limitarsi alle sintesi della tivù. L’argomento del bilancio europeo è complicato ma è l’emblema di una politica economica continentale che si contrae. Tre miliardi di euro in meno nel bilancio complessivo e l’impossibilità di uscire dallo gabbia di ferro in cui l’Italia come altri Paesi si trova, chiusa dal rigore del fiscal compact, che costringerà lo Stato a ripianare il debito in meno di dieci anni per portarlo al 60% del Pil. Il bilancio europeo per i prossimi setti anni non potrà fare affidamento su una disponibilità maggiore, bensì minore: meno addirittura dell’1% del Pil dei Paesi membri. Invece di investire nelle infrastrutture realmente utili, ricerca e formazione, reti di trasporto, si taglia. Vince ancora la linea del rigore, la politica restrittiva, con la quale non si potrà creare sviluppo, soprattutto in Italia, dove i ricavi dell’industria, nel suo complesso, crollano addirittura di un terzo, un dato negativo su cui incidente con forza il calo dei consumi. Il cerchio si chiude rimpicciolendosi. Così non si esce dalla crisi. Bisogna cambiare le regole liberiste e rigoriste con cui è stata costruita questa prigione europea nella quale siamo rinchiusi. Fuori, va ricordato, c’è il vuoto.
Italia ( e Europa ) a un bivio: La sfida di Rivoluzione Civile
11/02/2013 di Bruno Steri
Nel week-end appena trascorso, le prime pagine dei quotidiani hanno dato ampio spazio a due notizie che
ben caratterizzano il contesto generale in cui saranno celebrate le prossime elezioni politiche. La prima
concerne il dato sulla secca caduta della produzione industriale del nostro Paese; la seconda riguarda l’esito
(“deludente” secondo D’Alema, direi io catastrofico) della trattativa sul varo del bilancio dell’Unione Europea
per il prossimo settennato (2014-2020). Si tratta di due questioni fortemente connesse, che costituiscono
l’ennesima riprova del fallimento delle politiche neoliberiste, così come vengono promosse sul piano nazionale
e su quello europeo: un fallimento che inesorabilmente chiama il centro-sinistra a rispondere del suo operato,
quello del recente passato e quello dell’immediato futuro.
Il Sole 24 Ore ha evidenziato i dati di un’analisi condotta da Prometeia e Intesa San Paolo sul crollo del settore
manifatturiero italiano: tra il 2011 e il 2012, i ricavi della nostra industria hanno subito un decremento di 37
miliardi di euro, equivalente a un calo del 6% del fatturato. In cima alle performances negative figurano i
settori che producono beni di consumo durevole (dalle auto agli elettrodomestici), ma tutti i quindici comparti
esaminati (ad eccezione dell’alimentare) vanno indietro. E’ qualcosa di più di un campanello d’allarme, per un
Paese la cui fisionomia resta legata a doppio filo alla manifattura: l’industria vale infatti il 24,7% del prodotto
interno lordo italiano (dati di Area Studi Mediobanca). Va rilevato che il declino è stato reso meno pesante dalla
buona prova dell’export: senza l’aumento del fatturato sui mercati esteri (+15 miliardi di euro), il saldo sarebbe
stato ancor più negativo. Ciò significa che a incidere sul secco arretramento produttivo è stata, in modo
determinante, la contrazione dei consumi degli italiani. Lo sottolinea il titolo del quotidiano padronale: “Sul
risultato pesa il crollo del mercato interno”. Anche questo è un fatto ampiamente confermato dalle rilevazioni:
l’Indicatore dei consumi Confcommercio (Icc) registra per il 2012 un calo del 2,9%, il peggior dato degli ultimi
12 anni (cioè da quando è calcolato il suddetto indice). Ma per Federconsumatori e Adusbef , questo stesso
dato di Confcommercio è sottostimato: secondo le due associazioni, il calo dei consumi supera il 6%. Superfluo
ricordare che per siffatti risultati dobbiamo ringraziare il governo Monti, con il suo rigore e i suoi tagli, nonché
il centro-sinistra, il centro e il centro-destra che lo hanno sostenuto.
Ma dobbiamo ringraziare anche questa Europa, la sua conduzione tecnocratica e antipopolare, che quel rigore
e quei tagli ha imposto e intende continuare a imporre. Ne è emblematica dimostrazione il secondo evento
eclatante cui ci riferiamo. Come hanno diffusamente riportato tutti i mezzi d’informazione, il bilancio Ue per il
prossimo settennato, rispetto a quello dei sette anni precedenti (2007-2013), anziché aumentare è diminuito
del 3%: è la prima volta che ciò accade ed è la conseguenza della pressione dei Paesi forti (Germania
su tutti), assecondata dalla spinta centrifuga della Gran Bretagna (ormai con un piede fuori dall’Ue). Non
sarà un certificato di morte per l’Unione, ma certamente si tratta di un referto di coma profondo. Invece di
dare ossigeno a economie strozzate dalla recessione e dal drammatico aumento della disoccupazione, si va
addirittura sotto il già magro budget, fermo a un risibile 1% del Pil complessivo dei Paesi membri. Si salvano
i contributi all’agricoltura (cui tiene soprattutto la Francia), si attenua l’esposizione dell’Italia (già contributore
netto, nel senso che versa alla cassa europea più di quanto non riceva), ma per il resto è stroncata sul
nascere ogni prospettiva di crescita: essendo tagliati stanziamenti per infrastrutture, reti del trasporto, della
comunicazione e dell’energia, ricerca e formazione. Come dire: il futuro non è per noi. E’ la logica liberista
dell’austerity, su cui peraltro questa Europa è stata eretta.
Quando si decise di lanciare la moneta unica, furono stabiliti vincoli uguali per tutti su deficit e debiti pubblici
(parametri di Maastricht), alla Bce fu affidato esclusivamente il controllo dell’inflazione e l’azione su tassi
d’interesse e cambio. Rigore finanziario a garanzia del valore della moneta, libera concorrenza a garanzia del
mercato unico europeo: è questo il “paradiso neoliberista” che è stato tradotto nei trattati. La competitività del
sistema industriale e i livelli occupazionali sono rimasti e tuttora restano un affare dei singoli Paesi. Così come
le politiche del lavoro e le politiche fiscali, su cui ciascuno viaggia per proprio conto: vigendo su tali materie
l’obbligo dell’unanimità, ciascun membro può esercitare un diritto di veto su qualunque proposta tendente a
introdurre in merito una sgradita uniformità comunitaria. Così i capitali sono liberi di andarsi a cercare l’offerta
migliore, in termini di legislazione del lavoro e di penalizzazioni fiscali. Ma attenzione, è un paradiso che oggi
rischia di implodere, a seguito dell’acuirsi delle tensioni che questo stesso assetto ha generato tra la “periferia”
dell’Unione e il suo centro più ricco.
Nonostante il frastuono della grancassa propagandistica, tali tensioni non derivano tanto dall’allarme sui debiti
pubblici dei singoli Paesi: la Spagna è nell’occhio del ciclone, eppure nel 2008, con la crisi nascente, essa
vantava un rapporto debito/Pil del 36%, mentre questo medesimo rapporto era in Germania del 65%. Ancora
oggi la Spagna fa registrare un rapporto tra debito e Pil più basso di quello tedesco (68% contro 81%).
Non è tanto il debito pubblico il parametro più sensibile, quello che eminentemente segnala ai mercati la
salute complessiva dell’unione monetaria e che fa divergere gli spread. Come ribadito da più di un operatore
economico e da economisti non embedded, tale indicatore va piuttosto identificato con lo squilibrio delle
partite correnti, con il divergere dei conti con l’estero dei Paesi membri: di qua, il saldo del commercio
estero della locomotiva tedesca in costante e crescente avanzo; di là, quello dei cosiddetti Piigs (Portogallo,
Irlanda, Italia, Grecia, Spagna) in crescente disavanzo. Sulla linea ascendente la Germania, favorita dal
passaggio all’euro e dalle politiche di contenimento salariale (a partire dalle misure a suo tempo varate con
l’Agenda 2010 del socialdemocratico Schroeder) a sostegno della competitività delle sue merci; su quella
discendente i Paesi del Sud Europa, penalizzati dall’impossibilità di operare svalutazioni competitive. Per
riequilibrare verso l’alto il suddetto divario, occorrerebbe “europeizzare la Germania”: cioè aumentare i salari
tedeschi proporzionalmente al livello di produttività raggiunto, così da incrementare la domanda interna e le
importazioni (dunque l’export verso la Germania). Al contrario, si persiste nel riequilibrare quel divario verso
il basso, “germanizzando la periferia europea”: cioè esportando l’austerità tedesca e riducendo i redditi da
lavoro in tutta l’eurozona. Deprimendo così, insieme al reddito, l’economia e l’occupazione.
La semplicissima verità è che, senza solidarietà, non c’è Europa che tenga. Se una regione va in crisi
(per debolezze strutturali del suo assetto geo-economico, per un terremoto o altro), lo Stato cui appartiene
dovrebbe automaticamente provvedere a trattamenti fiscali di favore, a politiche del lavoro e a programmi
di sostegno sociale ecc. In Europa avviene l’esatto contrario: chi si affanna sul pelo dell’acqua viene spinto a
fondo. La drammatica inadeguatezza del prossimo bilancio settennale è la riprova che questa Europa liberista
non solo è profondamente ingiusta, ma è anche incapace di darsi una realistica prospettiva di esistenza. Con
la crisi che inizia a mordere anche i più ricchi, la Germania – capofila dei Paesi “forti” – non rinuncia a godere
dei privilegi assicurati dall’attuale status quo e non vuole saperne di contribuire al bilancio comunitario con
trasferimenti netti a carico della sua ricchezza nazionale. Del resto, bisogna esser ciechi per non vedere che è
in corso un processo all’indietro, di rinazionalizzazione del panorama europeo.
Siamo giunti a un bivio: reso quanto mai stringente dall’involuzione del quadro complessivo. Le destre (ma
anche Grillo) hanno ormai imboccato la pericolosa strada dell’isolamento autarchico e del ripiegamento
nazionalistico; il centro-sinistra (l’agenda Monti ma anche la Carta d’intenti di Bersani) non è in grado di andare
oltre amichevoli suggerimenti nel quadro del rispetto dei patti europei, laddove occorrerebbero richieste
ultimative. Resta l’europeismo di chi non accetta questa Europa. Costruire con le sinistre d’alternativa europee
una dura opposizione al neoliberismo e ai patti europei (a cominciare dal fiscal compact) è l’unica strada, la
strada giusta da percorrere. E’ la strada di Rivoluzione civile.