3. Stupro – chi la fa, l’aspetti: la catarsi del rape and revenge
Hell Hath no Fury…

Il rape and revenge (letteralmente “stupro e vendetta”) è uno dei sottogeneri (e, per esteso, degli argomenti presenti in modo trasversale in pellicole di ogni genere e caratura) più discussi e attaccati dall’opinione pubblica, ma anche uno dei più persistenti poiché si presta efficacemente alla facile polemica che genera pubblicità gratuita e spesso di bassa lega. Il tema della vendetta è da sempre centrale nella narrazione filmica (si veda, ai giorni nostri, la produzione della Corea del Sud, in particolare la Trilogia della vendetta di Park-chan Wook), mentre la violenza sessuale è stata spesso lasciata fuori campo, sia per una forma di rispetto (o almeno così ci piace pensare) che, in primis, per più prosaici timori censori. Non è agevolissimo datare una vera e propria nascita del rape and revenge, forti tracce della tematica si possono ritrovare già nel capolavoro Bergmaniano La fontana della vergine (1960), e nel 1971 il grande Peckinpah turbò Hollywood con l’immenso Cane di paglia (Straw dogs), nel quale l’assalto sessuale non solo era mostrato, ma assumeva contorni moralmente ambigui. Nell’ambito dell’exploitation le barriere si fanno decisamente più ampie, con intenti che possono essere meramente provocatori o mirati al guadagno facile; in casi più rari, si uniscono anche intenzioni “alte”, messaggi che sovente vengono colti a distanza di tempo.

Un’umanità anche ironicamente mitizzata, come si denota dall’ emblematica presentazione del personaggio di Krug Stillo, che avviene principalmente a livello sonoro (il giornale radio che dà la notizia della fuga dei criminali): “Krug Stillo, che stava scontando l’ergastolo per il triplice massacro, nel 1966, di un prete e due suore”. Biglietto da visita ironico, come si diceva, nel suo non andare molto per il sottile nell’associazione tra il personaggio e il Male: d’altronde, Krug incarna l’altra faccia del Flower Power, di quella che, come dice la madre di Mari, “dovrebbe essere la generazione dell’Amore”. I riferimenti a Manson sono stati immediati ma non sono così fondamentali nel film, per quanto vi siano allusioni alla Family: è altro ciò che conta, ossia lo scontro di due nuclei famigliari, i reietti e quelli “perbene”, e questi ultimi non si rivelano di certo migliori dei primi. La forza de L’ultima casa a sinistra, come del resto di molti film dell’epoca, si ritrova proprio nel background sociale, politico e culturale che si porta dietro ma soprattutto in come è stato in grado di farlo trapelare, impregnando le immagini di un potenziale sadico e disturbante che resta intatto a distanza di oltre quarant’anni. La scena in cui Phyllis viene obbligata a farsi la pipì addosso, giusto per fare un esempio, mette lo spettatore in uno stato di profondo disagio, ben più di lunghe sequenze di tortura: è l’umiliazione, la sottomissione forzata, tutto questo riesce a toccare corde nascoste e dolorose.

Negli anni immediatamente successivi, il rape and revenge vede avvicendarsi una manciata di titoli controversi e dagli esiti alterni: ricordiamo Thriller (1973), di Alex Fridolonski, pseudonimo dello svedese Bo Arne Vibenius (in passato assistente di Bergman), film proiettato al Festival di Cannes dove, prevedibilmente, suscitò scalpore, e col quale il notevole L’Angelo della Vendetta (Ms 45) di Abel Ferrara, del 1981, presenta non poche analogie, oppure gli assai trascurabili Black alley cats e Rape squad, entrambi del 1974.
Quando ci si trova di fronte al remake del film di Craven, realizzato nel 2009 da Dennis Iliadis, ci si rende conto di quanto rifare un film così non solo sia stato inutile, ma anche del tutto fuori luogo: il goffo tentativo di attualizzare la vicenda si riduce a un’imitazione macchiettistica, una rielaborazione con cambiamenti apportati per far contento il nuovo pubblico, rendendo l’elemento violento più urlato, meno sottile, privandolo dei suoi sottotesti, e al tempo stesso limando ed edulcorando: Krug è un teppista prestante e muscoloso, il figlio Junior è belloccio e non tossicodipendente, quello che era il viscido personaggio di Weasel è qui ridotto a una nullità e si potrebbe continuare all’infinito. Si puntano i riflettori sulla sequenza dello stupro strizzando l’occhio agli incassi facili, e le psicologie dei personaggi sono tagliate con l’accetta. La magnifica sequenza dell’uccisione di Mari nel lago, inesorabile, macabra e poetica, qui diventa una scena action scandita da uno score simile a quello de Lo squalo: già questo è sufficiente a marcare una linea netta tra due modi di fare cinema che si pongono completamente agli antipodi, il primo incurante delle esigenze di mercato, il secondo al totale servizio di queste.
Il solito prodotto/pretesto che supplisce alla mancanza di idee, fa gonfiare i botteghini e mette in campo la becera scusa di far scoprire alle nuove generazioni il cinema “dei bei tempi che furono”. Si sa che oggi si vive di remake, ma vi sono territori filmici più delicati di altri, veri e propri campi minati in cui muoversi è rischioso. L’ultima casa a sinistra versione 2009 ha riscosso un buon successo in sala, com’era prevedibile, poiché ha offerto ciò che una buona fetta di pubblico vuole vedere: l’orrore edulcorato, rassicurante, ben lontano dal cinismo dell’illustre predecessore.
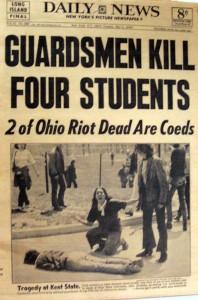
Oggi, si tende a credere che il fruitore di cinema abbia già visto tutto e ormai non sia più toccato da nulla, e in parte è vero, se si tiene conto del fattore assuefazione; d’altro canto, ciò che viene offerto nei circuiti delle sale è ripulito, mitigato, addomesticato. Un altro punto fondamentale è la diminuizione dell’empatia: l’orrore ci circonda ancora, forse anche più di ieri, ma ci sentiamo distanti da esso, muovendoci nel nostro piccolo spazio individuale senza prestare troppa attenzione a ciò che accade là fuori. E’ l’insieme di questi elementi a far sì che l’orribile di oggi lo sia un po’ meno, e che quando venga spinto il piede sull’accelleratore dell’eccesso si sconfini dal mercato convenzionale, finendo in territori di nicchia.

Sempre dai territori italici arriva il pregevolissimo Autostop rosso sangue (1977) di Pasquale Festa Campanile, tratto da un romanzo di Peter Kane e che vede nuovamente David Hess nelle vesti di villain, autostoppista in realtà criminale psicopatico in fuga. Walter Mancini (Franco Nero) e la moglie Eve (Corinne Cléry) non sono esattamente quel che si può definire una coppia felice: lui è un giornalista alcoolizzato, violento e abusivo verso la moglie, che è figlia del suo capo. Mancini è un fallito ed Eve è frustrata, sottomessa ma implosiva nel permettere che il marito la maltratti a proprio piacimento. Autostop Rosso Sangue è rape and revenge assai atipico poiché non possiede, in realtà, gli elementi fondamentali del filone in senso stretto: Eve è vittima dello stupro da parte di Adam (Hess) ma il suo atteggiamento è a metà tra il consenso e la provocazione verso il marito, che assiste impotente alla scena. Nel finale, c’è una vendetta profondamente diversa da quella vista finora in film di questa tipologia: Campanile realizza un’opera cinica, anche spietata, ricca di sfumature e ambiguità, che punta sul rovesciamento dei canoni classici del genere.

Nel 1978, giunge nelle sale quello che è considerato il film forse più rappresentativo del filone: Non violentate Jennifer (Day of the woman, meglio conosciuto come I spit on your grave), diretto da Meir Zarchi, che segue alla lettera lo schema narrativo tipico del sottogenere. Interpretata da Camille Keaton (già vista in Cosa avete fatto a Solange?, di Massimo Dallamno, 1972, nel ruolo della ragazza del titolo), insieme a un gruppetto di attori sconosciuti, l’opera di Zarchi è ancora oggi oggetto di dibattito, tra detrattori che la considerano gratuita e di poco conto, ed estimatori che le hanno attribuito chiavi di lettura più elevate e complesse. Censurata e bandita in molti Paesi con l’accusa di glorificazione dello stupro è stata, per contro, rivalutata da critici come Michael Kaminski, che nell’articolo “Is I spit on your grave really a misunderstood feminist film?”, apparso sul sito Obsessed with film, ne evidenzia il significato di denuncia e reazione alla violenza sulle donne; la docente (e femminista) Carol J. Clover, nel suo interessante saggio Men, women and chainsaws: Gender in the modern horror film (Princeton University Press, 1993), sottolinea come il film porti lo spettatore maschio a identificarsi con Jennifer e non con il carnefice, mettendo anche in luce il debito della pellicola di Zarchi verso Un tranquillo week-end di paura di Boorman. Al di là dei pareri contrastanti, quel su cui non si può discutere è il potenziale disturbante di I spit on your grave: la sequenza della violenza, della durata di circa trenta minuti (in seguito decurtati), è francamente intollerabile; la catarsi vendicativa è fragile, poiché si rischia di tornare al trito discorso sulla vittima che diventa peggiore del carnefice. L’ultima inquadratura, che vede Jennifer abbozzare mezzo sorriso, dopo aver sterminato i suoi aggressori, può essere eloquente in tal senso: la vendetta dopotutto, è una magra soddisfazione.
Alcune sequenze restano indubbiamente notevoli, come la “punizione” di Johnny nella vasca da bagno, sensualmente macabra, oppure il gesto della donna che subito dopo le sevizie risistema le pagine del proprio libro, nel voler rimettere insieme la sua integrità di persona. Il critico statunitense Roger Ebert stroncò il film, definendolo “uno spregevole sacco di spazzatura” (“a vile bag of garbage”); ciò che è interessante notare, leggendo la recensione di Ebert, è quanto il suo parere fosse senza dubbio condizionato dalle reazioni del pubblico in sala: dallo spettatore di sesso maschile che esortava gli stupratori a “darle ciò che merita” fino alla ragazza che urlava “sorella, tagliaglielo!”. E’ stato questo, forse più del film stesso, a spaventare il critico, ossia di come le immagini riuscissero a far uscire fuori il peggio da coloro che le stavano guardando.
La reazione del pubblico è diventata, per contro, quasi una giustificazione stando alle parole del regista del remake (2010), Steven Monroe: “A chiunque accada una cosa simile, o a chiunque sia vicino alla vittima di una cosa del genere, è inevitabile che passi per la testa il pensiero: io farei questo a chi ha commesso un tale crimine. Dunque, credo che la vendetta sia una grande liberazione emotiva per queste persone dopo che hanno assistito a ciò che gli uomini fanno alla protagonista” . Un punto di vista “di pancia” ma in ogni caso assai discutibile, specie se visto nel contesto di una società che sta diventando sempre più forcaiola e che spesso e volentieri torna a metodi triviali come il linciaggio o la giustizia privata. Ciò che disgustava Ebert (e molti altri) trent’anni fa è ora dunque visto non solo come accettabile, ma anche come giusto, questa è una differenza fondamentale. Il remake segue i meccanismi già visti ne L’Ultima Casa a Sinistra e molti altri rifacimenti, ossia una ripulitura visiva e un moralismo di fondo, a cui si aggiunge un dilungarsi della parte dedicata alle sevizie, riducendo quella sulla revenge (ma non doveva essere “liberatoria”?). Rape and revenge che si tramuta in torture porn, lo show della tortura, un non-genere che oggi rappresenta gran parte della produzione horror mainstream finto-scioccante: in poche parole, un pizzicotto spacciato per un pugno in pancia.

Con La casa sperduta nel parco (1980) di Ruggero Deodato, si torna in terreno nostrano, dunque a una concezione di “stupro e vendetta” al di fuori degli schemi: ancora una volta David Hess nei panni di Alex, che violenta una giovane in auto a inizio film (moglie dell’attore nella vita), e che, insieme a Ricky, il suo amico “non troppo sveglio” (Giovanni Lombardo Radice), viene invitato da un gruppo di ragazzi bene a una festa in una villa. Il cerchio si chiude nel finale, ma è il plot centrale che conta, le dinamiche tra i personaggi, i due outsiders che tengono sotto scacco i giovani ricchi e viziati: lotta di classe e violenza si mescolano, dando vita a un’altra ottima opera, un gioco del gatto col topo, nel quale spicca il rapporto ambiguo tra Alex e Ricky, dominante e dominato, sadico e masochista.

Chiara Pani
Nella prossima puntata: il fenomeno Guinea Pigs







