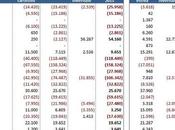I CAN’T BREATHE. Le ultime parole di Eric Garner riecheggiano nelle strade e nelle piazze di New York, si allargano alle comunità afroamericane di tutti gli Stati Uniti, volano su Youtube e rimbalzano sui social network; a cinquant’anni di distanza dalla straordinaria e terribile stagione del Movimento per i Diritti Civili di Martin Luther King, dalle battaglie del Black Islam e dalle idee oltranziste dei gruppi della black supremacy, le proteste dell’America nera s’incendiano nello scenario tormentato della politica a stelle e strisce e sfondano la barriera patinata dello show business. Nella notte del 6 dicembre, un grido bianco si staglia nell’atmosfera magica dello United Center: Derrick Rose si toglie la sopramaglia ufficiale e indossa una semplicissima t-shirt nera, ma il suo gesto provoca una tempesta di flash. Il lamento strozzato di Garner campeggia con l’ineffabile forza icastica della sintesi in un messaggio di passione civile.
I CAN’T BREATHE
La tempesta invade la Rete e travolge le coscienze sensibili di decine di atleti afroamericani; nelle serate successive i parquet più scintillanti d’America si riempiono di macchie nere che urlano lamenti muti per denunciare le contraddizioni di una società incapace di fare i conti con se stessa. LeBron James e Kevin Garnett, Kyrie Irving e Deron Williams, i Brooklyn Nets e i Cleveland Cavaliers, i Los Angeles Lakers e i Saint-Louis Rams della NFL; i messaggi di sostegno alle proteste dell’America nera accendono una cascata di partecipazione politico-civile e un temporale di dubbi negli uffici dell’Olympic Tower: il gesto degli atleti è meritorio e degno del più grande rispetto o rischia di spalancare gravi problemi di convivenza con gli ambienti del big business?
L’ANTEFATTO: LA MORTE DI ERIC GARNER E LA MANCATA CONDANNA DELL’AGENTE DANIEL PANTALEO
Il 17 luglio 2014 Eric Garner camminava lungo le pericolose strade newyorkesi di Staten Island con una borsa piena di sigarette di contrabbando. La mole imponente e i movimenti sospetti di questo 46enne attirarono l’attenzione della polizia: dopo una violenta aggressione, l’agente Daniel Pantaleo immobilizzò a terra Garner e cominciò a soffocarlo stringendogli la gola con un braccio: la presa chokehold – che mira a strangolare la vittima ed è vietata dal codice deontologico della NYPD – provocò immediate difficoltà respiratorie all’afroamericano, che soffriva di gravi disturbi asmatici. Il ripetuto grido “I can’t breathe” non impietosì il poliziotto di origine italiana: dopo lunghi secondi di strangolamento, Garner fu lasciato al suolo in stato d’incoscienza e non ricevette cure sufficienti. Se la sua morte scatenò forti proteste negli ambienti afroamericani, la recente assoluzione di Daniel Pantaleo da parte del Gran Giurì ha fatto esplodere la rabbia di una comunità che non ha mai goduto di autentiche pari opportunità di sviluppo umano all’interno della società statunitense.
LA MOBILITAZIONE DEGLI ATLETI: ESEMPI ILLUSTRI E PROFONDI SILENZI
 I gesti coraggiosi di alcune tra le stelle più luminose del firmamento NBA si appoggiano sulle illustri testimonianze di grandi campioni del passato. Nei torridi mesi del 1968 i duecentisti Tommie Smith e John Carlos stupirono il mondo con la protesta più famosa della storia dello sport: i pugni chiusi avvolti nei guanti neri che si stagliarono sul podio dello Stadio Olimpico di Città del Messico trovarono la piena e attiva solidarietà dell’australiano Peter Norman e provocarono un clamoroso terremoto nel movimento a Cinque Cerchi: i due velocisti manifestarono il loro sostegno al black power ed espressero una dura condanna delle ipocrisie dell’America WASP attraverso un’immagine che divenne subito una delle icone più note del Novecento. I profili austeri degli atleti richiamavano il boicottaggio che il giovane Lewis Alcindor e altre stelle dello sport americano avevano costruito in vista della rassegna messicana: mentre il re dello sky-hook disertò l’appuntamento più importante dell’autunno, altri alfieri della spedizione a stelle e strisce cercarono di conquistare il palcoscenico più prestigioso per mandare un chiaro messaggio al mondo. L’orgogliosa azione “ribelle” costò a Smith e Carlos l’espulsione dai Giochi Olimpici e infiniti problemi agonistici nelle stagioni successive; il “contro-boicottaggio” che il sistema mise in atto nei loro confronti ricordò in parte i durissimi attacchi mediatici e giudiziari che Muhammad Alì dovette subire dopo la conversione all’Islam e il rifiuto della chiamata alle armi. Il pugile più ineffabile di tutti i tempi pagò con la galera un desiderio di pace e di affermazione della propria identità razziale che aveva cominciato a manifestare già nel 1960, quando aveva scagliato nel Mississippi la medaglia d’oro che aveva vinto alle Olimpiadi di Roma poiché non era stato servito in un buon ristorante del Deep South.
I gesti coraggiosi di alcune tra le stelle più luminose del firmamento NBA si appoggiano sulle illustri testimonianze di grandi campioni del passato. Nei torridi mesi del 1968 i duecentisti Tommie Smith e John Carlos stupirono il mondo con la protesta più famosa della storia dello sport: i pugni chiusi avvolti nei guanti neri che si stagliarono sul podio dello Stadio Olimpico di Città del Messico trovarono la piena e attiva solidarietà dell’australiano Peter Norman e provocarono un clamoroso terremoto nel movimento a Cinque Cerchi: i due velocisti manifestarono il loro sostegno al black power ed espressero una dura condanna delle ipocrisie dell’America WASP attraverso un’immagine che divenne subito una delle icone più note del Novecento. I profili austeri degli atleti richiamavano il boicottaggio che il giovane Lewis Alcindor e altre stelle dello sport americano avevano costruito in vista della rassegna messicana: mentre il re dello sky-hook disertò l’appuntamento più importante dell’autunno, altri alfieri della spedizione a stelle e strisce cercarono di conquistare il palcoscenico più prestigioso per mandare un chiaro messaggio al mondo. L’orgogliosa azione “ribelle” costò a Smith e Carlos l’espulsione dai Giochi Olimpici e infiniti problemi agonistici nelle stagioni successive; il “contro-boicottaggio” che il sistema mise in atto nei loro confronti ricordò in parte i durissimi attacchi mediatici e giudiziari che Muhammad Alì dovette subire dopo la conversione all’Islam e il rifiuto della chiamata alle armi. Il pugile più ineffabile di tutti i tempi pagò con la galera un desiderio di pace e di affermazione della propria identità razziale che aveva cominciato a manifestare già nel 1960, quando aveva scagliato nel Mississippi la medaglia d’oro che aveva vinto alle Olimpiadi di Roma poiché non era stato servito in un buon ristorante del Deep South.
Negli anni più difficili della segregazione razziale e delle lotte per i diritti civili, anche Bill Russell e Oscar Robertson si adoperarono per migliorare le condizioni di vita degli afroamericani e per contrastare le ingiustizie del sistema sociale: la leggenda dei Boston Celtics rifiutò apertamente di giocare una partita amichevole a Lexington in onore di Frank Ramsey poiché gli organizzatori del match avevano imposto ai neri che indossavano le canotte col trifoglio di fare il check-in in un albergo riservato alla loro razza. Mentre gli stessi frangenti storici tormentavano gli Stati Uniti, il mago delle triple-doppie divenne uno dei fondatori e dei principali animatori dell’Associazione dei Giocatori; Robertson promosse diverse battaglie civili e sindacali affinché i diritti dei giocatori colored fossero identici a quelli dei loro colleghi bianchi. Questi illustri esempi trovarono un riflesso nelle straordinarie campagne di sensibilizzazione contro l’AIDS che Magic Johnson promosse dopo la scoperta della sua sieropositività, ma non nascondono il doloroso silenzio che Michael Jordan mantenne dopo la controversa uccisione del padre: His Airness decise di non mostrare il suo lutto sui palcoscenici delle battaglie contro la violenza e la diffusione delle armi da fuoco poiché trovò la forza di superare il vuoto soltanto nel nido privato della famiglia o – secondo i maligni – non volle esporre il suo marchio agli strali avvelenati della critica e ai pericoli delle polemiche settarie.
UN RISVEGLIO CIVILE?
Fra la notte del 6 e il mattino del 7 dicembre la t-shirt di Derrick Rose ha innescato un intreccio di elogi, sospetti, emulazioni e condanne senza precedenti; dopo il match contro i Golden State Warriors la stella dei Chicago Bulls ha evitato di rispondere alle domande dei giornalisti poiché era sconvolto dalla cattiva prestazione che aveva offerto al pubblico dello United Center e non si sentiva pronto a replicare alle sollecitazioni della stampa. Questo atteggiamento ha acceso i dubbi di una parte piuttosto rilevante delle penne della Windy City; la domanda si è diffusa in un baleno: Rose ha manifestato solidarietà a una famiglia che soffre per una delle più gravi contraddizioni socio-legislative della società statunitense, ma ha compiuto un gesto consapevole o un’ottima trovata per il difficile rilancio sul grande pubblico?
Derrick Rose takes stand wearing "I can't breathe" T-shirt in warm-ups http://t.co/Kp8o9yAOYk pic.twitter.com/JHxEKzRV7p
— Chicago Tribune (@chicagotribune) December 7, 2014
Mentre le colonne dei quotidiani online e cartacei mostrano sibillini sospetti, LeBron James riserva al pubblico dei social network la sua meraviglia ed esprime un profondo desiderio di indossare una maglietta identica a quella di Rose, la point-guard dei Brooklyn Nets Jarrett Jack fa preparare uno stock di t-shirts per la serata successiva e coinvolge il suo ex-compagno ai Cavs Kyrie Irving, che accetta con entusiasmo l’idea di riscaldarsi con il messaggio “I can’t breathe”. Alle prime luci dell’alba, gli organizzatori del movimento Justice for NYC capiscono che il match del Barclays Center fra Nets e Cavaliers può diventare uno straordinario veicolo di diffusione del loro messaggio e fanno stampare novanta magliette; i contatti con Jay-Z aprono la strada al dialogo con LeBron e infondono il desiderio della protesta anche negli animi di Deron Williams, Kevin Garnett e Alan Anderson, ma l’NBA comprende la massiccia portata del fenomeno “I can’t breathe” e si adopera per fermare i messaggi pubblici che rischiano di riempire le “ruote” di riscaldamento di parecchie arene. Le forze di sicurezza presidiano il Barclays Center, ma la rete di Justice for NYC riesce a far entrare le t-shirts e sfrutta il sostegno autonomo di Jarrett Jack; la discesa a Brooklyn di King James e dei rampolli britannici William e Kate si trasforma nel palcoscenico più prestigioso della protesta afroamericana e moltiplica i canali della sua diffusione. Nel derby californiano contro i Sacramento Kings, Kobe Bryant e i Los Angeles Lakers rinunciano alla sopramaglia ufficiale e si associano al grido icastico dei loro colleghi.
Kobe Bryant and the Lakers all wear “I Can’t Breathe” tees before tonight’s game http://t.co/cdkUdCpjVZ pic.twitter.com/r6a3O67eTR
— Bleacher Report (@BleacherReport) December 10, 2014
I CAN’T BREATHE. UN MESSAGGIO STRAORDINARIO E UN MODO CONTROVERSO: CHE FARE?
Nelle ore successive alla sfida fra i Bulls e i Warriors il Commissioner Adam Silver ha manifestato il suo rispetto nei confronti di Derrick Rose e degli atleti che esprimono le loro opinioni sulle principali questioni sociali, ma ha sottolineato il suo disagio al cospetto delle t-shirts “I can’t breathe”: il leader della Lega più famosa del mondo ha espresso il desiderio che gli atleti continuassero a servirsi dei capi d’abbigliamento ufficiali e non promuovessero messaggi sensibili sui campi attraverso i loro corpi e i loro indumenti. Anche se l’Olympic Tower non ha mai nascosto il suo impegno nei confronti della questione razziale e benché le inevitabili ipocrisie del big business abbiano trasformato le vicende di Donald Sterling e degli Atlanta Hawks in autentici lavacri mediatici gonfi di contraddizioni puritane, l’NBA ha visto nelle magliette delle sue stelle il subdolo pericolo legato alla diffusione di un’abitudine tribunizia contraria alla policy dell’organizzazione. Alcuni dilemmi hanno lacerato le coscienze dei massimi dirigenti del basket professionistico a stelle e strisce: cosa accadrebbe se altri atleti mostrassero messaggi capaci di veicolare idee palesemente contrarie alle campagne e allo spirito della Lega? Cosa succederebbe se gli sponsor multimilionari avessero incassato il colpo malvolentieri?
L’intervista che Derrick Rose ha rilasciato nei giorni successivi al match contro Golden State hanno chiarito la nobiltà delle sue intenzioni: “Sono cresciuto e ho visto queste cose ogni giorno. Non omicidi o cose del genere, ma ho visto la violenza tutti i giorni. Solo vedere quello che può succedere… Sto solo cercando di cambiare le idee dei ragazzi in tutta la nazione e quest’operazione comincia qui. Ora sono un genitore: probabilmente [prima di avere un figlio] non avrei indossato la maglietta. Ma ora che sono padre, ho cambiato la mia visione sulla vita”.
Anche le altre stelle che hanno sostenuto la campagna I can’t breathe hanno espresso il loro desiderio di incidere su una questione che trascende la politica e si estende alla piena realizzazione del progetto dei Founding Fathers, ma gli sforzi e le sensibilizzazioni non hanno ancora smesso di dividere l’America: mentre i followers e i supporters della protesta crescono fra la Rete e le comunità degli appassionati più attenti ai temi dell’attualità politico-giudiziaria, i dubbi dell’establishment continuano a manifestare la scottante centralità della lotta per i diritti civili.
La meravigliosa e struggente Changes di Tupac Shakur cancellerà dalla storia le speranze della risposta Black President di NaS?