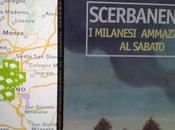Una spettatrice del Novecento della poesia. Giovanna Bemporad, Esercizi vecchi e nuovi, a cura di Andrea Cirolla, Milano, Edizioni Archivio Dedalus, 2010
Una spettatrice del Novecento della poesia. Giovanna Bemporad, Esercizi vecchi e nuovi, a cura di Andrea Cirolla, Milano, Edizioni Archivio Dedalus, 2010
_____________________________
di Giuseppe Panella*
Per molto tempo la figura di Giovanna Bemporad si è confusa con il ricordo di Gabriella Bemporad (che non era sua parente) anche se traduceva come lei dal tedesco – quest’ultima la conobbi, sia pure fuggevolmente, a casa di Gianfranco Draghi, in una villa appena fuori Firenze dove credo che questo singolare personaggio di psicoteraupeta di impronta junghiana, poeta, scrittore, pittore e altro ancora viva a tutt’oggi. Anche lei parlava di Rilke e di letteratura tedesca del Novecento con una voce sottile ma vibrata, ricca di accenti densi e dolci di nostalgia.
Giovanna Bemporad, invece, è stata soprattutto una traduttrice di testi del legato classico, soprattutto greco e soprattutto dell’ Odissea, opera di traduzione che è durata praticamente tutta la sua vita matura. Ma, tra una traduzione di Omero e una di Rilke o di Hofmannsthal o di Goethe o di Novalis, la Bemporad è stata soprattutto poetessa molto raffinata nei tocchi, nei toni, nelle soluzioni ritmiche e formali.
Esercizi vecchi e nuovi è un libro del 1948 (pubblicato dagli editori veneziani Urbani e Pettenello) che fu ristampato poi nel 1980 da Garzanti per le cure di Giacinto Spagnoletti – grazie a questa ristampata, il volume vinse premi prestigiosi (il Vallombrosa, lo Stresa e l’Elea) e rilanciò il nome dell’autrice nel mondo della letteratura militante.
A leggerlo oggi fa una strana impressione et pour cause. Nelle Testimonianze riportate in fondo al volume, agilmente ristampato e annotato da Andrea Cirolla, spicca una recensione di Pier Paolo Pasolini per il “Mattino del popolo” del 12 settembre 1948 (un giornale friulano cui Pasolini collaborerà fino allo “scandalo di Ramuscello” del 1949) in cui si può notare questa dichiarazione di una certa rilevanza (l’amicizia con la poetessa risaliva ai tempi di Bologna e del Liceo “Galvani” e fu rafforzata dal soggiorno a Casarsa negli anni più bui della guerra):
«Ma, a parte un’infinità di osservazioni particolari dovute proprio al “mestiere” di questo poeta, resta da notare un dato essenziale, che è in fondo la ragione del libro; voglio dire che ci troviamo di fronte a una poesia “diretta”, che aggredisce i suoi argomenti nominandoli: si pensi a quante volte è nominata la “morte”. Tale atteggiamento diretto (cioè, fra l’altro, molto ambizioso) vuole dare al libro il tono della poesia “maggiore” affrontando i compartimenti stagni del tradizionalismo con molto coraggio e quasi con imprudenza. Ne consegue che i critici si trovano disorientati di fronte a tanto manifesto disprezzo per certo tono “minore”, per certo “gusto” dei limiti, per certa impeccabilità in cui si circoscrive e generalizza il “caso” umano, elementi che identificano molta parte (e la migliore, perché no?) della poesia contemporanea italiana; così i critici tacciono. Io, amico, non critico, della Bemporad, ho cercato di avviare un discorso: ma quante cose mi resterebbero ancora da dire su di lei!» (p. 201) (questo articolo di Pasolini è stato poi raccolto da Laura Betti per l’Associazione “Fondo Pier Paolo Paisolini” in Il portico della morte, Milano, Garzanti, 1988).
E’ proprio questo, invece, che lascia perplessi i critici di oggi, magari: dov’è questa natura “diretta” dei testi poetici della Bemporad? Sicuramente l’innovazione linguistica e la direzionalità della scrittura c’è e non si può negare – andrebbe semmai verificata nell’ottica delle modificazioni intervenute nell’edizione 1980 rispetto a quella del 1948 ma questo non è significativo rispetto al corpo grosso dell’opera riedita. Ma forse quell’annotazione del poeta friulano ha senso rispetto alla tradizione contro la quale la poesia della Bemporad andava a cozzare in rotta di collisione. Oggi la poesia della traduttrice ferrarese appare più che “diretta”, capace di suscitare emozioni e senso proprio per la natura obliqua, sedimentata, ri-diretta verso un bersaglio interiore che si vuole cogliere a tutti i costi. Si veda una poesia come Preludio che apre la raccolta e il cui tono accompagnerà tutte le liriche della prima parte della raccolta:
«Per mille e mille autunni sia guanciale / la terra alle mie palpebre socchiuse / non più gravate da un presagio d’ombra; // né la mia bocca smorta, disfiorata / e agli angoli cadente, già sforzata / da spasimi e sorrisi, sembri assorta // nel sepolcro in preludi di orazioni; / e non sul plinto immortalmente vegli / la mia maschera, chiusa in un cristallo» (p. 19).
La morte compare come punto di riferimento esistenziale, certamente, ma è metafora classica ad indicare l’oppressione della vita cui si vuole sfuggire e la scelta di un oltre cui non ci si può sottrarre. In sostanza, la morte cui si fa riferimento è velo poetico della vita e l’adombrarla non basta ad evocarla se non come simbolizzazione in atto di una proposta di vita dove la poesia è ben più forte di una possibile e presunta fine auspicata. Ne è conferma una poesia intimamente “classica” (e non solo classicistica) come questa:
«Vorrei gettare ciecamente al nulla / la mia stanchezza, come fosse pietra / che precipita in fondo all’acqua buia. / Ma la pace che aleggia sugli erbosi / campi assolati in cui non odo insulto / dell’uomo, solo un canto di cicale / monotono assordante, fa che al male / che già sembrava estremo io sopravviva; / giunta al suo colmo, l’intima oppressione / si converte in sopore e cede all’afa / che il mio pensiero dominante annulla / nel sonno non dissimile alla morte» (p. 39).
La consapevolezza dell’esistenza del Male è sopita, quasi soffocata, dal calore di un’insopportabile estate calda – il sonno, “non dissimile alla morte”, farà il resto permettendo alla volontà di vivere di sopprimere o far decantare il desiderio di annientamento totale. La Morte, il Male, il Dolore di vivere qui evocati, tuttavia, non sono figurazioni allegoriche o simboli estenuati della tradizione lirica ma emozioni latenti, poi proiettate sulla pagina, a indicare un percorso o un progetto di decantazione della vita, “sogno dentro sogno”. Lo stesso vale per un’altra poesia sine titulo che segue e che documenta lo stesso procedimento di scioglimento esistenziale entro la fineinvocata ma non certo voluta o raggiunta:
«Ch’io muoia all’esaurirsi delle risa / quando più non sopporto una stanchezza / già scontata all’estremo; e sia d’autunno / mentre l’orecchio intendo estesamente / per la quiete, e soffochi il mio canto / una foglia che cade, o sia d’estate / quando tra rose rosse e gelsomini / ferve la guerra. Già da tempo estranea / a questa sinfonia d’estati e inverni, / non entrerò nei pallidi domini / con purpurei tumulti dentro il cuore; / e al commento inesausto degli insetti / tra l’erba, al loro giubilo sonoro / che indietro mi richiama, io sarò sorda» (p. 59).
Il tema della stanchezza, dunque, predomina e della necessità della sua estraneazione al mondo la poetessa si dice pur sempre consapevole – eppure un’attenzione notevole alle forme mutevoli e spesso stupende del mondo la attira comunque pur dicendosene lontana e “sorda” alla dimensione fattiva e più intensa delle vicende della vita. In sostanza, la poesia di Giovanna Bemporad si attiva a livello di descrizione della realtà che vede e che la agisce salvo poi allontanarsene insoddisfatta e dolente, incapace di vivere in un mondo che la rende melanconica e mesta. Il lento e progressivo succedersi delle stagioni la coglie egualmente proclive al rifiuto della partecipazione ed è in questa sua situazione di spettatrice che risuona più alacre la sua corda lirica più efficace. Questo accade non soltanto negli anni bui e difficilissimi del primo dopoguerra ma anche in testi “degli anni tardi” come questo in cui i temi sembrano gli stessi ma sono maggiormente rastremati su una tavolozza di toni più sensibili al richiamo del canto:
«L’anima mia che ha tristezze d’aurora / e di tramonto, e il gusto della morte, / non più tenuta viva da illusioni / piange sommessa al clamoroso mare / come un fanciullo triste, abbandonato / senza difesa a tutti i suoi terrori. / Ma quando il sole un riso di rubini / mi semina tra i solchi della fronte, / spiegano i sogni un volo di gabbiani! / Persa in un mondo di gocce d’azzurro / e di freschezza verde, annego in questo / mare più dolce dell’oblio l’angoscia / cupa degli anni tardi, in cui presento, / rammaricando, che il mio tempo è morto» (p. 181).
Dove, a prescindere dall’evidente lezione di Cardarelli, il taglio è più ampio, più aperto al sogno e al desiderio, quasi correzione interiore di un desiderio di morte che si è fatta angoscia e stupore doloroso senza però perdere il suo slancio verso la bellezza sempre incessante della realtà vitale.
___________________________
*Il titolo di questa rassegna deriva direttamente da quello di un grande romanzo (Quel che resta del giorno) di uno scrittore giapponese che vive in Inghilterra, Kazuo Ishiguro. Come si legge in questo poderoso testo narrativo, quel che conta è potere e volere tornare ad apprezzare quel che resta di qualcosa che è ormai passato. Se il Novecento italiano, nonostante prove pregevoli e spesso straordinarie, è stato sostanzialmente il secolo della poesia, oggi di quella grande stagione inaugurata dall’ermetismo (e proseguita con il neorealismo e l’impegno sociale e poi con la riscoperta del quotidiano e ancora con la “parola innamorata” via e via nel corso degli anni, tra avanguardie le più varie e altrettanto variegate restaurazioni) non resta più molto. Ma ci sono indubbiamente ancora tanti poeti da leggere e di cui rendere conto (senza trascurare un buon numero di scrittori di poesia “dimenticati” che meritano di essere riportati alla memoria di chi potrebbe ancora trovare diletto e interesse nel leggerli). Rendere conto di qualcuno di essi potrà servire a capire che cosa resta della poesia oggi e che valore si può attribuire al suo tentativo di resistere e perseverare nel tempo (invece che scomparire)… (G.P.)