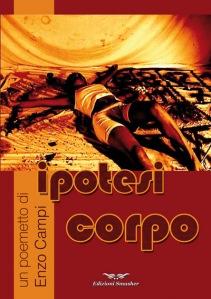 Dispendio e godimento – un’ipotesi di poesia. Enzo Campi, Ipotesi corpo, con un’ Introduzione di Natàlia Castaldi, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Edizioni Smasher, 2010
Dispendio e godimento – un’ipotesi di poesia. Enzo Campi, Ipotesi corpo, con un’ Introduzione di Natàlia Castaldi, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Edizioni Smasher, 2010
_____________________________
di Giuseppe Panella*
Scrive Natàlia Castaldi nel suo Posizioni (tracce e cancellazioni di un corpo in opera), l’efficace testo critico che fa da Introduzione al poemetto lirico di Enzo Campi:
«Il corpo è qui tema dell’indagine e palcoscenico in cui l’io mette in opera un monologo questionante che – poematicamente e teatralmente – si incarna nel corpo del testo e della parola cercando di risolvere (dissolvere?) l’unicità di senso di un doppio movimento che oscilla incessantemente tra il dispendio (come ragione di vita) e il ricominciamento (come unica possibilità di proiezione verso l’ a venire). Ciò avviene attraverso la scissione drammatizzata tra forze centripete (pulsione, desiderio, istinto-carne) e forze centrifughe (ragione, indagine e ricerca-alterità» (p. 8).
Seguendo le indicazioni di Georges Bataille presenti in La parte maledetta e sviluppandole in senso materialistico, di conseguenza, il poemetto di Campi si presenta come una forma non limitabile di rappresentazione del corpo come vicenda personale e come sviluppo universale, come forma che fluisce senza fine e come modulazione dei suoi momenti sensibili e limitati, come la Gestalt della vita dei singoli e come un flusso generale di desideri e di contraddizioni che va verso la sua fusione con il mondo esterno. Come continua a scrivere la Castaldi, infatti:
«La drammaticità si concretizza nella reazione poetica scrivendo e riscrivendo il linguaggio nel corpo, ricercando il senso non solo nel significato oggettivo della parola ma, anche e soprattutto, nel connubio tra phoné e significante, in quell’incontro-scontro che restituisce al corpo (suo e del lettore) le disattese potenzialità che l’oralità ha in senso originario, in un gioco al massacro che, colpendo direttamente i sensi, traccia una mappa percettiva di significati e gesti attraverso i quali l’io si riscopre e si espone nelle verità più impietose e intime di una carne che non può esimersi di mettersi “in opera”» (p. 12).
L’io non come altro dal corpo ma quale sua intrinseca funzione proiettiva è la posta in gioco del poemetto di Campi – la sua capacità di dirsi con parole e significarsi come realtà va al di là del suo stesso modo di mettersi in attesa di essere chiamato a concorrere alla propria conoscenza. La sua peculiare forma di scrittura poetica viene costruita attraverso il tentativo di produrre un alternarsi spiazzante e continuo di significanti in concorrenza reciproca che, a forza di rimbalzare l’uno sull’altro e contro se stessi, si articolano in arcate significative di senso.
Nato sotto il nume tutelare, filosofico e sapienziale, di Antonin Artaud (“E dicevo in mezzo al vuoto, / vuoto delle sette eternità: / l’io non è il corpo, / è il corpo all’essere l’io”), il testo poetico di Campi si propone di cantare in maniera coerente e onirica al tempo stesso, articolandosi in un flusso di parole lucidamente strutturate in lasse liriche, le possibili epifanie di un corpo che si rinnova e di ritrova ogni volta sempre uguale e diverso.
«io corpo dunque / carne a carne / s’infervora e fluisce / scorrendo / appena aprendo / e aprendosi / succhiando la linfa alla falda / che salda / l’umido al fluido / in un solo gesto d’amore / senza variabili / che ne condizionano il transito // solo / una figura / sfigurata / ad altro / che non è / diverso / da questo // io corpo solo pelle / non ride s’irride / stordito dalla rotazione / caracolla si manca / e inforca nuovamente il palo / nel bel mezzo di un centro / sempre da verificare / osannare slabbrare // perché senso se non amore al sesso / che qui gioisce e urla / rifiutando l’encomio / del nome proprio / da sempre e per sempre inappropriato?» (pp. 48-49)..
Lo sviluppo impetuoso e il rincorrersi apparentemente insensato dei significanti diventa nel corso della fuga in avanti del senso alla ricerca di significati che li ricompattino una sorta di auto-costruzione frenetica dei suoi principi fondanti: il fluido e il desiderio che evolvono a partire dalla forza del desiderio che apre la carne e la rende vulnerabile al piacere e poi l’amore che si rapprende nel sesso e va oltre di esso nella sua corsa verso la conoscenza della propria identità.
La capacità della carne di saldarsi ad altra carne trasforma il corpo in qualcosa che va al di là di se stesso, alla ricerca di un io che non sia solo se stesso ma capacità di comunicazione con l’altro da sé in nome di una ragione superiore dell’esistenza: il sesso e l’amore come unica ragione produttiva di essa. Come l’autore stesso prospetta verso il finale del poemetto:
«io corpo certo / mi vedo propinquare / l’indegno senno / al seno e al sesso / e sono d’un tratto gettato / a tanto a tanto / troppo poco cosa / e ancor mi dico / e mi muoio / ridisegnando l’ellisse / del sono suonato / percosso percorso / di tondo in tondo / senza più mai differire / nell’altro / che fu che è che sarà / questo beffardo poco / dell’intricato seme / in tra le faglie colato a iosa / nella rosa in posa / come intrigo / e trama e ordito / della cornice / in cui inscrivere / il corpo sì mio / ma in vero estraneo / e che ancora reitera / in vero e in falso / la solita copula / e la solita domanda // cos’è che tanto e poco ancor rinviene / nei petali inumiditi estromessi dal velluto? » (pp. 54-55).
La logica del corpo qui viene a coincidere con quella della poesia in un tentativo di rispondere alla domanda di sempre: perché l’io come sostanza del corpo e perché il mio corpo come stagione sempre esitante dell’io, in bilico tra vita e morte, tra salvezza e destino, tra desiderio ed estinzione della sua fiamma? Domanda ondivaga ma essenziale cui il corpo non risponde se non “in forma di parole” (Dante) e di proiezione crepitante di un sogno che non si arresta nemmeno ai confini del territorio di carne che lo contiene.
Il corpo come sostanza dell’io si configura, allora, come il luogo designato all’esplosione del desiderio e alla sua trasformazione in promessa di felicità.
_____________________________
*Il titolo di questa rassegna deriva direttamente da quello di un grande romanzo (Quel che resta del giorno) di uno scrittore giapponese che vive in Inghilterra, Kazuo Ishiguro. Come si legge in questo poderoso testo narrativo, quel che conta è potere e volere tornare ad apprezzare quel che resta di qualcosa che è ormai passato. Se il Novecento italiano, nonostante prove pregevoli e spesso straordinarie, è stato sostanzialmente il secolo della poesia, oggi di quella grande stagione inaugurata dall’ermetismo (e proseguita con il neorealismo e l’impegno sociale e poi con la riscoperta del quotidiano e ancora con la “parola innamorata” via e via nel corso degli anni, tra avanguardie le più varie e altrettanto variegate restaurazioni) non resta più molto. Ma ci sono indubbiamente ancora tanti poeti da leggere e di cui rendere conto (senza trascurare un buon numero di scrittori di poesia “dimenticati” che meritano di essere riportati alla memoria di chi potrebbe ancora trovare diletto e interesse nel leggerli). Rendere conto di qualcuno di essi potrà servire a capire che cosa resta della poesia oggi e che valore si può attribuire al suo tentativo di resistere e perseverare nel tempo (invece che scomparire)… (G.P.)




