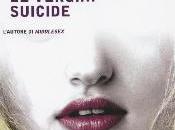Metteteci pure un toppino, ma quelle di Demetrio Stratos e di Flavio Paulin sono state le voci che più di ogni altra hanno segnato la musica pop italiana degli anni Settanta, o meglio che più hanno turbato e scosso l’immaginario musicale popolare di quegli anni dai due lati opposti della musica di ricerca e della canzone di facile ascolto. È curioso constatare come i due outsider della canzone italiana, pur nella loro assoluta e totale distanza estetica e culturale, siano accomunati da alcuni tratti significativi. La carriera parallela, innanzitutto: la parabola creativa degli Area e dei Cugini di Campagna si svolge infatti nel medesimo arco temporale, tra il 1973 e il 1978. In quell’anno sia Stratos che Paulin lasciarono i rispettivi gruppi per seguire carriere solistiche: il primo nell’ambito della sperimentazione vocale, il secondo in quello del pop elettronico. Altro tratto comune, l’unicità e l’originalità del ruolo e della posizione assunta dai due gruppi nei rispettivi generi di appartenenza: come gli Area si distinguono nettamente dagli altri gruppi progressive italiani (Orme, Banco, Premiata Forneria Marconi), in virtù di una ben più pronunciata radicalità nelle scelte stilistiche, così i Cugini di Campagna, in perfetta simmetria, si distinguono dai gruppi soft pop allora più in voga (Camaleonti, Pooh, Alunni del sole) per la particolare attenzione rivolta a un certo tipo di immaginario femminile pre-adolescenziale e puberale, che a mio avviso hanno saputo interpretare ed esprimere meglio di chiunque altro.
Ma c’è un terzo, fondamentale tratto che li ‘accomuna’: e cioè la forza perturbante e destabilizzante di quelle due voci uniche, l’una – se si vuole – il rovescio della medaglia dell’altra. Com’è noto e inconfutabile, infatti, nessun cantante italiano (e ben pochi altri a livello mondiale) ha spinto la propria voce oltre quei limiti superati da Stratos dopo anni di studio, di pratica e di paziente ricerca. La potenza fonatoria, il controllo sulle emissioni polifoniche (le famose ‘diplofonie’ e ‘triplofonie’); lo sconfinamento dell’estensione naturale della voce umana (sia nell’acuto che – cosa ben più sorprendente – nel grave: si ascolti in proposito Passaggi 1,2 da Cantare la voce); l’ampliamento delle possibilità tecniche della voce attraverso il canto ‘introiettato’ (Criptomelodie infantili), lo scioglilingua continuo a velocità impossibili (O tzitziras o mitziras), l’imitazione sbalorditiva degli strumenti musicali (Flautofonie ed altro); il particolarissimo timbro (un misto tra il grido e il lamento) usato nella melodie più ‘regolari’ degli Area ma già presente nei Pugni chiusi dei Ribelli – tutto ciò ha fatto di Stratos e della sua voce una presenza inquietante e irriducibile nel panorama canoro degli anni Settanta.
E Paulin? Che dire del più celebre falsetto pop italiano? Intanto che era diverso da tutti gli altri. La voce maschile in falsetto non era certo una novità nella musica pop, italiana e soprattutto internazionale, dell’epoca: da Robert Plant a Ian Gillan, da Jon Anderson a Barry Gibb (il più inarrivabile e tecnicamente perfetto) fino al nostro Nico di Palo: ne abbiamo avuti tanti di falsetti, ognuno con le proprie peculiarità tecniche e stilistiche. Ma quello di Paulin è unico. Sarà per il contesto che gli fa da sfondo (l’immaginario adolescenziale femminile della provincia italiana degli anni Settanta), sarà per le sue caratteristiche anatomiche (sarebbe interessante approfondire la questione, ma io non ho certo le competenze per farlo) – fatto sta che quella voce colpiva e turbava più di ogni altra. Voglio dire: mentre quello di un Plant o di un Gillan è un falsetto perfettamente consono all’estetica di certo Hard Rock – di cui gli Zeppelin e i Deep Purple sono stati notoriamente i padri – quello di Paulin precipita come una meteora dall’alto nell’ambito della canzone italiana (soprattutto di quel tipo di canzone, né sperimentale né engagé). Similmente, se quello di Anderson o di Gibb aderiva alla più o meno presunta ‘purezza’ stilistica della musica, pur così diversa, degli Yes e dei Bee Gees (una musica ‘pura’ nella misura della sua tendenziale autoreferenzialità), quello di Paulin restava sospeso in un’ambiguità perturbante. Semplicemente perché, così almeno io credo, al di là della questione banale e scontata dell’androginia, che pur all’epoca turbava di per sé il costume italiano, quella voce non si sapeva da dove provenisse, chi la articolasse e in che rapporto stesse con il contesto a cui apparteneva. Era cioè in tutti i sensi una voce ‘out’: sospesa, spettrale, irrealistica eppure così avvincente. Perfino l’interpretazione ‘angelica’ – peraltro ben radicata nel profondo legame che lega la musica dei Cugini di Campagna da un lato alla Cappella Sistina e dall’altro alla parrocchia della periferia romana – non riuscì a risolverne l’enigmaticità: perché mai, d’altronde, dovrebbe essere proprio un angelo a sondare gli abissi dell’inconscio di una dodicenne del casertano? Quella voce si trovava così allo stesso tempo ad aderire al contesto (grazie alla fortissima seduzione che esercitava sulle adolescenti) e a restarne fuori, avvolta nel più impenetrabile mistero. Un altro mistero italiano, potremmo dire, senza alcuna sfumatura di allusione a crimini o misfatti ma semmai ai tanti ‘misteri estetici’ italiani, non meno interessanti, che ancora attendono di essere indagati. Prendiamo Preghiera, una delle canzoni più note dei Cugini di Campagna. Il testo parla di un tragico fatto di cronaca: il suicidio di un ragazzino seguito alla morte della fidanzata gravemente ammalata. Ebbene: se il testo della canzone è tutto in prima persona (“E le mie mani innalzerò verso di te”, “Signore mio, ascoltami se puoi”, etc.) non è certo il ragazzino che canta. Chi è, allora? Un suo portavoce (come in ogni altra situazione simile nella canzone italiana)? No. La ‘voce’ del giornale, come in certo crudo stile cronachistico proprio della canzone ‘impegnata’ dei cantastorie? Men che mai. E allora? Chi è che parla?
Non si sa. È Paulin. L’altra voce. La voce dell’altro. Una delle due facce del Giano bifronte, lo Stratopaulin, l’inconscio vocale dell’italiano medio.