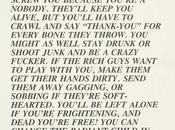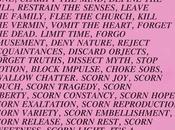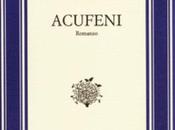Uomini contro, di Francesco Rosi (sceneggiatura di Tonino Guerra, Francesco Rosi e Raffaele La Capria), Italia/Jugoslavia 1970, 97′.
 Uomini Contro è un film “di chiara impronta pacifista e antiautoritaria”, o almeno così lo definisce Wikipedia.
Uomini Contro è un film “di chiara impronta pacifista e antiautoritaria”, o almeno così lo definisce Wikipedia.
Però a me ha sempre colpito un fatto. Tra tutti i personaggi che popolano il film, quello che mi affascina maggiormente è quello che, secondo un’interpretazione pacifista e antiautoritaria, dovrebbe risaltare solo in quanto villain supremo.
Tra le trincee e le pietraie spettrali, che una fotografia genialmente plumbea rende quinte di un vero incubo, tra nebbie perenni e rari raggi di sole anemico, si muovono tutta una serie di uomini contro. Il giovane sottotenente Sassu (che sarebbe Emilio Lussu, autore del libro dal quale è tratta la pellicola), entusiasta della guerra finché non si trova in mezzo ai suoi orrori. Il tenente Ottolenghi (un milanesissimo Gian Maria Volonté), ufficiale e socialista, che parla ai suoi soldati-contadini di rivoluzione e finirà falciato da una mitragliatrice italiana. I tanti fanti che cercano scampo dal tritacarne della guerra e dalle fucilazioni attraverso le ferite autoinflitte, la diserzione, la fuga. Anche il “nemico” è contro questa guerra da pazzi: di fronte all’ennesimo massacro di soldati in grigioverde, dalle trincee austriache si alza l’urlo «Basta italiani, basta morire così!»
Poi c’è lui: il generale Leone. E ci sono io che mi chiedo perché il “supercattivo”, quello che ordina gli attacchi e le decimazioni, in fondo sia il personaggio che mi colpisce di più. Ma soprattutto perché, di fatto, io non trovi odioso, non riesca a vedere come villain il generale dalla mascella squadrata e dallo sguardo inespressivo.

Gen. Leone (Cluny) e ten. Ottolenghi (Volonté) in una scena di Uomini contro
Forse perché anche il generale Leone (cui presta il volto un gigantesco Alain Cluny) è un uomo contro. Contro il Tempo: quello, con la maiuscola, che sta per archiviare il suo mondo.
Quando la sua divisione si ritira, lui è lì in mezzo ai suoi soldati, a correre per salvare la pelle. Quando si marcia, lui non va in auto, caracolla a lato della colonna in groppa ad un muletto. Il suo comando ha sede in una villa gentilizia, ma nella sala dove sta lui non c’è nulla se non una scrivania. Leone va in trincea e si espone ai cecchini, dice ad un soldato di fare come lui, e quando quello viene abbattuto da una fucilata gli appoggia una moneta sul petto insanguinato e gli dice di usarla per farsi un cicchetto. Leone appare a noi oggi ridicolo e crudele, in questa e in altre scene del film; ma forse ci dimentichiamo che prima del soldato, ai cecchini, si era esposto lui. Perché è il modo che conosce per avvicinare i suoi uomini a sé, mostrare loro il proprio coraggio. È il modo che gli hanno insegnato generazioni di generali e anni di scuole militari. Leone non sembra lo scintillante prototipo del fascismo che verrà, quanto un relitto della modernità. È una figura autoritaria, crudele, ma ha una sua grandezza (come riconobbe lo stesso Rosi, poco dopo l’uscita del film). È l’incarnazione dell’autorità, certo, ma di un modello di autorità che ha gli anni (se non i mesi) contati, l’onda del baracconismo fascista è dietro l’angolo. È l’incarnazione dell’autorità, ma non è l’autorità. Tiene nel cassetto della scrivania la foto dei suoi figli, e ordina alle mitragliatrici di aprire il fuoco sui soldati che arretrano. Ma non è il male.
È, anche lui, un uomo.