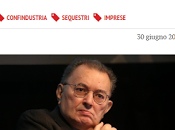In questi giorni sto leggendo una raccolta, appena pubblicata, di alcuni dei più significativi discorsi pronunciati da Adriano Olivetti, splendida e isolata anomalia italiana.
Di quest’industriale atipico, luminoso esempio d’ingegnere umanista (figura assai poco diffusa, in una società in cui si fa fatica a capire che la cultura, se è davvero tale, non è “scientifica” o “umanista”, ma semplicemente “cultura”), mi è sempre piaciuta l’idea secondo la quale scienza e cultura sono ricerca disinteressata della verità, così come l’idea secondo la quale il più alto fine che un’industria deve porsi come obiettivo non è quello rappresentato dal successo del proprio nome e del prodotto del proprio lavoro ma quello di contribuire attivamente al progresso – economico e sociale – della comunità nella quale opera.
Suo padre, Camillo, nel 1908 aveva fondato a Ivrea la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere ma fu lui, Adriano, il maggiore dei figli maschi, a fare dell’Olivetti qualcosa che in Italia non s’era mai visto prima e che non si sarebbe più visto dopo.
Quello che Adriano Olivetti ha realizzato in questo Paese a metà del secolo scorso (negli anni che vanno dall’immediato dopoguerra ai primi anni sessanta) rappresenta la realizzazione di un sogno, la concretizzazione dell’idea di una nuova idea di società, la realizzazione del modello di una nuova idea di fabbrica, vista come “un bene comune e non un interesse privato“, pensata affinché “la bellezza fosse di conforto nel lavoro di ogni giorno“.
In un suo discorso, rivolto ai lavoratori di Ivrea nel giugno 1945, pronunciò queste profonde parole: “Cosa faremo, cosa faremo? Tutto si riassume in un solo pensiero, in un solo insegnamento: saremo condotti da valori spirituali. Questi sono valori eterni, seguendo questi i beni materiali sorgeranno da sé senza che noi li ricerchiamo“.
Adriano Olivetti puntava a valorizzare l’intelligenza, a far crescere il sapere, non il lavoro (che segue, non precede, il sapere) e questo non poteva essere accettato in un sistema chiuso, reazionario, come quello che caratterizza la società di questo Paese, che teme come la peste il sapere, l’intelligenza, l’intraprendenza.
Il sapere, infatti, non è controllabile come il lavoro, specialmente se questo è organizzato secondo sistemi tradizionali, collaudati.
Non a caso Adriano Olivetti fu osteggiato tanto dai sindacati quanto dal Partito Comunista Italiano che, in quanto classici mediatori, preferivano al modello aperto, orizzontale, d’Ivrea quello tradizionale, verticale, della Fiat di Torino, città poco distante (in termini di chilometri) da Ivrea ma da questa lontanissima anni luce in termini di sistemi di relazione tra lavoratori e proprietà e tra fabbrica e territorio.
E non era certamente casuale il fatto che i dipendenti dell’Olivetti stessero decisamente meglio di quelli Fiat e questo, si badi bene, anche dal punto di vista economico.
Leggendo i discorsi di Adriano Olivetti, profondo umanista e pure (forse proprio per questo) tra i migliori imprenditori al mondo negli anni cinquanta, mi sono venute in mente queste parole di Joseph Roth: “Un uomo che non ha mai visto una fabbrica in vita sua e ha studiato Platone può affrontare e considerare la vita in modo mille volte più pratico”.
Il fatto che quando si parla dell’Olivetti di Adriano Olivetti non si parli semplicemente di un’idea, di un progetto, di un sogno, ma di una concreta realtà, di qualcosa che è esistito per davvero (tanti anni fa, per lavoro, ho avuto modo di vederne dal vivo gli uffici di Ivrea), è la dimostrazione che in questo Paese un mondo migliore sarebbe stato possibile.